LIBRO DI CARLO VOLPARA - CAPITOLI
A STAMPINO C'ERA IL CONTE
STORIA E STORIE DI FAMIGLIA DEL NOVECENTO ANDORESE
di
CARLO VOLPARA
PREFAZIONE

La contessa Tina e il conte Quaglia
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora
Rielaborazione a colori - Mario Vassallo
Il proposito di realizzare un libro sull’armatore Giovanni Quaglia non è stato una decisione facile ed ancor meno presa d’impulso, ma è il prodotto di lunghi anni di riflessioni e considerazioni personali. Sono arrivato a questa conclusione in seguito ad una valutazione critica di fatti e persone, senza dare nulla per scontato o per assunto come mi hanno insegnato i miei ormai lontani, ma sempre validi, studi liceali.
Se a questi fattori aggiungiamo che ho sempre posseduto un’altrettanto grande passione per la storia, intesa sia in senso generale che più ristretto a livello locale, arrivo al punto che tanto mi sta a cuore e che mi ha spinto a scrivere questo libro su Giovanni Quaglia. Molto probabilmente alla maggioranza della popolazione contemporanea questo nome dirà poco o nulla addirittura, ma negli anni trenta del secolo scorso fece il giro del mondo alla stessa stregua di quello dei potenti di turno, oppure dei divi del cinema.
E’ strano davvero che una persona di tale grandezza imprenditoriale ed umana non abbia mantenuto nel corso del tempo memoria e riconoscimento adeguati da parte delle autorità e dei media nazionali ed a livello locale abbia rischiato, se non proprio l’oblio, quanto meno di cadere nell’anticamera del dimenticatoio. Non un francobollo celebrativo, non una manifestazione commemorativa seria in occasione di un anniversario a cifra tonda. Nemmeno gli organi di informazione liguri si sono mai sprecati in occasione delle ricorrenze che riguardassero tanto lui personalmente, quanto le sue imprese. Al massimo solo qualche piccola manifestazione a livello ultralocale o qualche trafiletto sui giornali.
A Viareggio, patria indiscussa di impareggiabili, per certi versi eroici palombari, già da parecchi anni hanno realizzato una fondazione denominata “Artiglio Europa” con tanto di premio da attribuirsi a chi a livello internazionale si è distinto nell’opera di esplorazione sottomarina.
Sempre a Viareggio hanno inoltre realizzato un museo della marineria intitolato ad Alberto Gianni, mitico maestro della palombaria italiana e mondiale.
Tutto ciò va ad onore dei viareggini e di tutti coloro che non vogliono che la memoria collettiva si perda, anche se costoro hanno voluto campanilisticamente ricordare i soli meriti dei propri conterranei dimenticandosi un po’ chi contribuì in maniera decisiva a rendere così grandi ed imperituri quei palombari stessi.
Ma in Liguria abbiamo saputo fare altrettanto con il più grande armatore-recuperatore sottomarino di tutti i tempi che tanto onore e gloria seppe conferire all’Italia nel mondo?
Purtroppo, e lo dico con una punta di rammarico, non mi risulta altrettanto né a Genova, né nel ponente ligure più in generale, considerando che costui fu tanto nativo di Diano Castello, quanto risiedette per quasi tutta la vita a Genova, città dove ebbero sede le sue società.
Forse questo atteggiamento può essere imputato al tradizionale pudore ed al carattere schivo ed elusivo della gente ligure, la quale notoriamente tende a fuggire dai riflettori delle scene e raramente ha il coraggio di tributare i dovuti onori a chi della propria gente ha dimostrato veramente di meritarlo.
Per motivare questa patina di oblio potrebbe essere anche chiamata in causa l’altrettanto arcinota ingratitudine dell’Italia matrigna che non sa essere riconoscente verso i propri figli migliori, proprio quelli che le sanno conferire vanto e prestigio a livello mondiale.
Inoltre, non avendo egli lasciato eredi, si è perso il filo conduttore generazionale familiare ed anche questo fattore potrebbe aver inciso in maniera negativa sulla memoria collettiva alla pari del fatto che la sua flotta recuperi, essendo stata prettamente una sua creatura, commercialmente parlando, morì anch’essa appena dopo la sua morte.
Comunque al di là di queste potenziali attenuanti, penso che il mondo dell’informazione e della storiografia italiana, che non ha esitato a conferire il giusto tributo nei confronti di altri personaggi, magari neppure italiani, sia ancora fortemente in debito nei confronti di questa persona che molto ha dato sia in termini di prestigio, che in termini umani.
Anche il mondo della televisione e del cinema, sempre alla caccia di fatti e personaggi a cui attingere per le proprie produzioni, non si sa come abbia potuto trascurare, se non proprio dimenticare, fatti di cronaca così epicamente appassionanti realizzati da un uomo che gli anglosassoni non avevano esitato a definire “attractive”, dove il termine attractive sta si per attraente ma significa anche interessante ed appassionante.
Oggi molti giovani ed anche meno giovani, liguri e non, poco o nulla sanno degli avvenimenti che videro protagonista l’Avvocato Giovanni Quaglia, il quale con le imprese dei propri marittimi e dei propri palombari seppe stupire il mondo intero, marinaresco e non, ricevendone in cambio un prestigio ed un’ammirazione profonda e sincera al punto che, per anni all’estero, risultò essere l’italiano più famoso e rispettato di chiunque altro nostro connazionale.
Ora sembra che qualcosa finalmente stia muovendosi anche da noi, poiché il nuovo Museo Navale di Imperia ha riservato un ampio spazio dedicato proprio alla società dell’armatore castellotto, dove si possono ammirare reperti originali appartenuti alla sua flotta nonché attrezzature varie atte al lavoro di recupero sottomarino.
Speriamo quindi, che tra non molto si possa rendere il giusto onore, storicamente parlando, ad un grande della nostra terra che ha saputo rinnovare in epoca moderna ed in maniera sui generis i fasti dei grandi uomini di mare liguri.
L’Avvocato Quaglia non è stato certamente andorese di nascita, ma la sua quarantennale presenza sul nostro territorio, avendo risieduto nella villa di Stampino, seppur non in maniera continua, è stata comunque più che importante, per non dire influente, sia a livello economico lavorativo che storico sociale e proprio per questi motivi gli può ben valere la cittadinanza onoraria.

Il Conte Giovanni Quaglia.
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora
Rielaborazione a colori - Mario Vassallo
Questo scritto non ha la pretesa di essere una biografia né tantomeno un’ulteriore narrazione delle imprese compiute dai suoi intrepidi equipaggi, a suo tempo già state meravigliosamente descritte da altri autori ben più autorevoli del sottoscritto, ma vuole essere solo un omaggio alla sua persona, che fu presente e residente per molti anni in seno alla nostra comunità.
E’ mia intenzione presentarne un ritratto inedito e più ampio sotto il profilo umano, arricchito dal racconto di aneddoti a lui relativi con il contorno di vicende che si intrecciano con quelle relative alla mia famiglia, nel contesto storico, sociale e paesaggistico dell’Andora di quei tempi.
Per ottenere ciò, oltre ai già noti racconti di famiglia ed alla collaborazione di tanti amici, mi sono anche impegnato nell’opera di recupero della memoria degli ultimi testimoni di quel tempo, che ebbero modo di conoscere ed apprezzare quell’uomo.
Ho così messo sotto torchio ed ho spremuto ripetutamente, spero non me ne vogliano più di tanto, un gruppetto di arzilli vecchietti che, devo riconoscerlo con profonda gratitudine, hanno sempre attivamente collaborato alla mia opera con grande entusiasmo e talora con incitamenti e altrettanto validi suggerimenti.
A tutti, giovani e meno giovani, va il mio più profondo riconoscimento per l’indispensabile contributo apportato. Una citazione particolare e’ per i miei insostituibili e fantastici senatori alcuni dei quali, complice l’età avanzata, da quando iniziai a raccogliere le informazioni molti anni fa, purtroppo non sono più tra di noi e non hanno potuto vedere realizzato questo lavoro al quale hanno personalmente contribuito.
E’ pertanto a loro che va il mio primo pensiero ed ad un paio in particolare, primi inter pares, se mi è consentito.
Per ragioni affettive il primo è mio padre, che, quando gli manifestai la mia intenzione solo pochi mesi prima della sua dipartita, contribuì in maniera decisiva a scrollarmi di dosso le ultime esitazioni dandomi l’impulso affinchè tutti quei ricordi di famiglia e della comunità non andassero perduti e così impugnai carta e….. coraggio e decisi di mettere tutto per iscritto.
Il secondo, per ragioni storico testimoniali, è il signor Francesco Tagliatini, ultimo esponente rimasto dell’equipaggio dell’Artiglio, che ebbi l’onore ed il piacere di incontrare nella sua casa di Diano Castello durante un piovoso pomeriggio invernale. Con lucidità e chiarezza d’espressione disarmanti, ad onta dei suoi novantanove anni, mediante poche ed efficaci parole in pochi minuti seppe trasportarmi indietro di ottant’anni facendomi rivivere l’epica impresa dell’Egypt, quasi come se si fosse trattato di guardare un film. Chapeau!
Un ringraziamento particolare a voi tutti poiché siete stati e continuate ad essere la memoria storica della comunità perché, come disse il grande Indro Montanelli:
“Un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente ed è un paese senza futuro.”
PROLOGO
Io sono cresciuto ed ho vissuto tutta la mia infanzia e gioventù in una casa che si trova ad una manciata di metri sotto la villa di Stampino e la visione di quella tanto nobile costruzione mi è stata intimamente familiare fin dal primo momento della mia vita quasi quanto la visione dell’altrettanto simmetricamente umile mia dimora.
In casa eravamo in cinque: mio nonno e mia nonna paterni, più papà e mamma con me.
Mio padre faceva l’odontotecnico mentre mia madre lavorava saltuariamente come segretaria aggiunta negli alberghi o meglio, come si diceva allora, faceva la stagione e se poteva l’allungava ad altri mesi, una ragione in più, appena fu possibile, per mandarmi alla scuola dell’infanzia che si trovava presso le Suore di Sant’ Eusebio.
Ma di andare all’asilo, come si diceva a quel tempo, a me non piaceva proprio. Il motivo principale non risiedeva nemmeno nel fatto che là eravamo in tanti, inquadrati e pigiati tutti assieme con quelli più grandi che tiranneggiavano i più piccoli e le suore che, per non fare figli e figliastri, quando vedevano qualcosa che non andava per il verso giusto, sculacciavano sia il reo che il danneggiato, con tanti saluti per i dettami pedagogici della signora Montessori e del signor Spock, come del resto usava allora in tutte le case.
La ragione principale, per la quale ad un certo punto decisi di non andare più all’asilo infantile attuando il mio primo atto di ribellione a soli tre anni, era che a casa mia, oltre a starci molto meglio e di godere di tutta la libertà di questo mondo, c’era per l’appunto mio nonno con il quale avevo un rapporto intensissimo e di cui tuttora ho un ricordo struggente.
Mi voleva un bene dell’anima ed io stravedevo per lui ancor più che per papà e mamma.
Quando ripenso a lui vedo un uomo minuto ormai grigio, col volto scavato e la fronte stempiata, che amava immergersi totalmente nella cura dei suoi fiori e delle sue piante ornamentali. Aveva solamente una sessantina d’anni, quantunque mi sembrasse molto più anziano di quello che in realtà era. Comunque, nonostante quell’apparenza, era attivissimo e pieno di energie come neppure altre persone molto meno anziane di lui possedevano. Infatti lui non camminava, ma andava quasi di corsa tutto il tempo tanto era sempre indaffarato e dall’alba al tramonto non si fermava mai un momento per rifiatare.
Il ricordo più bello che possiedo della sua persona, e che non mi abbandonerà mai, è la sua immagine di fiorista intento ad accudire le sue creature vegetali con un amore quasi materno. Possedeva una piccola serra di legno entro la quale coltivava strelizie, che gli serviva anche come semenzaio e ricovero invernale per altre piante. Ma il luogo più affascinante di tutto quel suo piccolo mondo era rappresentato da una ancor più minuta serretta di stuoie di cannizzo che si era realizzato da solo, laggiù verso il ruscello all’ombra degli olmi e di una quercia, in un luogo fresco e riparato dai raggi del sole, entro la quale nella bella stagione riponeva ed esponeva per i potenziali acquirenti il meglio della sua produzione. Ecco, io me lo vedo ancora là, chino sui vasi, mentre cura con un amore maniacale le sue piante ed i suoi fiori. Lo seguo con il corpo e gli occhi in maniera avida ed affascinata, gli pongo domande ingenue come solo i bambini di cinque o sei anni sanno fare, eppure egli, con infinito amore mi spiega tutto ciò che c’è da spiegare su quelle piante e quei fiori.
Chissà, forse in cuor suo avrebbe sperato che anch’io, nato e cresciuto in quell’ambiente, un giorno sarei diventato come lui ed avrei continuato la sua opera, ma purtroppo il destino non gli avrebbe concesso questa gioia e soprattutto neppure molto altro tempo da vivere accanto ai suoi tanto amati fiori.
A me piaceva un mondo stare a contatto della natura sempre appiccicato a lui. Durante i lavori nei campi oppure quando andava a curare i giardini nelle ville in collina, aveva sempre qualcosa da insegnarmi o da raccontarmi, soprattutto storie tanto immaginarie quanto reali e vissute.
Mi raccontava fiabe e storielle per bambini quanto storie lontane, epiche di quando aveva fatto la guerra, la Grande Guerra e storie più recenti relative ad un certo signore che aveva vissuto in quella bella villa signorile che si trovava a poche centinaia di metri, un po’ più in alto della nostra casetta.
Quella villa rosa, così elegantemente rifinita, suscitava nel mio immaginario infantile delle suggestioni tutte particolari, oserei dire quasi di mistero, che mi accompagnarono per anni.
Ad arricchire quel sentimento contribuiva il fatto che ogni tanto scoprivo che certi oggetti di arredamento oppure dei semplici giocattoli, che ritrovavo in casa, avevano una strana provenienza, del tutto improbabile, ovvero dal fondo del mare.
Per esempio accadeva che un bel giorno scoprissi come quella enorme conchiglia tridacne, pesante non meno di una dozzina di chili, che in salotto faceva bella mostra di sé sulla mensola del caminetto, fosse stata ripescata da chissà quale nave affondata chissà dove.
Oppure che quel mio primo football di cuoio, ruvidissimo ed ancora con i lacci, con il quale oggi sarebbe pura follia giocare, ma al quale ero allora devotissimo insieme a quelle altrettanto improbabili scarpe da football che erano più dure di uno stoccafisso, era tutta roba riportata alla luce dai fondali marini alla pari di quell’elegante servizio di piatti di Ginori che usavamo solamente nei giorni di grande festa.
Insomma ogni tanto scoprivo con mia grande sorpresa e meraviglia che tanti oggetti, presenti in casa, erano il frutto del lavoro di recupero sottomarino degli uomini di quel signore di nome Quaglia, di cui spesso mi parlava mio nonno e che tali oggetti erano stati da lui gentilmente omaggiati alla mia famiglia.
Mio nonno purtroppo morì quando io non avevo ancora compiuto nove anni e questa è una ragione in più per la quale non mi pentii mai di aver trascorso il maggior tempo possibile al suo fianco.
Il tempo passò e quando fui adulto fu invece mio padre a riprendere in più di un’occasione quei racconti relativi a quel signore che aveva vissuto nella villa di Stampino e le imprese che aveva realizzato per il mondo.
Nel contempo iniziai a comprendere ed a ordinare tutta la complessità di avvenimenti che si erano succeduti nei vari tempi e luoghi della villa e lessi anche i pochi e vecchi libri che erano stati scritti su Quaglia e sulle sue navi recupero.
I fatti che venivano narrati, pur rimanendo cronaca nuda e cruda, per un certo qual verso, ai miei occhi di adolescente, sembravano usciti dalla penna di un autore di libri d’avventura per ragazzi e mi entusiasmarono non poco facendomi idealizzare fatti e persone.
Il tempo continuò a trascorrere finchè in età matura rilessi con occhi diversi quei testi e dentro di me si accese la curiosità di conoscere il personaggio meglio ed in maniera più realistica possibile. Grazie ai racconti di nuovi testimoni ed a nuove letture, ho avuto così modo e maniera di affinare il mio pensiero su di lui e sulla sua residenza in seno alla nostra comunità.
Alla fine di questo faticoso e certosino lavoro, l’impressione di fondo che ne ho ricavato è quella di un sincero rimpianto per non aver avuto modo di conoscerlo direttamente e non aver potuto apprezzare di persona la sua caratura imprenditoriale e le sue qualità umane.
Sono ormai molti anni che non risiedo più nella casa di famiglia, sita appena sotto la villa di Stampino, però è lì che è rimasto il mio cuore ed è sempre lì che penso che prima o poi tornerò. Solo in questo luogo ritrovo certe sensazioni di pace e di sicurezza ed ogni volta che ci ritorno, ed i miei occhi rivolgono lo sguardo verso la villa, il mio pensiero non può fare a meno di riandare a quel tempo passato ed all’allora suo padrone di casa.
Oggi è una domenica invernale qualsiasi e mia madre, come d’abitudine, mi ha invitato a pranzo. Io, come al solito, non ho saputo rifiutare, considerato che è un modo ancor più piacevole di stare assieme.
Ormai è il primo pomeriggio e prima che cali l’oscurità, esco finalmente di casa per sgranchirmi le gambe. Ho trascorso un paio d’ore con le estremità sotto il tavolo e questo non è proprio il mio forte anche se so apprezzare pienamente le gioie della cucina, soprattutto quando la cuoca è mia madre che tra i fornelli sa destreggiarsi veramente bene.
Ma ora sento proprio la necessità di uscire a respirare un po’ di sana aria di campagna, la mia amata campagna, che in questa zona per fortuna e per il momento si è salvata dall’urbanizzazione invadente.
Mentre passeggio pigramente lungo il vialetto d’accesso all’abitazione, godendomi il tiepido sole invernale ed assaporando il piacere di essere dove mi trovo, il mio sguardo spazia tutto attorno ed ascolto le voci della natura, natura che, vegetalmente parlando, è ancora ferma ed in questa sua apparente immobilità sembra anche poter fermare il tempo. E’ il periodo dell’inverno freddo e secco, infatti il vicino ruscello non si ode scorrere come avviene abitualmente in primavera e le piante da frutto, essendo state potate da poco, ora sembrano tante membra mutilate.
Nonostante gli spunti di vita e di colore sembrino pochini, i passeri manifestano ugualmente la propria felicità cinguettando e ruzzolando felici come piccole galline nella polvere della stradina campestre mentre in lontananza si ode un brusio indistinto emesso da uno stormo di uccelli. Si tratta di un nugolo di storni che ha occupato militarmente la chioma dell’enorme bagolaro situato nel terreno del mio vicino e che durante la bella stagione ombreggia la vecchia strada mandamentale. Ora lo stanno spogliando scientificamente delle dolci bacche. Guai a sostarci sotto in momenti come questo!
Nella direzione opposta Charly, il sempre vigile, ma altrettanto inoffensivo cane dell’altro mio vicino, che staziona sempre sotto due enormi pini parasole ultracentenari e si diverte a segnalare chiunque passi da quelle parti, abbaia a lungo ed un momento dopo ecco apparire un folto gruppo di escursionisti che, alla pari di altrettanti bikers, su questa antica strada hanno trovato un gradevolissimo percorso verde alternativo all’asfalto.
Dapprima mi salutano cordialmente e poi, non essendo pratici della zona e mancando contestualmente una adeguata segnaletica sentieristica, mi chiedono informazioni sui percorsi escursionistici che offe il territorio.
Dopo aver dato tutte le dritte richieste, prima di accomiatarmi da loro mi dilungo nello spiegare le opportunità che la vecchia strada mandamentale offre ai turisti.
Già, la vecchia mandamentale, quanti ricordi!
E’ stata la spina dorsale della viabilità della Val Merula per secoli e secoli fino alla fine del XIX secolo, ed è stata la strada della mia infanzia lungo la quale sono cresciuto tra il campo di mio nonno e quelli dei vicini. Era la strada che durante la settimana poteva portarmi a casa dei miei amici locali, oppure al sabato al campetto parrocchiale e la domenica alla chiesa.
Alla domenica percorrevo la stradina passivamente poiché si trattava di andare a messa, ma il giorno precedente, al sabato pomeriggio, era tutta un’altra cosa, ci volavo letteralmente sopra percorrendo d’un sol fiato quei cinquecento metri che mi separavano dal campetto di calcio posto sotto la chiesa di San Giovanni. Era il classico campetto dell’oratorio con annessi e connessi: forma e fondo assolutamente irregolari, circondato per due lati da alte barriere di rovi che, quando il pallone ci si piantava dentro, si poteva perdere anche un quarto d’ora per recuperarlo ( se non si bucava). Sul lato a settentrione non c’era nessuna barriera di rovi, ma forse era anche peggio, dato che due metri più in basso c’era la strada con subito a lato il fosso il quale, quando scorreva, se non ci sbrigavamo, ti poteva ruscellare via la palla direttamente nel Merula.
Il campo nella zona centrale aveva il fondo terroso, diventando inevitabilmente un mare di fango quando pioveva e per contraltare, essendo erboso sui lati, in quelle zone in primavera c’era l’erba alta mezzo metro, che poi si tramutava in paglia d’estate con l’aggiunta di spinosissimi cardi secchi che ti massaggiavano le caviglie senza pietà al pari di un cilicio di medievale memoria.
Il prete, Don Michele, si faceva vedere raramente, sembrava quasi non ci fosse, ma in ogni caso era in perenne agguato, dato che non appena uno dei contendenti si permetteva di essere troppo violento nel gioco oppure ingiurioso, ecco che d’incanto si materializzava lassù in alto sul piazzale a lato della chiesa e da lì comminava le ammonizioni che poi altro non erano che paternaleschi richiami verbali; le espulsioni costituivano eventi eccezionali e riguardavano solamente i blasfemi ( considerato il luogo ).
Al termine del pomeriggio di svago tutti i partecipanti alla partita dovevano poi andare a fare la cosiddetta “visita”, cioè andare a dire qualche preghiera in chiesa, ed allora era il fuggi-fuggi generale con mille ed una scusa, ma qui scattava la diffida da parte del prete: chi non avesse fatto la “visita” non avrebbe poi potuto giocare nuovamente al sabato successivo ed allora volenti o nolenti, che si credesse o meno alle sue parole, quasi tutti si dovevano rassegnare.
Erano sfide epiche con partite che potevano durare un tempo indeterminato, anche tutto un pomeriggio, e con il numero dei giocatori che variava a seconda delle esigenze personali dei giocatori stessi.
Non c’erano limiti di età tantomeno di abilità, tutti potevano partecipare liberamente in assoluta comunanza ed a volte era ridicolo ed al contempo commovente vedere bambini di sette otto anni cercare di contendere il pallone a ragazzi già formati di quattordici quindici, comunque i “ grandi” non ne approfittavano mai più di tanto e nessuno si faceva mai e poi mai del male, anzi, i cosiddetti “grandi”, spesso fungevano da istruttori ed incitatori per i più piccoli in una sorta di tutorizzazione in movimento direttamente sul terreno di gioco.
Si poteva iniziare quattro per parte, avere un orario di punta in cui si raggiungeva il numero di otto contro nove e terminare mestamente cinque contro quattro senza problemi.
Lì, quasi ogni sabato pomeriggio, su quel campo che per noi ragazzini e per me in particolare aveva il sapore di un piccolo Maracanà, aveva luogo la perenne eterna sfida tra la nostra squadretta parrocchiale e quella formata dai ragazzi della Marina e si può senza dubbio affermare che tutta la gioventù di Andora di quel tempo sia stata almeno una volta al campo di calcio di San Giovanni con la scusa di quelle partite, anche coloro ai quali il calcio non interessava affatto. Quel luogo, per un pomeriggio alla settimana, era il luogo principe di aggregazione della maggior parte dei ragazzi andoresi, tanto quelli dell’interno quanto quelli della costa che lì avevano modo di conoscersi, parlare, giocare, in una sola parola socializzare.
Non essendoci spogliatoi noi locali arrivavamo a piedi già in tenuta da gioco, mentre quelli che arrivavano da fuori a piedi o in bici ed al ritorno non volevano rimanere sudati a lungo, prima e dopo la partita dovevano cambiarsi almeno la maglietta. Allora erano soliti usare come appendiabiti un paio di alberi di ulivo che si trovano tuttora in fondo al fascione che sovrasta il campo appena sotto la chiesa, che, così addobbati, assumevano le sembianze di anomali alberi di Natale fuori ordinanza.
Le mise da gioco erano le più eterogenee che fantasia umana potesse immaginare: a seconda della stagionalità c’era chi giocava in maglietta e pantaloncini corti, tanti in camicia, oppure, in pieno inverno quando faceva freddo, c’era pure chi non si toglieva nulla e giocava tranquillamente con i pantaloni lunghi di fustagno ed il maglione girocollo di lana completati dagli scarponi ai piedi.
Le scarpe da gioco erano costituite per lo più dalle cosiddette scarpe da tennis, ma comunque si poteva vedere anche gente coi mocassini (!) o, per l’appunto, con gli scarponi contendere validamente la palla ai pochi, anzi pochissimi “ricchi” (quasi tutti della Marina), che esibivano regolari scarpe da calcio con tanto di tacchetti.
Di solito la partita “regolare” era sette contro sette, come quando Don Michele organizzava il sentito torneo che si concludeva con la finale che si disputava in occasione della festa parrocchiale di San Giovanni. Ma il carburante, che faceva da detonatore in questo superclassico ante litteram del sabato pomeriggio, era la sfida tra noi campagnoli di San Giovanni e quelli della Marina, i cittadini, tra i quali si annoveravano anche i primi immigrati che venivano considerati alla stregua di calciatori stranieri.
Era una sfida che, seppur vissuta nella nostra ingenuità infantile, accomunava al tempo stesso elementi riguardanti la lotta tra fasce sociali ad altri riguardanti il senso di appartenenza a differenti comunità.
Con malcelato orgoglio devo riferire che noi sangiovannesi, forti del fatto che giocavamo in casa e che conoscevamo ogni zolla del campo nel vero senso della parola, la spuntavamo quasi sempre.
Io di solito me ne andavo quando era già una ventina di minuti che sentivo mia madre sgolarsi dal terrazzo di casa per richiamarmi alla base: che voce!
Se allora quei richiami mi risultavano altamente inopportuni al limite del fastidioso, ora, a distanza di tanti anni, posso solo dire: che malinconia….. che nostalgia per quel tempo e quei momenti spensierati……
Interrompo la catena dei ricordi ritornando al presente, mi giro sui miei passi per tornare indietro verso casa ed il mio sguardo si rivolge inevitabilmente verso l’amichevole e boscosa collina che si trova ad ovest. Questa vista mi concilia ad abbandonarmi a qualche riflessione.
Alcuni anni fa è stata approvata una nuova enorme lottizzazione edilizia e, purtroppo, stavolta riguarda proprio la zona della tenuta di Stampino. C’è in progetto una ennesima enorme colata di cemento che dovrebbe riguardare addirittura la collina (sic!), proprio là dove non c’è mai stato nulla prima di oggi.
Ho anche sentito dire che forse è stata bloccata in Regione, speriamo sia vero perché non se ne sente proprio la necessità di nuove devastazioni ambientali, che nessun beneficio apporterebbero ad alcuno del luogo se non a qualche società di capitale creata ad hoc, arrivata da chissà dove e col solo obiettivo di monetizzare al massimo l’opportunità, fregandosene altamente dell’architettonicità e della sostenibilità.
Altri affermano che è tutto fermo solo a causa della perdurante crisi economica che per il momento dissuade dal costruire poiché i nuovi insediamenti rimarrebbero inevitabilmente invenduti.
Chissà come stanno in realtà le cose, io so solo che per il momento e per fortuna tutto è fermo e spero lo rimanga il più a lungo possibile, affinchè il luogo rimanga intatto nella sua naturalezza.
Volgendo gli occhi un po’ più a destra, al centro della bella pineta, che sfavilla di un verde intenso alla luce del basso sole invernale in questa giornata tersa e dai contorni nitidi, il mio sguardo osserva per l’infinitesima volta nella mia vita anche la villa di Stampino con i suoi molteplici particolari, che conosco quasi meglio di quei pochi essenziali che caratterizzano la mia semplice dimora di famiglia.
Ad onta del tempo che trascorre implacabile, che ne ha sbiadito inesorabilmente il bel colorito roseo della facciata, complice anche questa luce intensa, oggi sembra risplendere di nuovo come al tempo della mia infanzia
E’ un momento e quella più che abituale e familiare visione ha comunque il potere di evocare una volta in più nella mia mente tutta una vita di ricordi della comunità e di ricerche personali a riguardo, ricordi che si trasformano in emozioni, che in un attimo mi sovrastano e mi si ripropongono come se fossero una valanga impetuosa ed inarrestabile……
STAMPINO PRIMA DI QUAGLIA
Quando il Dott. Avvocato Giovanni Quaglia giunge ad Andora, proveniente da Diano Castello per acquistare la villa di Stampino con annessa tenuta e costruzioni minori, è il 15 Ottobre 1915.

Ad attenderlo, assieme al Notaio Calvini, al primo piano della residenza ci sono i proprietari, i quali sono due francesi, fratello e sorella: lui è Mr.Leopold Durand, lei Md. Anna Marie Coralie Durand, entrambi nati a Marsiglia e residenti ad Aix en Provence.
Gli stabili sono pervenuti agli eredi Durand per metà dalla successione della loro madre Giulia Matilde Musso in Durand e per l’altra metà dalla loro zia Isabella Musso in Moreno, sorella appunto di Giulia Matilde.
A loro volta le due sorelle avevano ereditato dette proprietà dalla successione dell’ultimo dei loro fratelli, Carlo Musso, ultimo appunto di quattro maschi.
Le due sorelle assieme ai quattro fratelli più anziani rappresentavano le ultime eredi di colui che aveva costruito la villa nei primi decenni dell’800 e costituito la primigenia tenuta di Stampino, tal Gian Stefano Musso, che di nascita non era stato assolutamente francese, come ben testimonia il nome, ma nativo di Laigueglia, essendovi venuto alla luce nel 1780, e soprattutto laiguegliese, anzi laigueglino come si diceva allora, per spirito e capacità imprenditoriale.
Per la precisione Gian Stefano Musso al tempo in cui era nato era addirittura cittadino andorese dato che a quel tempo Laigueglia era ancora parte di Andora e si sarebbe staccata e resa comunità autonoma indipendente solo nel 1794.
Costui apparteneva ad una di quelle grandi famiglie di origine catalana che avevano saputo arricchirsi nel corso dei secoli prima con la pesca del corallo e del tonno e successivamente con il commercio marittimo.
Proprio per sviluppare al meglio le proprie attività imprenditoriali marittime si sarebbe poi trasferito stabilmente a Marsiglia laddove sarebbe morto non prima di aver ottenuto la naturalizzazione francese, nonché aver lasciato una folta progenie dietro di sé costituita appunto da ben sei figli.
Quindi Stampino, che era stato creato da un italiano andorese, nel corso del tempo era diventato di proprietà dei francesi e dopo circa un secolo, con l’acquisto da parte dell’avvocato Quaglia, ritornava in mani italiane.
Bisogna precisare che la sunnominata signora Isabella Musso, sebbene fosse nata a Marsiglia e di conseguenza fosse di nazionalità francese a tutti gli effetti, era però poi diventata la moglie dell’italiano bordigotto Francesco Moreno appartenente all’altrettanto ricca e potente famiglia dei Moreno di Bordighera, famiglia di facoltosi commercianti che coi propri commerci spaziava letteralmente in tutto il mondo.
A quei tempi erano infatti frequenti i matrimoni tra famiglie appartenenti allo stesso ceto sociale oppure operanti nel medesimo ramo lavorativo. In questo caso ciò che legava i Musso ed i Moreno erano i trasporti via mare delle merci essendo i primi degli armatori navali ed i secondi dei commercianti all’ingrosso.
I Musso avevano tra i vari clienti d’elite anche i Moreno, i quali, per poter esportare in tutto il mondo le proprie merci, dovevano avvalersi dei trasportatori del tempo e, dato che a quel tempo non esistevano ancora aerei, ferrovie, autocarri e quant’altro, tali merci potevano essere trasportate a lunga distanza solamente via mare.
Stando così le cose, tali unioni spesso e volentieri, volentieri magari da parte dei genitori forse un po’ meno da parte dei figli, comunque queste unioni erano la naturale conclusione di frequentazioni iniziate solo con intenti d’affari.
I Moreno erano famosi sia in Italia che fuori dei patri confini. Costoro erano famosi sì per il fatto che commerciavano olio e limoni della Liguria esportandoli in tutto il mondo, perfino in Giappone, e tra questi prodotti veniva annoverato anche l’olio che si produceva nella tenuta di Stampino, ma anche per il fatto che possedevano una straordinaria passione di famiglia per la botanica.
Il primo fu il padre Vincenzo Moreno al quale seguì poi il figlio Francesco. Entrambi, coltivando ciò che oggi definiremmo un semplice hobby, erano adusi farsi portare a casa dai componenti dei vascelli di ritorno dai viaggi commerciali in paesi lontani, piantine o semplicemente semi di piante esotiche mai viste e conosciute prima da noi.
Fu così che, coniugando mirabilmente affari con passione per la botanica, poco a poco costituirono il famoso Giardino Moreno situato attorno alla loro villa sita in Via Romana a Bordighera.
Nel 1860 il loro giardino era già noto a livello internazionale per la ricchezza della flora e la sua bellezza attirava la visita di pittori, scrittori e viaggiatori del tempo. Per questo motivo alcuni anni dopo Claude Monet, fondatore del movimento pittorico più conosciuto e di successo della storia, venuto a conoscenza di questo straordinario paradiso la cui fama correva nei salotti d’Europa, giunge a Bordighera. Riesce ad essere ospitato dalla famiglia Moreno che gli apre le porte dei giardini, luogo in cui agli inizi del 1884 dipingerà una dozzina di tele di valore inestimabile, ora esposte nei maggiori musei del mondo, non solo a Parigi, ma uno per tutti gli altri, il Metropolitan Museum di New York.
A Bordighera e dintorni Monet dipingerà in totale ben trentotto tele.
Ma la passione botanica dei Moreno non si fermò al paese d’origine e dato che, tramite il matrimonio di Francesco con Isabella arrivarono ad avere il possesso di Stampino, anche questa proprietà usufruì dell’onore di ricevere queste piante venute da lontano.
Fra queste la centenaria Banksia Grandis (Australia Occidentale) ivi situata, morì nell’inverno del 1985 a causa del freddo eccezionale ed un Pinus Canariensis ultra centenario è visibile ancora oggi.
Questi sono solo due esempi delle piante che vi furono messe a dimora, ma a quel tempo il giardino di Stampino doveva essere comunque floridissimo ed interessantissimo poiché Monet in un paio di lettere del suo fitto e quasi quotidiano carteggio con la moglie Alice Hoschedè riferisce che da Bordighera si sposta ad Andora insieme a Moreno per andare a visitare le sue proprietà là esistenti. Anche se il toponimo di Stampino non viene mai citato apertamente nelle righe a noi pervenute, nella prima delle due lettere il grande artista così scrive alla propria compagna:
“Chere Madame, je rentre de cette fameuse vallée d’Andore, emerveillèe, mais tres fatigué; c’est a 2 heures et demie de chemin de fer, ce qui fait 5 heures aller et retour et ayant beaucoup marché; en somme, journee tres agreable, je vous en parlerai plus longuement demain ( omissis ).....”

Autoritratto di Claude Monet
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
Monet in questa prima lettera, datata 16 Marzo 1884, pone l’accento sul fattore distanza, lamentando che con il treno ha impiegato ben due ore e mezza per raggiungere la nostra località da Bordighera, il che significava ben cinque ore tra andata e ritorno. Bisogna prendere atto, per onor di verità, che sebbene allora le locomotive funzionassero a vapore e nel frattempo le linee siano state elettrificate, quasi un secolo e mezzo dopo, i tempi di percorrenza non sono variati di molto.
Ritornando al racconto, annotiamo però che Monet, sebbene sia rimasto affaticato dalla pesante giornata, adopera anche tre aggettivi estremamente positivi per inquadrare la stessa, il primo dei quali è riferito alla valle di Andora che viene definita “famosa” ed il secondo alla propria esperienza di viaggio quando si autodefinisce “ meravigliato, stupito” e conclude infine le poche e scarne righe di questa prima sintetizzando che in fondo si è trattato di una piacevole giornata e ne riferirà più a fondo alla propria amata il giorno seguente.
Infatti il giorno successivo, il 17 Marzo 1884, in coda alla quotidiana lettera ad Alice Hoschedè, riprende il discorso interrotto il giorno precedente con le seguenti parole:
(omissis)…… "Comme je vous l’ai dit hier, j’ai fait un voyage delicieux hier: je suis passè par beaucoup d’endroits nouveaux pour moi, et tous plus merveilleux les uns que les autres. Ce M. Moreno est un vrai marquis de Carabas qui a des proprietes par toute l’Italie, et quelles proprietes! Hier, apres dejeuner, nous avons marchè trois heures sans voir la fin de sa propriete d’Andore, une merveille: la maison a mi cotè e des bois superbes: le sommet du bois est a 400 metres au dessus du niveau de la mer et là tojours des orangers, des grenadiers, etc. Nous avons fait un dejeuner pantagruelique et a l’italienne, cuisinè par les fermiers et delicieux, je vous assure..... (la fine manca)".
In questa seconda missiva la fatica del giorno precedente appare un po’ stemperata. A ventiquattr’ore di distanza al pittore sono rimasti vivi quasi solamente i lati positivi della gita: il viaggio è stato delizioso ed ha ammirato tanti luoghi nuovi uno più incantevole dell’altro. Francesco Moreno viene definito addirittura “un vero marchese di Carabas”, riprendendo la fantasiosa definizione presente nella nota fiaba “Il gatto con gli stivali”.
Monet riferisce di aver marciato dopo pranzo ben tre ore senza per ciò aver raggiunto la fine delle proprietà di Moreno. Probabilmente, conoscendo la passione che animava tanto Moreno padre quanto il di lui figlio, più che marciare forse ha solamente passeggiato per tre ore, mentre il suo anfitrione gli spiegava le varie piante presenti nel giardino e le colture dei suoi possedimenti tanto vicino quanto distante la residenza, che lui nella missiva definisce giustamente situata a mezza costa.
Sottolinea che il bosco arriva ad un’altezza di quattrocento metri, ma ciò non significa necessariamente che siano saliti fin lassù, e rimane particolarmente impressionato dalla presenza di aranci e melograni, piante che ritrarrà molte volte nei suoi quadri.
Non omette di sottolineare che ha fatto anche un pranzo tanto abbondante quanto delizioso, sottolineando “all’italiana”, cucinato per loro dai fattori che lavoravano nella tenuta e che molto probabilmente abitavano nella casetta di servizio situata dietro la villa vera e propria.
Chissà mai cosa gli avranno preparato quel giorno per lasciarlo tanto soddisfatto: trenette al pesto, ravioli al sugo, coniglio alla ligure, un pollo alla cacciatora, oppure tutte queste leccornie assieme?
Purtroppo della lettera a noi giunta, manca la parte finale e pertanto non potremo mai sapere cosa avrà voluto assicurare alla sua bella con le parole che purtroppo sono andate perdute.
Ciò è un vero peccato perché sono veramente poche le sue lettere, appartenenti al carteggio con Alice Hoschedè da Bordighera, che sono giunte incomplete, ma purtroppo una di queste è proprio la seconda delle due riguardanti la sua visita in territorio andorese ed oltretutto non si sa di altre documentazioni scritte riguardo la sua visita ad Andora.
Comunque ciò che si rivela ancor più grave e lascia un enorme rammarico in noi andoresi è che quel giorno evidentemente Monet fu mosso da un intento di pura curiosità e svago e non artistico creativo, non avendo avuto assolutamente intenzione di toccare i pennelli.
Probabilmente il padrone di casa lo invitò a fare una gita spensierata in quel di Stampino, con annesso lauto pranzo, con l’intento di fargli ammirare da vicino un’altra delle sue numerose proprietà e da parte propria Monet forse con quella visita intendeva solo rilassarsi e riposarsi per una giornata.
Non dimentichiamoci che si era di domenica, giorno di riposo, e ricordiamo che, leggendo il fitto carteggio con Alice, egli si era più volte lamentato delle proprie fatiche pittoriche, ma purtroppo per lui, pur non avendo lavorato sulle tele, anche quella giornata si era rivelata fisicamente pesante.
Se avesse portato seco gli attrezzi del mestiere, forse ora potremmo vantare con giusto orgoglio che anche Andora e nella fattispecie Stampino furono ritratte dal più grande maestro impressionista.
Peccato veramente!!
Altrettanto certo è che a quel tempo a Stampino esisteva un ponte giapponese, forse ispiratore di quello che Monet farà costruire più tardi nella sua casa di Giverny, vicino a Parigi, e che diverrà protagonista di molti dei capolavori dell’ultimo periodo.
Ecco, con l’immagine mentale del ponte giapponese da lui ritratto più volte, vogliamo forzatamente consolarci del mancato ritratto di uno degli angoli più romantici e suggestivi del nostro paese ed al contempo illuderci che anche Andora abbia lasciato un’impronta nel cuore e nella produzione artistica di Claude Monet.
Dopo la morte del marito Francesco Moreno avvenuta nel 1885, appena un anno dopo il soggiorno di Monet a Bordighera, la vedova Isabella, essendo deceduto il figlio maschio ammalato di poliomielite, decide di ritornare in Francia e si disimpegna totalmente dalle proprietà italiane tanto di Bordighera quanto di Andora.
Stampino sarà così ceduta ai già citati nipoti Leopold e Anne Marie Coralie Durand nel 1910 un paio di anni prima del decesso della zia Isabella.
Durante questo periodo ultraventennale Stampino andrà così incontro ad un progressivo periodo di declino fino a che non arriverà ad acquistarlo il personaggio che andremo a conoscere meglio nei prossimi capitoli.
IL GIOVANE QUAGLIA
Giovanni Quaglia nasce a Diano Castello il 3 Gennaio 1881 da una ricca famiglia di proprietari terrieri di antico lignaggio presente in paese già dalla metà del 1300.
Il ragazzo, considerata la situazione economica della famiglia, non avrebbe alcuna necessità di lavorare per vivere, ma il padre vuole che si scelga una professione pertanto il figlio, dopo gli studi liceali, si reca ubbidientemente a Genova per frequentare la facoltà di Giurisprudenza divenendo avvocato.
Del giovane Quaglia in paese si ricordano le particolari doti di affabilità e spontaneità, che manifesta nelle relazioni con gli altri giovani della comunità, ed il temperamento dinamico che non gli può permettere di vivere oziosamente.
Pratica tutti gli sport tradizionali ed innovativi.
In particolare ama cimentarsi in lunghe partite di pallapugno che allora, come in tutti gli altri luoghi del ponente ligure, si praticava per le vie del paese, diventando campione provinciale, inoltre vince molti premi di tiro a segno tanto con la pistola quanto col fucile.
Risulta pure essere il primo cittadino di Diano Castello a dotarsi di una bicicletta, che egli non si limita a tenere strettamente per propria utilità o diletto, ma che concede magnanimamente all’uso e piacere della novità anche ai propri amici e conoscenti dimostrando in questa maniera disponibilità e generosità fattive. E’ infatti così che decine di suoi compaesani imparano ad andare in bicicletta, con quella del giovane Giovanni il quale, anche se nelle foto della maturità appare in pletorico sovrappeso, in gioventù doveva comunque essere stato un valido atleta. Più di una volta usa quel mezzo per andare e tornare da Genova al paese natale quando era uno studente universitario. A quel tempo la Via Aurelia era ancora notoriamente un inferno di buche e sassi che si tramutavano in una nuvola di polvere oppure un mare di fango a seconda della stagione, le biciclette erano ben lungi dall’essere leggere come quelle attuali e per di più prive di cambio di rapporto: insomma una vera avventura!
Il ragazzo dimostra di vivere intensamente i suoi tempi e di saper cavalcare appieno le trasformazioni in atto coniugando tradizione e modernità con disinvoltura.
Questa naturale predisposizione, assieme all’intuizione ed alla perseveranza, è la connotazione che lo avrebbe contraddistinto per tutta la vita e che più avanti lo avrebbe portato ai grandi successi internazionali sul lavoro.
Una volta divenuto avvocato, non esercita però a lungo la professione, in quanto si rende conto che non fa per lui, ma, da buon genovese, seppur adottivo, ciò che lo attrae maggiormente è il mondo della marineria e della navigazione con le attività ad esso collegate.
Si dedica così all’imprenditoria marittima diventando armatore e, con metodo e laboriosità, in pochi anni si crea una invidiabile posizione dedicandosi ai servizi di trasporto.
Allo scoppio della prima guerra mondiale a soli 33 anni è un uomo d’affari importante con una posizione invidiabile e, come si suole dire, può già considerarsi arrivato nonostante l’ancor giovane età.
E’ proprio allora che intravvede la possibilità di realizzare più vasti affari e pertanto si lancia in un nuovo settore dell’imprenditoria marittima che consiste nell’acquistare vecchi velieri, dotarli di motori a benzina potenti e veloci, e con questi trasportare armi e rifornimenti per gli eserciti alleati.
E’ questo il Quaglia che si affaccia sulla scena andorese quando nel 1915 decide di acquistare la tenuta di Stampino dagli eredi Durand.
Il giovane armatore ha solo 34 anni, ma possiede già un bel gruzzolo ed inizia a reinvestire e diversificare i proventi delle proprie attività marittime.
Attorno alla figura di quest’uomo nel corso del tempo sono fiorite le più svariate leggende e dicerie la prima delle quali riguarda appunto il motivo reale che sta alla base dell’acquisto di questa proprietà.
Siccome “u Sciù Giuvanni “, come veniva familiarmente chiamato dai suoi intimi e collaboratori di fiducia, oltre all’innato senso degli affari aveva di pari passo manifestato anche una spiccata e precoce passione per il tavolo verde, già allora si era diffusa la voce che quell’affare non fosse stato programmato, bensì fosse stato il frutto di una particolare e fortunata serata trascorsa giocando a carte contro qualche altro possidente e che la posta finale della malcapitata controparte fosse alfine risultata la tenuta di Stampino con annessi e connessi.
La sicurezza assoluta in questi casi non c’è mai, ma è sicuramente più credibile che quell’acquisto fosse stato molto più ponderato di quanto affermassero le volatili dicerie popolari. Si era infatti entrati nel secondo anno di guerra e tutta l’Europa era schierata in campo, anche se per l’Italia la terribile avventura era iniziata solo da pochi mesi, ma il peso del conflitto si era fatto gravoso già da subito.
Tra i motivi più realistici e credibili c’è da considerare che, da buon uomo d’affari, Quaglia poteva aver pensato di porre al riparo della svalutazione i propri soldi con investimenti mirati e quello ne rappresentava uno valido come altri. Però quella non era certo l’unica motivazione che poteva averlo spinto in tal direzione in quanto ce n’erano sicuramente altre sia di carattere economico che personale, prima fra tutte sicuramente quella del prezzo: 85.000 lire.
Se si pensa che allora un chilo di pane, per chi non se lo faceva in casa, costava circa 50 centesimi di lire, un impiegato medio percepiva 3/4.000 lire all’anno, un’automobile Fiat Zero costava 7.000 lire equivalenti a 27.000 euro di un secolo dopo, allora si comprende come la tenuta di Stampino comprendente terreni, la “casa padronale”, come riportato nel documento originale, più altre costruzioni minori di servizio, non comportasse una spesa poi così esagerata e che potesse considerarsi un buon affare.
Evidentemente i “Francesi”, come venivano volgarmente definiti gli allora proprietari, avevano voglia di disfarsi della proprietà e l’avevano posta in vendita ad un prezzo conveniente e l’Avvocato non si era lasciato scappare l’occasione…..
In quel particolare momento storico Quaglia si trova anche molto dentro le questioni belliche dato che le sue navi lavorano per l’esercito, quindi sa pure che per far funzionare le centinaia di locomotive che fanno la spola tra le retrovie ed il fronte è necessario molto combustibile e l’Italia, non possedendo né carbone né petrolio, deve supplire a ciò con la tradizionale legna da ardere. Ed allora cosa c’è di meglio della valle di Andora per ricavare la legna necessaria al funzionamento delle caldaie delle locomotive a vapore?
Infatti durante il periodo bellico quasi tutti gli ulivi della media-bassa Val Merula vengono tagliati ed sradicati onde poterne ricavare legna da ardere di qualità che viene venduta al governo italiano impegnato nella strenua lotta contro gli Austro-Ungarici.
Gli uliveti che fanno parte della tenuta non fanno eccezione ed anch’essi vengono sacrificati ed immolati sull’altare delle patrie fortune poiché, economicamente parlando, rendono più come combustibile che come alberi da frutto oleario.
Infine all’acquisto potrebbe aver contribuito anche una motivazione di carattere più specificatamente personale e ciò è determinato dal fatto che egli già da alcuni anni lavora e di conseguenza abita a Genova, ma quando torna a casa a Diano Castello per certi versi si sente un po’ soffocato.
La sua casa avita, anzi il suo palazzo di famiglia, è ampio e comodo, però si trova proprio in pieno paese stretto tra le altre abitazioni e la strada centrale, pertanto non gode dello spazio necessario attorno per poter usufruire di una particolare privacy tanto per se stesso quanto per i suoi eventuali ospiti.
I compaesani poi, quando torna a casa, dal momento che egli ha fatto fortuna in città, stravedono per lui e sono gentili ed affabili come non mai, ma per un verso o per l’altro non lo lasciano in pace come lui desidererebbe. In quella residenza di Stampino egli intuisce che c’è il luogo che faccia da giusto compendio tra il ritorno a casa tra la propria gente e la necessità di un buon ritiro dove rilassarsi e ritemprarsi ed all’occorrenza poter ospitare qualche ospite particolare, nella fattispecie un esponente dell’esercito, della finanza od anche del governo, lontano da sguardi indiscreti.
A testimonianza di ciò è necessario ricordare come si presenta Andora agli inizi del secolo scorso e che la situazione può essere ben sintetizzata dall’antico detto: “Andora, chi la cerca non la trova”.
Infatti per fotografare la situazione locale del primo ‘900 bisogna idealmente chiudere gli occhi, fare tabula rasa totale di ciò che vediamo oggigiorno, e porci di fronte ad una tela pressoché bianca sulla quale il pittore ha solamente tracciato uno schizzo per delinearne i contorni.
EPOCA DI CAMBIAMENTI
Il primo quarto di secolo del ‘900 vede Andora e la sua valle uscire dal torpore e dall’immobilismo che l’avevano caratterizzata nel lungo periodo precedente e condurla incontro a profonde trasformazioni alcune delle quali la caratterizzano ancora attualmente.

Dapprima viene costruita l’enorme nuova stazione ferroviaria che poteva accogliere anche i ferrovieri con le loro famiglie e la piazza della stazione, mancando un vero e sviluppato centro storico sul mare, con il contemporaneo e progressivo sviluppo delle attività commerciali della via sulla quale si affaccia, diviene il nuovo punto di riferimento di Andora Marina.
Arriva l’energia elettrica, governata da un eccentrico personaggio di altri tempi che risponde al nome di Marco Soleri. Costui, dai modi spicci e bruschi, soprattutto noto poichè soleva circolare per il paese sempiternamente accompagnato dalla fedele doppietta a tracolla, per queste caratteristiche era stato soprannominato “Burrasca”. Il fatto che fosse poi il primo elettricista di Andora, come volle fosse inciso anche sulla propria lapide tombale, era per lui motivo di enorme orgoglio, che si esaltava ogni sera allorquando attivava un enorme interruttore a maniglia permettendo a soli pochi fortunati andoresi della Marina di usufruire per poche ore dell’illuminazione elettrica. Facevano eco le sue liti con il marchese Marco Maglioni, che viveva a Villa Mazè, liti che nascevano dal fatto che “Burrasca”, in nome del progresso vantava il sacrosanto diritto di poter piantare i pali della luce nei terreni del marchese. L’interessato invece si opponeva fermamente al passaggio della linea elettrica affermando che era altrettanto suo fermo diritto opporsi a cotanto scempio territoriale; insomma i due più di una volta giunsero a minacciarsi armi in pugno, ma non arrivarono mai a spararsi quantunque fosse loro più caro coricarsi in compagnia di un fucile che di una bella donna; e meno male che “Burrasca” era perfino il figlioccio di battesimo del marchese tanto che ne portava lo stesso nome. Ironia della sorte, la morte riuscì in quello che una vita non fu capace: nel cimitero di San Giovanni sono sepolti uno accanto all’altro.
Quasi in contemporanea all’arrivo dell’energia elettrica si spengono le fornaci per la fabbricazione dei mattoni lasciando come testimonianza le due tipiche “sotte”, dalle quali veniva estratta l’argilla, che, una alla Marina e l’altra appena a monte del ponte ferroviario, per molti anni ancora testimonieranno questo piccolo passato industriale tipicamente locale.
Appena dopo in paese compare la prima automobile di proprietà dell’altro marchese Maglioni Giuseppe detto “Pippo”, il quale abitava a Villa Stefania. Da buon signorotto non la guida di persona, ma si avvale del servizio di Giovanni Lunghi, il quale espleta il servizio in alta uniforme. Questo status simbol non durerà a lungo, poiché il marchese, notoriamente affetto dai vizi del gioco e delle donne, scialacquerà in breve tempo gli ultimi averi in proprio possesso e terminerà miseramente i propri giorni in un ospizio di Diano Marina. Quel che è peggio, lasciando anche il povero Lunghi senza lavoro, il quale dovrà cercarsi un nuovo incarico come chauffeur presso una baronessa di Diano Marina.
Comunque il fatto economico e paesaggistico fondamentale del periodo è costituito dagli ulivi della media-bassa valle che vengono quasi tutti tagliati.
Infatti ciò che in effetti risulta più evidente e colpisce maggiormente nel processo di cambiamento è proprio il paesaggio che si trasforma.
Fino allora nella parte planiziale della bassa Val Merula non si trovava quasi costruzione alcuna poiché il Merula, non ancora arginato, con le sue periodiche disastrose piene rovinava sistematicamente i campi del fondovalle rendendo vano ogni tentativo di coltura e alla stessa stregua era assolutamente sconsigliabile edificare abitazioni troppo vicino al letto del fiume. Oltretutto nella zona della foce si trovavano acquitrini e paludi che rendevano malsana l’aria a tal punto che Davide Bertolotti, a metà ottocento, descriveva la valle di Andora come “non felice”, al contrario di quanto avrebbe scritto Monet pochi anni dopo. Che a lui, al contrario di quanto sarebbe avvenuto con Monet pochi anni dopo, non abbiano offerto nemmeno un “cundiùn” od un bicchiere di nostralino?
L’unica coltivazione che gli andoresi erano riusciti ad impiantarvi nel corso del tempo era stata quella dell’ulivo ed in una maniera talmente fitta che, come afferma un altro autore, Carlo Reynaudi ancora all’inizio del ‘900….. “dalla stazione di Andora passando fra una vera foresta di ulivi..... si arriva fino all’abitato di Molino Nuovo prima di uscirne”.
Per avere una vaga idea di quale aspetto dovesse avere e come dovesse presentarsi la nostra valle in tutta la parte planiziale medio-bassa fino all’inizio della Prima Guerra mondiale, bisogna pensare che il paesaggio era uniforme a quello che si presenta ancora oggi solamente nella parte più alta di Piangrande, unico punto dove è sopravvissuto qualche frammento della grande foresta di ulivi che fino ad allora e per secoli aveva contraddistinto il paesaggio.
Ma dopo la Grande Guerra quasi tutti gli uliveti sono scomparsi ed i terreni, ormai deprezzati, si sono trasformati in squallidi gerbidi che al massimo possono fungere da pascoli ed è a questo punto che si verifica la prima vera ondata immigratoria rappresentata principalmente da contadini liguri che provengono dal savonese e dintorni.
Costoro comprano i terreni incolti dai proprietari locali a basso costo e nel corso di pochi anni a prezzo di tanta fatica e sudore li bonificano ed iniziano a farli rendere più intensamente trasformandoli in frutteti.
Anche l’Avvocato Quaglia può essere considerato a ragione come uno dei nuovi colonizzatori, infatti non si ferma all’acquisto della sola tenuta di Stampino, ma amplia il proprio orizzonte facendo altri acquisti. Un paio di anni dopo compra anche il Gumbasso, noto grande frantoio come dice la parola, e tutti i terreni attorno che fanno parte della proprietà dei due fratelli Musso di Genova: uno l’avvocato Edoardo e l’altro, come riportano le carte, il “benestante” Giuseppe.
Ma non si ferma ancora, negli anni successivi continua a fare la spesa tra i confinanti ed acquista molti altri terreni con stabili inclusi soprattutto dal marchese Giuseppe Maglioni.
I Maglioni alla Marina ed i Musso a San Giovanni, risultano i proprietari terrieri per eccellenza di Andora, detenendone da soli la più parte, ma poco a poco svendono progressivamente quasi tutte le proprietà nel periodo di un decennio.

Al termine di questa serie di acquisti senza tregua, negli anni ’20 si sono oramai delineati i confini del nuovo piccolo impero andorese dell’Avvocato Quaglia, che sono grossolanamente i seguenti: a nord arriva al fossato della Ferraia, ad est al bacino del Merula, a sud al fossato della chiesa di San Giovanni e ad ovest fin quasi in cima alla collina: si tratta di una proprietà di dimensioni enormi calcolando che ci troviamo in Liguria dove la parcellizzazione della proprietà è stata sempre una costante.
Anch’egli abbraccia appieno il nuovo credo agricolo e piantuma i possedimenti con alberi da frutto, soprattutto peschi ed albicocchi.
In breve tempo la sua tenuta diventa l’impresa che dà la maggior mole di lavoro in tutta la valle; abitualmente in bassa stagione non vi lavorano meno di una quindicina di unità mentre quando si arriva alla stagione della raccolta i lavoranti possono raddoppiare ed anche più.
Insomma “U Sciù Giuvanni”, così l’Avvocato Quaglia viene confidenzialmente chiamato dai locali, poco a poco diviene il maggior datore di lavoro locale e le sue proprietà contribuiranno per alcuni decenni a dare occupazione ed un dignitoso livello di vita a molte famiglie.
I suoi braccianti arrivano tanto dall’immediato circondario quanto da Conna ed alcuni anche da San Bartolomeo. Si spostano obbligatoriamente tutti a piedi, i più distanti partendo da casa che è ancora notte e magari ritornandovi che è già notte, ma a quel tempo nessuno vi faceva caso perché, o nella propria proprietà oppure lavorando per qualcun altro, quelli erano gli orari abituali di lavoro in campagna.
L’unico che viene da fuori è il fattore che li dirige, un comprovato uomo di fiducia di Quaglia, Nicola “Culin” Novaro, il quale arriva ogni mattina da Diano Castello in calesse e pure lui come i suoi sottoposti fa il pendolare ante litteram impiegando non meno di un’ora per recarsi sul luogo di lavoro come per rincasare.
Le operazioni di ammasso ed incestamento avvengono nei magazzini che si trovano a metà del viale che conduce alla villa, accanto ai quali si trovano anche le stalle dove sono alloggiate le bestie utilizzate per i lavori nei campi.
La frutta, dopo essere stata opportunamente incestata, viene trasportata coi carri alla stazione ferroviaria per essere spedita ai mercati generali di Genova e Milano oppure è venduta già subito agli speditori andoresi ( Gagliolo,Torrengo) e limitrofi ( Noberasco, Moreno).
La produzione dei suoi frutteti è tanta e tale che da sola assorbe per intero la produzione di cassette e plateau di una segheria e sempre da sola riesce quotidianamente a completare il carico di un vagone ferroviario.
Un suo particolare vanto di cui sarà sempre orgoglioso, soprattutto agli occhi dei suoi numerosi amici inglesi, è che, già prima del secondo conflitto mondiale, nel momento di sua maggiore notorietà internazionale, riesce a spedire le sue pesche “Hale” via ferrovia da Andora fino al mercato di Covent Garden a Londra dove arrivano in capo a 3/4 giorni.
Per far ciò, pur essendo estate e non essendo ancora presenti all’epoca le celle frigorifero, si avvale di particolari vagoni dotati di ghiacciaia sui lati, dove vengono alloggiate grosse barre di ghiaccio, che sono via via sostituite mano a mano che si sciolgono lungo il percorso.
In questo caso per Quaglia non è tanto una questione di guadagno quanto di prestigio.
Se i suoi frutteti di Stampino poco a poco diventano nel corso del tempo una splendida realtà produttiva che dà lavoro e soddisfazione raggiungendo l’apice già sul finire degli anni ’30, le vicende legate alla marineria riservano fortune alterne e le sorprese sono sempre in agguato.
L'ORO DELL'EGYPT
Terminata la Grande Guerra c’è sovrabbondanza di navi da carico il cui valore commerciale crolla da 30 a sole 3 sterline la tonnellata, di conseguenza anche l’utilità di gran parte delle sue navi viene meno e Quaglia si ritrova quasi rovinato.



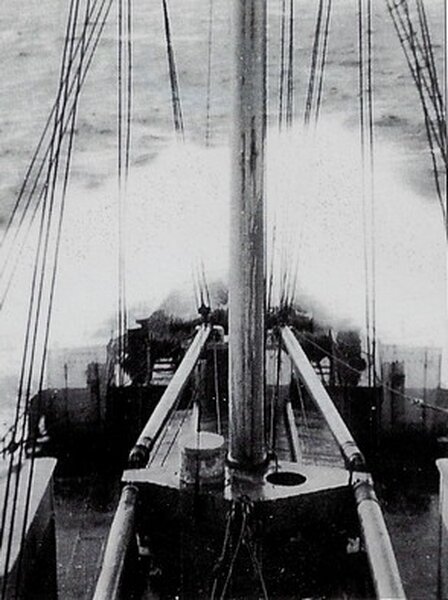
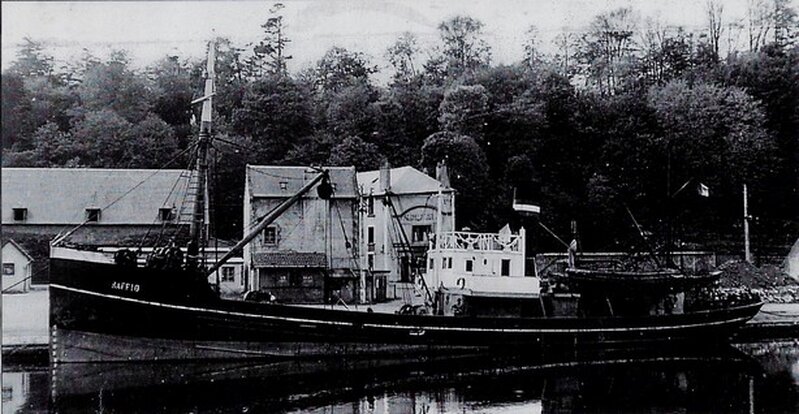
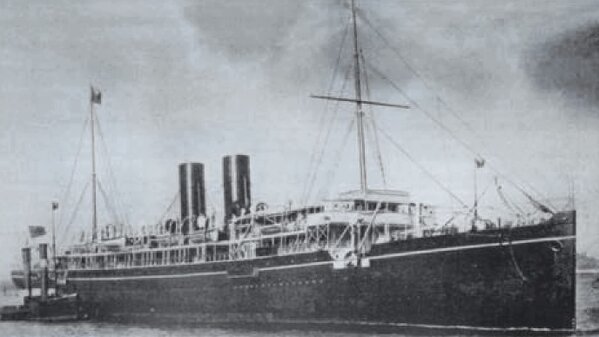


La tipologia delle sue navi, adattate per l’occasione a scopi bellici, ora non serve più e pertanto i suoi natanti sono inattivi, in disarmo e passivi al massimo.
Relativamente a questo frangente aleggia anche una leggenda, sempre collegata alla sua ben nota passione per il tavolo verde, la quale afferma che i suoi problemi economici in realtà siano stati generati da ingenti e ripetute perdite al gioco a tal punto da portarlo a meditare addirittura il suicidio.
Sempre la medesima leggenda aggiunge che, trovandosi appunto egli in così cattive acque, la donna che già da un po’ di tempo si trova al suo fianco, essendo di buona famiglia, arrivi addirittura ad offrirgli di vendere i propri gioielli pur di aiutarlo e che in seguito a questo episodio, in cui la sua compagna ha dimostrato tanta dedizione ed amore, egli accantoni ogni residua esitazione e decida di sposarla, cosa che avviene in realtà dato che si unisce in matrimonio con la signora Vincenza “Tina” De Nicola, che gli starà fedelmente al fianco per tutta la vita.
Comunque, anche se il momento economico è più che critico, con indomito coraggio, con quella volontà tenace che è certamente la sua caratteristica peculiare, tipica della razza ligure, l’armatore castellotto non si piange addosso e, con quell’ ottimismo che lo ha contraddistinto tutta la vita, si lancia in una nuova avventura.
Notando il rapido crescere delle esigenze petrolifere legate soprattutto al crescente mercato delle automobili, raduna quanto ancora gli rimane del patrimonio e si lancia in una nuova impresa creando la CITOM (Compagnia Italiana Trasporto Oli Minerali), la prima società italiana che si occupa di navi cisterna che trasportano petrolio dal Mar Nero, dall’Africa e dall’America in Italia e nei paesi del Nord Europa.
Con questa nuova attività ottiene nuovamente risultati di prestigio sia personali che economici, ma, non ancora soddisfatto, pensa già ad altro lanciandosi in una ulteriore avventura o meglio in una nuova tipologia di impresa marittima alquanto particolare, la quale sarà poi quella che gli conferirà la grandezza economica definitiva nonché il trionfo e la notorietà internazionale a livello planetario: quella del recupero del carico contenuto nelle stive delle navi affondate.
E’ così che l’11 ottobre 1926 a Genova viene fondata la SORIMA (Società Ricuperi Marittimi), una società unica nel suo genere, basata su quel che di più aleatorio si possa immaginare: i tesori affondati in fondo al mare. Oltretutto ciò avviene a Genova città che da sempre ha dimostrato come non possa esistere razza più pragmatica dei liguri.
Eppure Quaglia ed i suoi ci credono eccome anche perché la guerra aveva determinato l’affondamento di molte navi da carico e quindi a conti fatti la cosa non risultava poi così campata per aria come poteva sembrare di primo acchito; unica incognita non da poco, la profondità a cui si sarebbero rinvenute le navi affondate poiché a quel tempo si pensava non si potesse lavorare a più di 50/60 metri di profondità.
Il suo metodo è sempre il medesimo: tentare qualche cosa che non era ancora stato fatto oppure che era stato fatto, ma solo in piccole proporzioni e senza una organizzazione vera e propria, sviluppandola su larghe basi.
Infatti la SORIMA rappresenta una novità assoluta a livello mondiale in quanto è la prima ditta a specializzarsi in immersioni marine a grandi profondità su di una base commerciale, ottenendo per giunta un enorme successo.
La storia dell”Artiglio” e delle altre navi sorelle, assieme ai loro leggendari palombari, è pertanto anche la storia dei più riusciti recuperi marini a grandi profondità.
La SORIMA è così strutturata, se Alberto Fagian è il vero ideatore dei recuperi di profondità, il Presidente è il Gr. Uff. Alberto Manzi Fé, il Commendator Giovanni Quaglia ne è il maggior azionista ed Amministratore Delegato. Tra i soci azionisti di minoranza spicca la figura dell’Ammiraglio Costanzo Ciano, eroe della I Guerra Mondiale e coautore della famosa “Beffa di Buccari”.
Infatti Quaglia, da buon imprenditore-politico, sa tessere ed intrattenere le giuste amicizie e conoscenze in seno agli ambienti governativi onde poter ottenere le concessioni per poter intraprendere al meglio la nuova attività di recuperi sottomarini e di conseguenza trarne il maggior vantaggio possibile.
Sfruttando questa dote innata si fa conferire dall’Istituto Nazionale Assicurazioni, proprietario della maggior parte dei piroscafi e carichi italiani affondati durante la guerra, il diritto esclusivo dei recuperi da effettuare ad una profondità superiore ai cinquanta metri. Inoltre, non da ultimo, si procura l’esclusiva dell’ultima generazione di scafandri costruiti dalla società tedesca Neufeldt & Kunke di Kiel, ditta all’avanguardia nella produzione di scafandri per palombari, il meglio del meglio a quel tempo.
Insomma attività rischiosa sì, ma la società ha le idee chiare al riguardo, sia dal punto di vista giuridico che tecnologico.
Manca ancora un tassello non da poco: il fattore umano, cioè i palombari per l’appunto, e pertanto nella primavera del 1927 ingaggia allo scopo una squadra di palombari viareggini che hanno già dimostrato il proprio valore sapendo immergersi a profondità dove gli altri nemmeno pensavano fosse possibile.
I loro nomi sono: Alberto Gianni, Aristide Franceschi e Alberto Bargellini solo per citare i primi e più famosi ai quali nel corso del tempo se ne aggiungeranno altri.
Il capostipite e capo di questo gruppo è Alberto Gianni, viareggino come tutti gli altri, che si è formato alla Regia Scuola Militare del Varignano, uomo dalle mille risorse che dimostrerà nel corso del tempo di essere molto di più di un semplice palombaro, ma anche e soprattutto un inventore di dispositivi atti alla navigazione ed alle immersioni.
Neanche ventenne idea e fa realizzare il cosiddetto “motoeconomo”, un dispositivo per stabilizzare le navi a vela in caso di tempesta, marchingegno che ebbe poca fortuna poichè subito superato dalla pressoché contemporanea e progressiva dismissione della navigazione a vela in favore di quella a motore e poi, sempre con una grande idea, fà realizzare la prima “cassa disazotatrice”, cioè l’antesignana della successiva camera di decompressione ed infine dell’attuale camera iperbarica, per combattere il pericolo di embolia gassosa.
Anche Alberto Gianni ha già provato a lanciarsi nel difficile mondo dei recuperi sottomarini sia in proprio che in società con altri amici viareggini, ma nessuno di loro ha avuto fortuna ed allora l’incontro con Quaglia è un po’ come un segno del destino ed il matrimonio è immediatamente cosa fatta con reciproca soddisfazione.
L’attività di recuperi inizia l’anno successivo ed è subito un successo dietro l’altro.
L’”Artiglio” è la nave ammiraglia affiancata da “Raffio”, “Rostro” ed “Arpione”, nomi che diventeranno famosi in tutto il mondo, ai quali si uniranno successivamente “Rampino” e “Rastrello”. Da notare che sono tutti nomi che intendono l’azione dello strappare.

L'Artiglio nel giugno 1932.
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora

L'Arpione il 24 maggio 1934.
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora

Il Rostro nel porto di Oneglia, agli ordini del comandante Giobatta Dulbecco nel giugno 1950.
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora
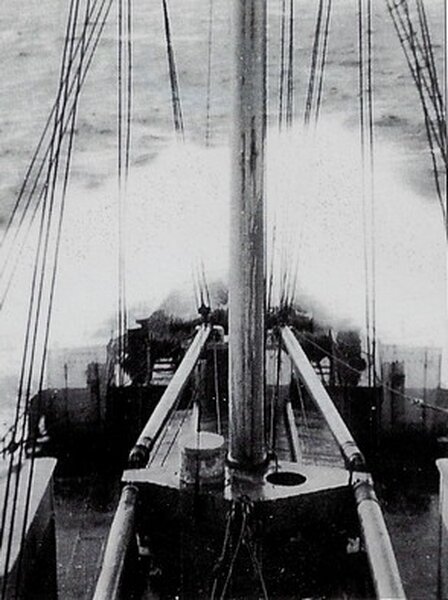
Il Rastrello in navigazione nel Mare del Nord nel 1937.
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora
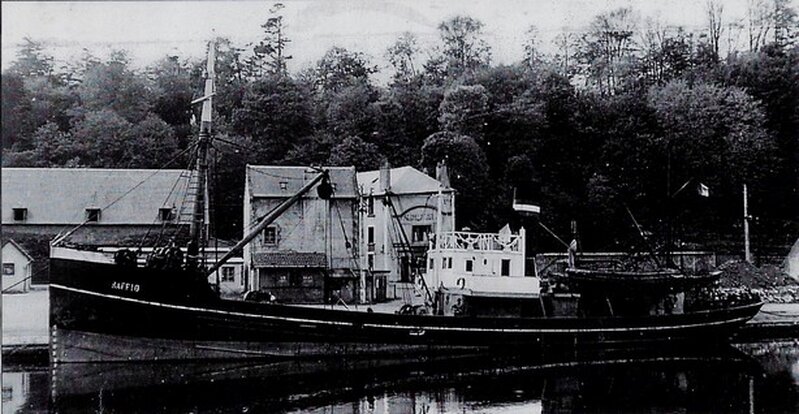
Il Raffio nel porto di Morlaix.
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora
Tutti gli uomini della SORIMA si rivelano da subito eccezionali dimostrando di saperci fare e di essere dotati di fisico, cervello, spirito di sacrificio, nonché audacia, tutte doti fondamentali per la riuscita in questi ardui compiti.
Sicuramente i nuovi scafandri della ditta tedesca Neufeldt & Kunke agevolano di molto le operazioni consentendo immersioni ad una maggiore profondità, ma Alberto Gianni continua a dimostrare di possedere doti rare di iniziativa e conoscenza. Dapprima li modifica e li migliora ulteriormente rendendoli ancor più competitivi e sicuri, in seguito sviluppa in proprio un cilindro metallico dotato di alcuni oblò chiamato “torretta”, che rivoluziona il modo di lavorare sott’acqua. Così facendo in primo luogo permette all’uomo di scendere a profondità fino ad allora impensate, quindi di modificare radicalmente la metodologia di lavoro: praticamente il palombaro ora non lavora più in prima persona, ma funge solo da occhio avanzato sott’acqua e tramite collegamento telefonico con la nave appoggio guida il braccio meccanico della gru che svolge il lavoro vero e proprio con molta meno fatica per l’elemento umano.
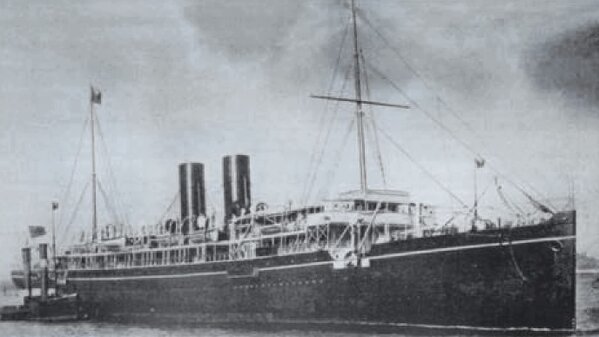
Il transatlantico Egypt in servizio sulla rotta Londra - Bombay
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
E’ così, in base a questi parametri molto confortanti, che Quaglia nel 1928 decide di alzare il livello dell’asticella e di puntare in alto, molto in alto, quasi stesse giocando alla sua tanto amata roulette, decidendo di puntare su un pieno secco.
Infatti il piatto più ricco al momento è rappresentato dal tentativo di recupero del carico del transatlantico “Egypt” affondato il 20 Maggio 1922 nei pressi dell’isola di Ouessant davanti a Brest, speronato nella nebbia dal piroscafo francese “Seine”.

Cartina topografica indicante i luoghi delle vidende narrate, evidenziati dalle frecce
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
L’”Egypt”, una nave di 8000 tonnellate di stazza lorda, lunga 152 metri e larga 16.5, di proprietà della “Peninsular & Oriental Steam Navigation Company” con a bordo 44 passeggeri e 294 uomini di equipaggio, era in navigazione da Plymouth a Bombay, avrebbe dovuto fermarsi a Marsiglia e lì imbarcare il grosso dei passeggeri, porto dove non sarebbe mai arrivata, ma la cosa più importante era che portava cinque tonnellate e mezza di lingotti d’oro e quarantatre tonnellate d’argento più ingenti quantitativi di sterline d’oro e rupie in banconote da consegnare alla Banca Centrale dell’India: un vero e proprio tesoro!!
Tutta la vicenda è stata magnificamente descritta ed illustrata dalle cronache del tempo, ma soprattutto da tre splendidi volumi, ormai introvabili nella versione originale.
I primi due sono “Con i palombari dell’Artiglio” e “L’Artiglio e l’oro dell’Egypt”, scritti dallo scozzese David Scott giornalista del “Times” di stanza a Parigi , che fu l’unico cronista ammesso a bordo dell’”Artiglio” per tutto il tempo della ricerca del relitto nonché del recupero del carico.
Il terzo è “L’Artiglio ha confessato” di Silvio Micheli anch’esso oramai pressoché introvabile al pari dei precedenti.
I libri di Scott, essendo stati redatti da uno spettatore esterno ed in maniera giornalistica, cioè in presa diretta come inviato speciale presente al momento, ci conferiscono un’immagine quanto mai viva e realistica sia di Quaglia che dei suoi uomini con tutti i loro pregi ed umani difetti, facendoli percepire al lettore più che mai vivi e presenti.
Scott possiede il grande merito di aver intuito l’impresa epocale che questa pattuglia di intrepidi italiani stava per compiere e, tramite questi due libri, ce ne offre un reportage unico nel suo genere, quasi in tempo reale.
Stando a bordo per tutta la durata delle ricerche del relitto dell’”Egypt”, nonchè delle fasi iniziali del recupero del prezioso carico, ha modo di stringere sincera amicizia sia con l’intero equipaggio che con il capo in persona della SORIMA ed in tal modo risulta essere stato l’unico scrittore ad averci lasciato un ritratto a tutto tondo ed umanamente ben delineato del Commendator Quaglia, come egli lo definisce, oltreché di una sua minibiografia, almeno fino a quel momento.
Risultano molto efficaci anche le descrizioni delle loro giornate a Brest, dove Quaglia aveva il suo quartier generale a terra presso l’Hotel Continental, oppure quelle delle loro scorribande in auto per la regione bretone, intenti a seguire da terra le operazioni della sua flottiglia impegnata in numerosi altri lavori di recupero sotto costa.
A conti fatti, ne esce il ritratto di una persona molto umana con tutti i pregi ed i difetti tipici di un latino: fondamentalmente viene descritta una persona ostinatamente ottimista ed allegra, ad onta delle oggettive difficoltà reali, e che a volte può indulgere perfino a credere nella scaramanzia più insensata piuttosto che nella pratica razionalità, un po’ come avviene per tutti gli appassionati del gioco d’azzardo, ma sorretta anche nei momenti peggiori da una enorme fiducia in sé stessa ed in quello che ha intrapreso.
E’ una persona che sente profondamente l’amicizia ed al tempo stesso preoccupata per l’incolumità dei propri uomini e capace di gesti notevoli come quando, per festeggiare il ritrovamento del relitto, fa ordinare per l’equipaggio addirittura una cassa di champagne!
Particolarmente gustosa, infine, la descrizione bonaria e quasi caricaturale, da parte di Scott, di un uomo che parla sicuramente un buon francese dal punto di vista sintattico-grammaticale, ma con una forte inflessione dialettale il che a volte lo porta a storpiare certe parole. Infatti il secondo ed ultimo libro della mini saga si chiude proprio riportando una frase molto significativa ed autobiografica da parte del Commendatore in cui il protagonista non si smentisce nemmeno in questa occasione storpiando la parola finale della frase, che nelle sue intenzioni dovrebbe essere “bien”, ma che Quaglia storpia in un quanto mai dialettale “biang”.
Per quanto riguarda il libro di Micheli, essendo stato scritto circa trent’anni dopo i fatti accaduti ed unicamente sulla base dei racconti dei marinai e palombari viareggini sopravvissuti, risente un po’ della cosa e naturalmente rischia di peccare un pochino di strabismo di parte.
Infatti, più che la descrizione dei fatti, ciò che sembra essere il reale motore dell’opera è la notevole vis polemica nei confronti dell’armatore castellotto, che viene descritto con tratti molto più scuri che chiari, il quale dapprima viene praticamente ritenuto l’indiretto responsabile della sciagura in cui l’”Artiglio” salta per aria, e poi, a recupero valori avvenuto, il perfido datore di lavoro che si rimangia la parola nei confronti dei poveri dipendenti non conferendo loro ciò che era stato concordato e più volte promesso.
Micheli descrive Quaglia come un ostinato imprenditore non alla pari di Scott, per il quale l’ostinazione risultava un valore positivo, ma come un personaggio ottusamente ostinato al limite della faciloneria, che comprende poco o nulla di cose di mare ed oltretutto rischia di mettere in pericolo tanto sé stesso quanto i propri uomini proprio a causa della propria incompetenza in materia. Il suo unico obiettivo è solo e nient’altro che l’oro in fondo al mare a tal punto che alla fine della vicenda non mantiene nemmeno la parola data ai suoi uomini relativa ad un premio extra in caso di successo.

L'Artiglio, il Raffio e l'Arpione, sul relitto del Washington (inverno 1929)
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
Peccato che, quando questo libro fu scritto, Quaglia fosse già scomparso da un lustro e non fosse più possibile una sua replica tantomeno una sua versione dei fatti, fatti, però, che Scott racconta in maniera più fatalistica rispetto alla versione polemica che ne dà Micheli.
Cionondimeno, per completezza d’informazione e pluralità di visione, merita leggere tutti e tre i libri e riassumere anche su queste pagine la vicenda, almeno per sommi capi, onde comprendere meglio l’unicità e la leggendarietà dell’impresa per chi non la conoscesse ancora e, così facendo, invogliare il lettore alla lettura in biblioteca delle opere succitate.
DESTINO AVVERSO E TRIONFO FINALE
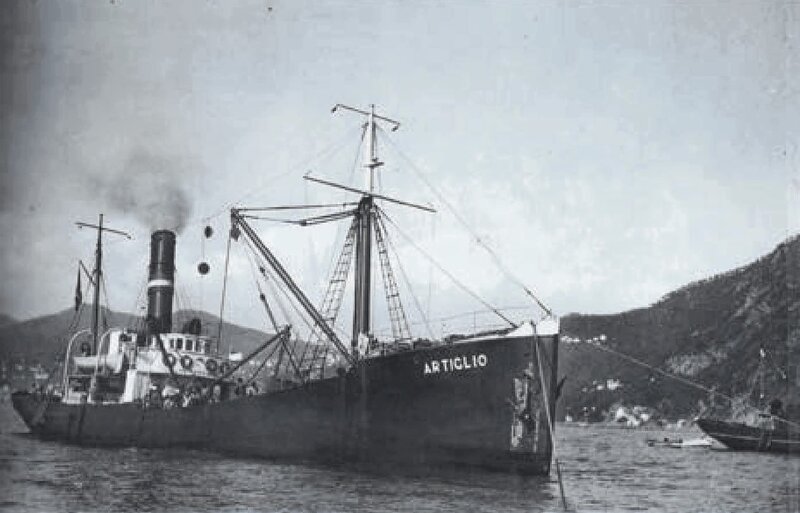
L'Artiglio nelle acque di Camogli nel 1927
"Proprio l'Artiglio di Fagian - Quaglia lasciò nel 1928 improvvisamnte le acque di Camogli per tentare il recupero del piroscafo Ravenna (silurato nel 1917 al largo di Capo Mele), ma nell'estate dello stesso anno fu destinato ad altra missione più importante e più redditizia in Atlantico (recupero fortunato di non pochi Lingotti d'oro del relitto Egypte)"
Da Tommaso Schivo - "Laigueglia e il siluramento del Ravenna".
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora
Nella corsa internazionale al recupero, dopo che avevano già fallito una società inglese ed un’altra francese, che lavoravano rispettivamente, i primi con una ditta svedese ed i secondi con dei palombari tedeschi, si inserì la SORIMA, che il 30 agosto 1928 stipulò il contratto di intervento con i Loyds di Londra e la Salvage Association, dato che i Loyds ormai erano divenuti i proprietari della nave dopo che ne avevano liquidato il valore ed i valori assicurati che essa trasportava.


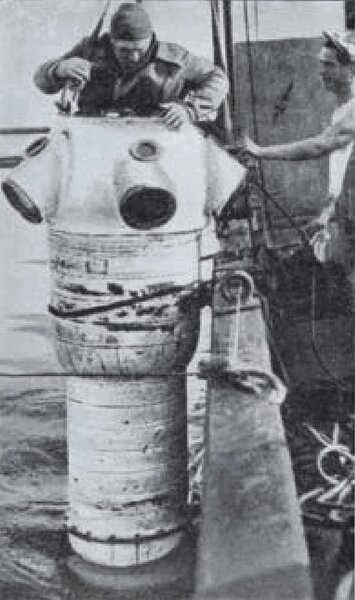


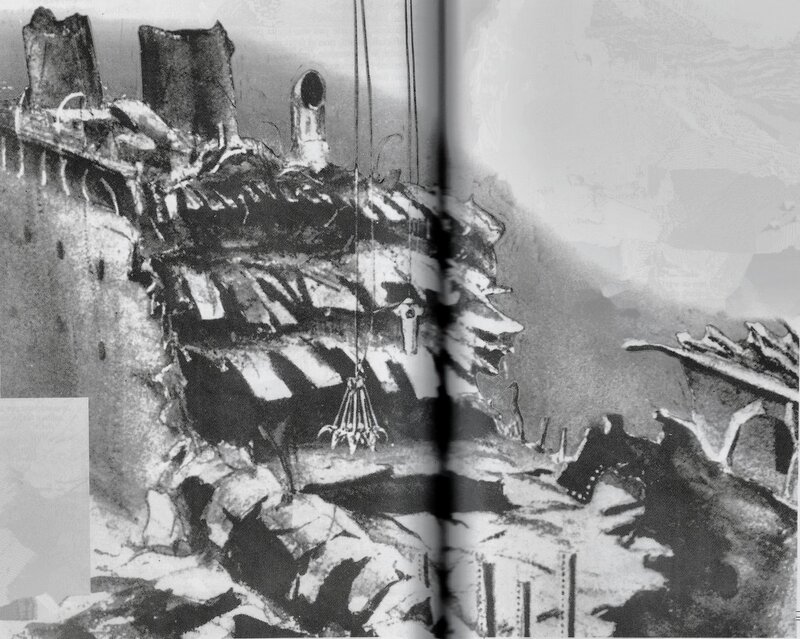






Potè così iniziare la grande avventura e la grande avventura iniziò con una ricerca paziente, difficile, tenace.
Per due anni quella gente ancora sprovvista di radar, sonar e qualsivoglia strumento elettronico inseguì un sogno, una chimera, vale a dire una nave in fondo al mare.
Dal giugno 1929 all’agosto 1930 vennero dragate centinaia di miglia quadrate in quel mare difficilissimo e noto a tutti i naviganti per la sua perigliosità data la presenza di alte maree, forti correnti, fitta nebbia, cambiamenti repentini di tempo e soprattutto vento, elementi coi quali equipaggi e palombari dell’”Artiglio”, abituati fino ad allora alle relativamente calme acque del Mediterraneo, dovettero familiarizzare in breve tempo.
Considerate le iniziali difficoltà di dragaggio del fondo del mare con conseguenti insuccessi, per localizzare il relitto in maniera sbrigativa ed alternativa, nel 1929 fu fatto ricorso anche a rabdomanti e rudimentali apparecchiature elettromagnetiche, ma senza risultato alcuno, cosicchè l’anno successivo si ritornò giocoforza all’opzione dragaggio iniziale.
Ma nonostante tutti i suddetti elementi avversi, il 28 agosto 1930, a due anni esatti dalla stipula del contratto, l’”Egypt” venne finalmente localizzato a 130 metri di profondità, cioè ad una profondità pari al doppio del massimo al quale usavano lavorare i migliori palombari del tempo.
Il mondo intero e gli esperti scrollarono il capo non credendo assolutamente alla possibilità di quel recupero e soprattutto la stampa francese ironizzò profondamente sulla velleitarietà del tentativo italiano, ma per l’”Artiglio” ed i suoi uomini ora iniziava la vera e propria sfida-avventura sottomarina.
I palombari ed i marittimi della SORIMA non si fecero troppi scrupoli e cominciarono il proprio lavoro.
Carte progettuali e modellino della nave affondata alla mano, iniziarono la demolizione di ben quattro ponti dell’”Egypt” mediante cariche esplosive onde poter arrivare alla camera del tesoro blindata, la cosiddetta bullion box, una stanzetta lunga e stretta che misurava solo due metri di larghezza per ben sette di lunghezza.

I palombari dell'Artiglio. Da sinistra Aristide Franceschi, Alberto Gianni e Alberto Bargellini.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
C’era la lotta contro il mare e c’erano lunghe ore di attesa da parte di Quaglia in porto a Brest dove gli italiani si fecero apprezzare dai locali ad onta delle autorità francesi le quali erano giunte a pensare che quella in realtà fosse tutta una manovra spionistica ordita da parte del governo italiano fascista atta a tenere sotto controllo la base militare navale francese di Brest. Ma gli italiani seppero dapprima farsi stimare e più tardi anche amare dalla popolazione locale per il loro coraggio, la loro cordialità, la loro forza, soprattutto la loro disinteressata generosità.

I palombari Gianni, Franceschi e Bargellini discutono su un modellino dell'Egypt.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
Tanto per dire, una sera ai baracconi dei divertimenti fecero fallire il titolare del gioco del battichiodo che offriva una bottiglia di champagne, anche se di bassa qualità, in premio a chi fosse stato in grado di piantare un chiodo con tre soli colpi in un’asse di legno: con quarantacinque colpi i palombari piantarono regolarmente non solo quindici chiodi, ma almeno venti! Fecero fatica a rincasare a causa del peso delle bottiglie vinte e di seguito tutti i baracconi destinati alle prove di forza divennero terreno di prova e di razzia.
Gli italiani non si limitarono a destare impressione ai baracconi, ma fecero anche colpo nelle balere locali dove lasciarono il segno nel cuore di più di una ragazza francese.
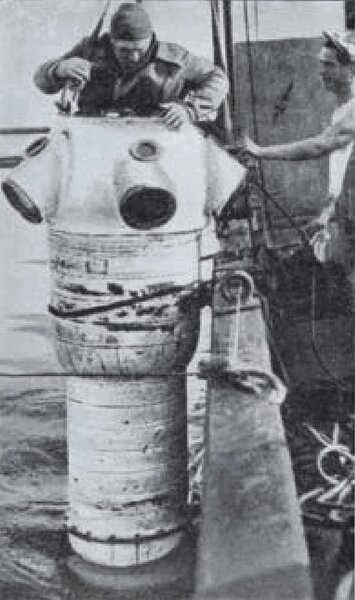
Agosto 1930: Bargellini ha veduto l'Egypt dopo tre anni di ricerche. Franceshi si appresta ad entrare nella torretta prima di immergersi.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
Ma un terribile destino era in agguato…..
Durante il periodo autunnale, non potendo lavorare sull’”Egypt” a causa del maltempo, l’”Artiglio” era stato inviato a lavorare in una zona di mare sottocosta più riparata e tranquilla situata un po’ più a sud tra l’isolotto di Houat, la costa e la penisola di Quiberon, a poca distanza da Belle Ile.
Avrebbe dovuto occuparsi dello smantellamento del piroscafo americano “Florence”, affondato da un sommergibile tedesco nel 1917, il quale trasportava munizioni al fronte alleato in Europa.
Giaceva su un basso fondale ostacolando la navigazione e nella stiva conservava ancora intatte le 150 tonnellate di proietti per cannone che aveva imbarcato alla partenza a New York e che doveva scaricare a Saint Nazaire.
Il Natale si stava avvicinando ed equipaggi e palombari dopo mesi di lavoro e lontananza dall’Italia fremevano per tornare a casa alle proprie famiglie in tempo per le feste natalizie.
Si sa che spesso la familiarità crea mancanza di rispetto, pertanto, accantonata poco a poco l’iniziale paura che li aveva fatti dapprima agire con estrema cautela, il Gianni e compagni aumentarono progressivamente la potenza delle mine, ma ciò che fu più grave, iniziarono altrettanto progressivamente a ridurre la distanza di sicurezza.
Agendo in questo modo, con frettolosità e superficialità, non rispettarono più le misure di sicurezza che la situazione imponeva e che all’atto pratico si traducevano essenzialmente nel distare almeno un miglio al momento dell’esplosione delle mine applicate alla carcassa della nave affondata il cui potenziale esplosivo era stato nettamente sottostimato.
Domenica 7 dicembre 1930, una maledetta domenica, quando le mine esplosero, esplose anche il mare.

Cartina topografica indicante la zona in cui l'Artiglio saltò in aria.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
Purtroppo all’atto dell’esplosione l’”Artiglio” si trovava solamente a circa duecento metri dal relitto sommerso.
Si sollevò un’onda alta decine di metri che mise a nudo il fondo del mare scavandovi addirittura una fossa di trecento metri di diametro.
L’”Artiglio” fu scaraventato in aria come una barchetta di carta spezzandosi in due, il mare divenne nero per l’intorbidimento e ribollì per un’ora.
Rottami del “Florence” piovvero come grandine a distanza di miglia, il cielo si oscurò avvolto da una densa nebbia di fumo nero che formò un enorme fungo spettrale, l’onda causata dall’esplosione si infranse contro la chiesetta di Saint Gildas sull’isola di Houat mentre i fedeli assistevano al vespro domenicale.
Mezz’ora dopo il “Rostro”, che cooperava in zona e dal quale i compagni assistettero impotenti alla terribile tragedia, recuperò sette superstiti che annaspavano in una cortina di schiuma densa e nera attaccati a qualche misero relitto.
Nella tragica esplosione erano scomparsi dodici uomini tra i quali il comandante Bertolotto di Camogli ed i palombari Gianni, Franceschi e Bargellini, l’elite della SORIMA.
Solo tre vittime furono recuperate: Gianni, Franceschi e il marinaio Cortopassi, gli altri rimasero dispersi in mare per sempre fra i quali anche l’imperiese Amoretti.
Ma se il tragico evento gettava nello stesso abisso di dolore tutti i dipendenti della società da Quaglia fino all’ultimo dei gregari, parimenti non veniva meno la tenacia e l’ardore dei propositi. Infatti solo cinque mesi dopo l’immane sciagura della baia di Quiberon un nuovo “Artiglio” era pronto a prendere il mare dai cantieri di Saint Nazaire e sulla sua fiancata a prora era stata sistemata pure la vecchia targa in bronzo recuperata dai rottami del vecchio “Artiglio” saltato in aria, la quale recava la scritta “Memento audere semper”.
Tutti si rimboccarono le maniche e ricominciò la lotta contro il mare, le correnti, le nebbie, le maree, il freddo, il vento, la pioggia.
Stavolta il comandante era Giobatta Carli di Imperia ed il capo palombaro Mario Raffaelli viareggino come ogni altro precedente.
Per demolire l’”Egypt” tagliarono quasi a metà un transatlantico di 8.000 tonnellate, sollevarono da esso circa 500 mq. di lamiere per un totale di 250 tonnellate di materiale metallico, fecero brillare cinque tonnellate di tritolo e si immersero duecento volte.

Il nuovo "Artiglio" torna alla base.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
Durante questa fase emerse prepotentemente la figura del Raffaelli che, divenuto giocoforza capo palombaro ed essendo uscito dal cono d’ombra dei colleghi scomparsi, dimostrò a propria volta una personalità eccezionale e soprattutto coi fatti che i rincalzi non erano da meno dei titolari.
Esperto, forte fisicamente come i predecessori, sebbene di poche parole, a seconda delle circostanze ideava modifiche alle attrezzature oppure inventava dispositivi nuovi.
Decisive per il buon esito del recupero furono la sua concezione e realizzazione di una particolare piccola benna che riusciva a penetrare nella stretta “bullion box” e di uno speciale tubo aspirante mediante il quale fu praticamente aspirato tutto il contenuto della “bullion box” fin nei pezzi più piccoli.
Ogni incertezza, ogni dubbio veniva da lui fugato con un’immersione personale.
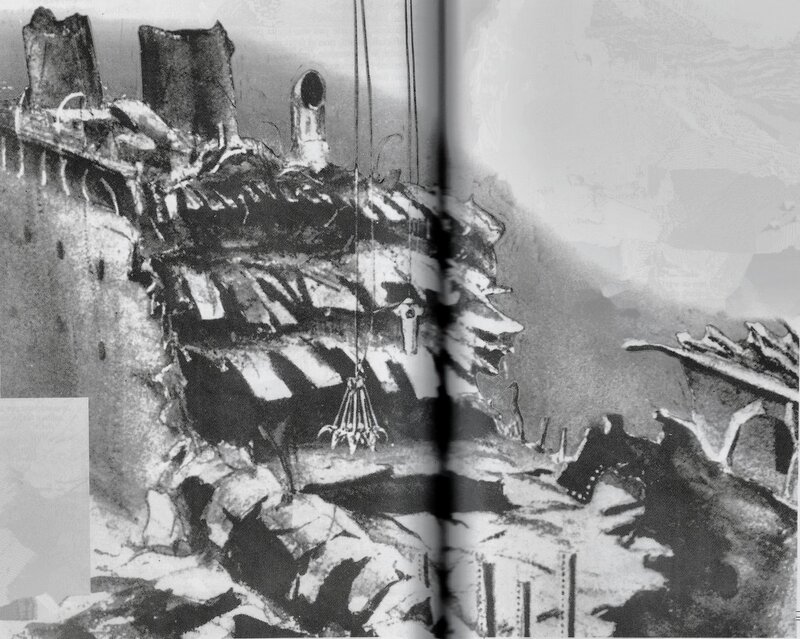
L'Egypt sul fondo: tracciati da David Scott, su precise indicazioni dei palombari, i disegni riprodotti in questa immagine danno un'idea della mole di lavoro eseguita sul relitto. E' visibile, in alto, l'apertura della stanza-valori, su cui pendono la benna e la torretta.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro

David Scott a bordo dell'Artiglio - Di David Scott - Libro Con i palombari dell'Artiglio - Pubblico dominio, httpscommons.wikimedia.orgwindex.php
Del resto il valore di questo autodidatta venne prontamente riconosciuto da Quaglia, che di persone di valore se ne era sempre inteso, il quale dapprima lo fece direttore tecnico e più tardi dirigente della società in qualità di consigliere di amministrazione.
E finalmente giunse anche l’ora della vittoria!

ArtiglioOrPlymouth - Di Agence de presse Mondial Photo-Presse - Bibliothèque nationale de France, Pubblico dominio, httpscommons.wikimedia.orgwindex.php
Il 22 giugno 1932, dopo quattro anni di lavori, di sacrifici, di fatica, di imprecazioni, di freddo e purtroppo anche di sangue, le prime due sterline pescate dalla gru emersero dall’abisso. La bennata successiva depose due lucenti mattoni gialli: “Lingotti, lingotti!! Oro. oro!! furono l’urlo comune. Fu un trionfo ed un delirio.
Un’emozione irrefrenabile percorse tutti, molti non riuscirono a frenare il pianto.

Esultanza dell'equipaggio al ritrovamento dell'oro.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
In quell’ora che sarebbe passata alla storia il Commendator Quaglia, che ne aveva condiviso fatiche, ansie, speranze e delusione, radunò tutti gli uomini a sé sulla tolda.
Chiese il silenzio e, scoprendosi il capo dal fido basco che teneva sempre sul capo, pronunciò queste parole:
“Nel momento in cui la nostra fatica è coronata dal successo e sentiamo tutti l’orgoglio di essere italiani, non voglio fare un discorso, pronunciare inutili parole. Vi invito soltanto a chinare per un momento il capo, rivolgendo il pensiero ai nostri poveri morti; essi ora sono con noi, presenti sulla tolda del nuovo “Artiglio” e condividono la nostra gioia”.
Quando l’”Artiglio” arrivò a Plymouth con il primo carico recuperato l’ammiraglio comandante la piazza chiese l’autorizzazione a recarsi in visita a bordo.
Al contrario il suo collega francese di Brest in quattro anni non aveva mai dato segno di accorgersi della modesta nave italiana attraccata al molo, ma era destino che anche l’ammiraglio francese dovesse rendersene conto. Accadde pochi giorni dopo quando il sommergibile sperimentale della marina militare francese “Promethèe” affondò al largo di Cherbourg. Anche i palombari francesi usavano gli scafandri Neufeldt & Kunke, ma non riuscirono a raggiungere il fondo. Allora l’ammiraglio di Brest,” improvvisamente, si fece vivo alla corte dell’”Artiglio” chiedendo aiuto per quei poveri disperati intrappolati in fondo al mare. La nave stava salpando per tornare al proprio posto di lavoro e continuare il recupero del tesoro, ma gli italiani compresero al volo il dramma che si stava consumando e corsero quanto prima in soccorso dei poveri sommergibilisti.
Detto fatto ed anche i nostri palombari si calarono riuscendo finalmente a raggiungere il “Promethèe”.
Battendo segnali Morse con un martello sulla fiancata dello scafo cercarono di comunicare con l’interno per riscontrare se c’erano ancora dei marinai vivi e così facendo ridare loro speranza, ma non ricevettero segnali di sorta.
Le autorità francesi vollero in ogni caso ricompensare la società italiana per l’aiuto conferito, ma Quaglia rifiutò qualsiasi genere di ricompensa o di rimborso spese offertogli.

Il Comm. Quaglia, in compagnia del Comandante Carli, mostra orgoglioso un lingotto appena ripescato.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
Cionondimeno tutti i rappresentanti della SORIMA, da Quaglia all’ultimo dei mozzi, ricevettero una serie di alte onorificenze e ringraziamenti ufficiali da parte dei rappresentanti del governo francese per ciò che avevano realizzato seppur con poca fortuna.

Il Comm. Quaglia accanto ai palombari del nuovo Artiglio. Mario Raffaeli in piedi a sinistra.
Seduti da sinistra: Raffaello Mancini, Giovanni Lenci e Fortnato Sodini.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
In seguito a questo episodio di valore e di abnegazione verso il prossimo assolutamente disinteressato, siccome poco tempo prima dei fuoriusciti antifascisti con fare molto superficiale avevano organizzato una ignobile gazzarra nei confronti di quelli della SORIMA pensando che fossero spie di regime colà inviati in missione speciale e qualche francese, che si era fatto condizionare dalla situazione, aveva urlato “cochons italiens”, allora nelle scuole di Brest venne dato un tema in classe: “Se in avvenire udrete qualcuno parlar male degli italiani ricordatevi dell’Artiglio e del Promethèe…..”
Il carico dell’”Egypt” fu recuperato nell’arco di più anni fino al 1939. A Plymouth l’”Artiglio si presentò quattro volte sempre atteso dai dirigenti più importanti dei Loyds e della National Salvage Association, mentre radio e giornali dedicavano ampi spazi alla memorabile impresa non solo in Italia e nel Regno Unito, ma in tutte le parti del mondo.

Giugno 1932, il conte Quaglia e parte dell'equipaggio mostrano felici alcuni lingotti d'oro.
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora
RITRATTO DI UN UOMO
A poco più di cinquant’anni l’Avvocato Commendatore Giovanni Quaglia, di professione armatore navale, raggiunge in tal maniera il successo inteso in ogni sua sfaccettatura, il che significa notorietà, prestigio ed ovviamente ricchezza nel vero senso della parola.
Tralasciando volutamente la più che scontata retorica celebrativa della stampa di stato italiana dell’epoca, ciò che risulta veramente interessante è il giudizio della stampa straniera.
Il giornalista Scott, presente per mesi e mesi a bordo dell’”Artiglio” e testimone diretto dell’impresa, scrive: “Nella storia dei recuperi marittimi questo è stato il più grande successo raggiunto fino ad ora e, forse, per molti aspetti, il più grande che potrà mai essere raggiunto da esseri umani negli abissi degli oceani.”
Sull’autorevole e storico “Times” si legge che “Nessuna opera di lavoro subacqueo così difficile, così eccezionale, così colma di non risolti problemi e di sconosciuti pericoli è mai stata realizzata prima ed è improbabile che qualcosa di paragonabile a questa possa mai più essere realizzata in futuro”.
In questa maniera l’impresa viene quasi descritta come quella di una cordata di alpinisti subacquei che abbia scalato alla rovescia una montagna fino ad allora invitta e che si reputava inconquistabile.
Detto dagli inglesi nei confronti degli italiani ciò equivale a molto più di un complimento di circostanza.
Quaglia ed i suoi uomini riescono al contempo sia a sciogliere il tradizionale nazionalismo britannico permeato di abituale superiorità, sia a conquistare il loro cuore; lo stesso vale parimenti per la stampa francese dal momento che anche i nostri cugini d’oltralpe non son mai stati storicamente generosi nei nostri confronti ed oltretutto all’inizio avevano ironizzato non poco sul tentativo, giungendo perfino a sospettare che si trattasse di una manovra di spionaggio camuffata.
Anche oltreoceano la stampa americana riempie per settimane le pagine dei quotidiani osannando l’impresa “impossibile” tramite i propri inviati speciali a Brest.
Qualcuno di questi giornalisti sulla banchina del porto arriva addirittura a palpare proditoriamente con le dita i muscoli dei palombari dell’”Artiglio” per verificare al tatto se questi uomini sono fatti come tutti gli altri oppure sono dei superuomini, fatto che ovviamente suscita perplessità se non vera e propria ilarità nei diretti interessati i quali, essendo persone umili e schive, di fronte alle domande incalzanti poste dai gazzettieri, si schermiscono e cercano di fuggire cotanta imprevista notorietà.
Per ovvie ragioni il trionfo di quest’uomo, che ha avuto il merito di intuire le possibilità che i mezzi del tempo potevano offrire, se adeguatamente impiegati da elementi umani selezionati e motivati dall’azienda, è soprattutto nel Regno Unito.
Non per nulla per qualche anno diventa l’italiano più noto e popolare in Inghilterra dove tutti si disputano la sua presenza, infatti spesso viene invitato ai ricevimenti nei salotti più esclusivi, in special modo nei ricevimenti a Buckingam Palace dove ha anche modo di conoscere i reali britannici.
Anche in Italia viene parimenti tributato di onori ed onorificenze multiple per il prestigio apportato alle patrie fortune e con tutto l’equipaggio dell’”Artiglio” viene ricevuto a Palazzo Venezia dal Duce che desidera complimentarsi personalmente con i protagonisti di questa grande impresa italiana.
Nell’occasione tutti i componenti del gruppo vengono iscritti d’autorità al Partito Fascista e Quaglia tra le varie onorificenze che gli vengono conferite viene anche insignito del titolo honoris causa di Conte, titolo al quale però non terrà più di tanto, ma che invece verrà molto più fatto proprio dalla di lui signora.
Quaglia è essenzialmente una persona di estrazione contadina e tale rimarrà tutta la vita: oltre che il suo particolare aspetto dimesso, lo testimonia il fatto che la sua lingua madre, quella preferita, è il dialetto castellotto che usa appena può con i suoi amici rivieraschi e compaesani. Ovviamente si esprime correttamente e correntemente anche in italiano dato che ha seguito fino in fondo gli studi da avvocato, ma prova molto piacere e si diletta anche ad esprimersi in genovese quando si trova in città.
Parla fluentemente pure il francese risiedendo spesso in Francia tanto per dei periodi di vacanza quanto per lavoro.
Uno dei suoi innumerevoli pregi consiste nel fatto che sa rapportarsi rapidamente all’ambiente che lo circonda.
Dalle campagne di Stampino alle stanze dei ministeri, dalla coperta delle navi ai salotti londinesi non avverte la minima difficoltà di passaggio e, stringendo sempre tra le labbra oppure tra le dita il suo abituale sigaro, intrattiene amabilmente la controparte sia che si tratti di un contadino, che di un cronista, che di un’autorità.
Scott lo descrive in questi termini:
“Tarchiato e rotondo è fisicamente molto simile all’uccello del quale porta il nome, ma, al contrario di quest’ultimo che è propenso alla paura, egli caratterialmente, benché d’aspetto allegro, nessuno è capace all’occasione di mostrarsi energico come lui. La sua astuzia cammina di pari passo alla sua simpatica ingenuità e superstizione; il suo amore latino per la gloria e lo sfoggio non hanno mai alterato la sua innata semplicità e la sua profonda bontà naturale pregna di umanità”
Proprio queste scarne ed essenziali parole di Scott forse hanno fotografato nel modo migliore e più sintetico il carattere e la figura dell’uomo di cui si parla, il quale è anche in grado di parlare un discreto inglese che ha fatto proprio in fretta dopo che è venuto a contatto con l’elite economica mondiale.
Proprio a Londra sviluppa una serie di conoscenze e di amicizie veramente importanti tornandovi più volte, amicizie che gli torneranno utili soprattutto durante l’imminente prossimo conflitto anche se, a dirla tutta, in cuor suo non nutre molta simpatia per i figli di Albione, infatti più volte viene sentito affermare dai suoi più stretti collaboratori che degli inglesi lui se ne batte…..anche se la moglie, ogni volta che si esprime in cotali termini, lo riprende duramente ricordandogli che così facendo si riduce automaticamente al livello dei suoi agresti compaesani.
Comunque sia e quantunque la moglie possa dissentire al Commendatore è permesso questo ed altro poiché l’artefice principale dei successi della SORIMA è assolutamente Lui avendo dimostrato al mondo intero di quale pasta sia fatto.
La sua è la tipica figura del ligure lavoratore ed intraprendente che con fede e coraggio ha perseguito un’idea, forse anche un sogno, e con acume ed incrollabile tenacia l’ha alfine raggiunta.
Dal dialetto facile, infarcito di espressioni tipiche della sua terra e del mondo marinaresco, rivela comunque profondo rispetto nei confronti di coloro che lavorano per lui e sa pesare e valutare in pochi minuti la qualità del proprio interlocutore, specie a bordo dove si è trovato spesso a condividere disagi, sacrifici e navigazioni pericolose.
E’ anche un generoso: i suoi equipaggi ed i suoi comandanti quando è possibile provengono dall’imperiese e in questo modo contribuisce a creare lavoro per i propri conterranei, come sa rivelarsi generoso in senso stretto, al di là dei rapporti di lavoro, con chiunque ogni volta che viene a sapere che un suo conoscente o compaesano si trova in difficoltà. Lungi da un facile paternalismo di facciata si interessa veramente ai problemi personali e familiari dei suoi dipendenti ed amici e quasi sempre li risolve, non lesinando quando occorre di mettere mano al portafogli, portafogli che, a dire la verità, tranne quando si trova da solo, non reca mai con sé dal momento che lo tiene quasi sempre l’autista Renato che provvede a tutti i pagamenti grossi o piccoli che siano in prima persona.
Sotto questo aspetto precede di qualche anno la ben nota abitudine dell’Avvocato Agnelli che notoriamente non toccava mai denaro con le proprie mani…..
Solo una volta si rivela duro e sordo alle istanze altrui ed è quando i marittimi dell’”Artiglio” rivendicano un premio extra per l’impresa dell’”Egypt” e lui si rifiuta, fatto per il quale a Viareggio non gliel’hanno mandata certo a dire a più riprese, ma è pur vero che si trattava di un ulteriore premio di produzione extra e che gli stipendi furono sempre puntualmente onorati, fermo restando che non si conoscono eventuali altri retroscena, uno dei quali potrebbe essere che le due parti ad un certo punto potrebbero anche aver esasperato una cosa che era nata semplicemente a livello di gentlemen agreement.
Sempre in seguito a questo trionfo si mormora che Mussolini sia italicamente orgoglioso per tale impresa, ma sia anche un po’ invidioso di questo italiano che presso gli inglesi al momento l’ha ampiamente superato in notorietà e popolarità il quale, nonostante le indubbie amicizie con alti esponenti di regime (Ciano, Grandi), non faccia corrispondere poi all’atto pratico e soprattutto all’estero una propaganda di regime adeguata.
A questo proposito, se è pur vero che il novello conte è ben introdotto nel novello governo fascista ed intrattiene rapporti con alti rappresentanti di regime al punto da farsi spianare la strada lavorativa con una legge ad hoc, e anche di ciò, sempre a Viareggio, ne hanno fatto quasi un capo d’accusa, è altrettanto vero che in qualità di astuto e smaliziato uomo d’affari quale egli è, li intrattiene soprattutto per ragioni lavorative, come avviene da sempre da parte di qualsiasi imprenditore, in qualsiasi epoca, in presenza di qualsiasi governo, così come continua ad avvenire quella che tutt’oggi si chiama “azione lobbistica”
Per di più, ad un’attenta analisi, si può facilmente riscontrare che i suoi rapporti con gli esponenti di regime si limitano ad elementi che appartengono all’ala più moderata del partito, nella fattispecie proprio coloro che il 25 luglio 1943 sfiduceranno il Duce ponendo fine all’era fascista della quale essi stessi erano componente integrante.
In questa ottica è pertanto da ritenersi pressoché priva di fondamento un’altra leggenda che aleggia sulla sua persona, la quale vorrebbe che quando si reca a Roma per ministeri abbia il vizietto di farsi mettere la camicia nera in valigia.
Quaglia non ha certamente bisogno di ricorrere a simili mezzucci affinchè vengano ascoltate le sue istanze, semmai l’armatore castellotto possiede un altro tipo di vizietto, anzi un vero e proprio tallone d’Achille che si chiama gioco d’azzardo.
Infatti egli si rivela da sempre un incallito frequentatore dei più noti casinò d’Europa ed ama soprattutto giocare alla roulette e a carte a “trente-quarante”.
I suoi casinò preferiti sono quelli di Montecarlo e Biarritz, dove ama trascorrere anche periodi di vacanza.
Mitica la sera in cui a Montecarlo, giocando a carte contro re Farouk d’Egitto, che affermava sulla parola di aver vinto e, non volendo mostrare le carte, ribadiva che era sufficiente la propria parola di re, allora Quaglia sbotta e gli urla imperiosamente in faccia: “Re o non re mostrami le carte”!!!
Insomma dopo il trionfo dell’”Egypt” è ormai diventato un esponente a tutto titolo del jet set internazionale a tal punto che si può permettere non solo di dare del tu, ma addirittura di porre degli inviti perentori ad un re.
Di tutta questa nuova ed enorme potenza e ricchezza se ne avvantaggia indirettamente anche Stampino perché ora che l’avvocato di Diano Castello ha raggiunto il successo planetario ( e può anche fregiarsi di un titolo nobiliare) anche la sua residenza andorese fa il salto di qualità.
STAMPINO

Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora
Rielaborazione a colori - Mario Vassallo
Fino alla prima metà degli anni trenta la villa di Stampino non possedeva assolutamente l’aspetto che oggigiorno tutti noi conosciamo.














Oltre che dai racconti dei pochi testimoni dell’epoca ancora viventi, lo possiamo apprezzare dall’unica foto precedente il suo restauro che ci è pervenuta.
Si tratta di una foto, scattata sicuramente negli anni venti del secolo scorso, in cui il soggetto non è la villa ma il ponte romano e in campo lungo la villa di Stampino appare come una costruzione senza decorazione alcuna.
Sebbene nel documento di vendita-acquisto non venga denominata come “villa”, ma come “casa padronale”, si tratta di una casa-palazzo già delle dimensioni attuali molto semplice nell’aspetto esteriore, anche se internamente doveva comunque già possedere un certo livello di rifiniture insolito per una magione qualunque, dato che ancora oggi nella sala da pranzo locata a pianterreno, sono presenti quattro affreschi che rappresentano altrettante vedute di Marsiglia e molti soffitti sono finemente decorati, testimonianza del fatto che i precedenti proprietari, nella fattispecie i Musso e loro eredi, la consideravano una residenza di un certo livello e non solo una residenza di campagna.
Il parco attorno alla costruzione era solo un giardino o poco più, mentre il lungo viale di accesso era già presente, ma senza alberi di lato. Erano invece già ben sviluppati i due enormi pini parasole che si trovano a metà circa dello stesso, i quali conferiscono al luogo dove si trovano il toponimo di “Pigne” proprio per la grande quantità di frutti che producono.
Probabilmente queste due piante vennero messe a dimora al momento della costruzione della villa e della realizzazione del viale di accesso quando questo era più corto rispetto ad oggi, poiché a quel tempo, a inizio ottocento, la strada provinciale attuale, situata sul fondovalle, non esisteva ancora. La principale strada di collegamento della valle, situata in posizione più elevata rispetto ad oggi, proprio a causa delle frequenti piene del Merula, era rappresentata dall’antica mandamentale, che in questo punto risulta tuttora ben conservata a differenza di altre zone in cui, a causa dell’espansione urbanistica e dell’adeguamento viario, il territorio è stato stravolto, cancellandola quasi totalmente.
Appena dietro questi due pini monumentali, che sembrano sentinelle di guardia, si intravedono le costruzioni che accoglievano le rimesse in cui erano alloggiate le bestie utilizzate per la conduzione dell’azienda ed i magazzini in cui veniva lavorata ed incestata la frutta prodotta nella tenuta.

Foto Ovidia Siccardi - Rielaborazione grafica Mario Vassallo
A metà strada tra il ponte romano e la villa l’unica ulteriore costruzione che si noti è l’enorme caseggiato del Gumbasso, che all’epoca però non teneva già più fede al proprio nome in quanto, come si può ben riscontrare dall’immagine di cui disponiamo, non c’erano pressoché più oliveti in zona ed oramai era adibito solamente ad abitazione ed a stalla.
Il fondovalle era praticamente immune da caseggiati e le abitazioni erano concentrate unicamente nei piccoli borghi situati sui primi rilievi tanto sulla destra quanto sulla sinistra orografica del torrente e ciò sempre a causa delle note ragioni di cui sopra.

Veduta della piana costiera andorese da Stampino.
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora
Rielaborazione a colori - Mario Vassallo
Andora contava circa duemila abitanti ed era presente solamente un centesimo (!) della volumetria abitativa attuale. Il resto erano solo campagne coltivate principalmente a peschi con l’alternativa di qualche appezzamento di peri od albicocchi, tanto che in occasione della fioritura primaverile la valle in questa zona si colorava come una tovaglia multicolore a scacchi.
D’estate poi il Merula, essendo terreno ideale per gli oleandri che vi radicavano favorevolmente, diventava un enorme serpentone rosa, talmente suggestivo da regalare alla valle il tipico appellativo di “Valle degli oleandri” al punto che arrivavano anche gli inglesi da Alassio per ammirarlo e fotografarlo e non era raro vedere qualcuno con tavolozza e colori intento a ritrarre il paesaggio sulla tela.
Quaglia adorava questi panorami che lo rilassavano ricordandogli il tempo trascorso in campagna durante l’infanzia e se li gustava osservandoli dal terrazzo della villa, ma c’era ancora qualcosa che non lo soddisfaceva pienamente e quel qualcosa era rappresentato dalla casa stessa.
Giunto a questo punto della propria esistenza vuole farne una vera e propria residenza lussuosa, un luogo dove si possa riposare con tutti i comfort possibili ed anche dove poter ricevere ed alloggiare degnamente amici, potenti e dignitari. Pertanto chiama fior di architetti e fa riammodernare la residenza dentro e fuori.




E’ così che sia la villa padronale che le costruzioni di servizio assumono l’aspetto attuale.

Il cortile della Villa.
Foto Ovidia Siccardi e Mario Vassallo
Il palazzo viene finemente decorato conferendogli una marcata impronta neoclassica tanto nelle decorazioni esterne, a lesene con capitelli d’ordine ionico e festoni a movimentare l’austero blocco delle murature, quanto nei pregevoli affreschi interni, i quali, nel segno di una forte unitarietà tra elementi esterni ed interni, sono ispirati al culto dei monumenti classici o a riquadri incornicianti semplici paesaggi.

La facciata d'ingresso della Villa.
Foto Ovidia Siccardi e Mario Vassallo
La colorazione rosata tipicamente ligure arricchita da fregi neoclassici stile impero la eleva quindi ad un livello di dignità architettonica accostabile ad altre più famose ville presenti nel genovesato e questo estremamente raffinato livello qualitativo la rende senza dubbio l’edificio civile più rappresentativo e prezioso dell’intera Val Merula.


Fregi e decorazioni della Villa.
Foto Ovidia Siccardi e Mario Vassallo
Anche la foresteria che si trova sul retro e l’abitazione di servizio per il personale vengono ristrutturate, ampliate e dipinte in tinta con il palazzo, il cui piazzale retrostante viene chiuso creando così una corte interna.

Foto dell'autore.
Rielaborazione a colori - Mario Vassallo
Se il novello Conte ha a cuore la residenza, la novella Contessa ne ha altrettanto per il giardino che diventa un vero e proprio parco; infatti lo amplia notevolmente creando nuovi vialetti, aiuole e prati, in cui fa mettere a dimora piante e fiori in quantità.

La contessa Tina.
Foto dell'autore.
Rielaborazione a colori - Mario Vassallo
Se il marito desidera accogliere come un piccolo monarca i propri ospiti, lei non vuole essere da meno e vuole ricevere le consorti degli ospiti, oppure le proprie amiche, come una reginetta passeggiando nel verde e tra i fiori.

Il giardino della Villa.
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora
Rielaborazione a colori - Mario Vassallo
Ovunque sono creati punti atti al riposo ed alla conversazione mediante la sistemazione di tavoli e panchine.
Viene realizzato un bellissimo agrumeto con aranci, limoni e mandarini che è un vero gioiello sull’esempio di quelli francesi del secolo precedente.
Al limitare del bosco viene realizzato anche un laghetto nel quale si trovano pesci e si possono pescare le trote.
Anche l’ingresso del viale che dà sulla strada provinciale viene arricchito dalla presenza di quattro bei pilastri in pietra a vista adibiti al sostegno della cancellata due dei quali sorreggono un elegante arco, sempre nella stessa pietra a vista, completato da un tettuccio in legno.
Veramente una cosa di classe e buongusto che anch’io ebbi la fortuna di poter ammirare personalmente quando ero ancora in età prescolastica. Peccato che un bel giorno, anzi un brutto giorno, un camionista, che stava tornando giù per il viale dopo aver scaricato un carico di letame in un campo adiacente il viale stesso, non si curò che il ribaltabile del cassone fosse sceso completamente e così, passandovi sotto danneggiò seriamente sia il proprio camion, in maniera pur sempre riparabile, sia l’arco, in maniera irreparabile, tanto che non fu mai più restaurato, ma anzi venne demolito completamente…..
Il periodo di maggior splendore di Stampino è proprio dopo il restyling avvenuto a metà anni ’30. Infatti se prima il nostro armatore vi soggiornava saltuariamente ora vi ritorna tutte le estati per il tradizionale periodo di ferie estive e non solo.

Il “novello Conte” Quaglia con la consorte, la contessa Tina sulla terrazza della villa.
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora
Rielaborazione a colori - Mario Vassallo
Eccellenti gli ospiti: professionisti ed imprenditori di rango, onorevoli e senatori, uomini di governo di peso come il già citato Costanzo Ciano oppure il ministro degli esteri Dino Grandi la cui moglie soggiornerà per un certo periodo da sfollata di lusso nella sua residenza di Diano Castello durante l’ormai prossima nuova guerra.
Insomma l’Avvocato Commendatore Conte Giovanni Quaglia, che per amici ed intimi rimane sempre e comunque “U Sciù Giuvanni”, si è oramai costruito il proprio piccolo fantastico regno e lui ne è il piccolo re con tanto di piccola regina e piccola corte.
Il suo ritorno ciclico ad Andora poi è un avvenimento atteso sempre con gioia e trepidazione dalla piccola comunità locale la quale già giorni e giorni prima del suo arrivo si prodiga affinchè ogni cosa sia in ordine e tutto proceda per il meglio e, così facendo, sperare che magari ci scappi pure qualche lauta mancia, cosa che non di rado avviene.
LA CORTE

Il portale di accesso al viale che condiceva alla Villa, ai tempi del conte Quaglia

Il portale di accesso al viale che conduce alla Villa, oggi.
Foto Ovidia Siccardi e Mario Vassallo
L’arrivo del Conte e della Contessa costituivano un vero e proprio avvenimento per la semplice comunità locale, in primo luogo perché il personaggio era veramente importante, un vero signore nel senso assoluto della parola, poi perché arrivava portandosi dietro una piccola corte di fedeli servitori alla maniera dei sovrani ed infine anche perché era solito spostarsi con l’auto e di automobili in giro allora se ne vedevano veramente pochine; fatta eccezione per la “Balilla” di Pietro Galleano “u Grillu” e dell’auto del Dott. Caviglia un po’ più tardi, ad Andora non se ne vedevano altre o quasi.


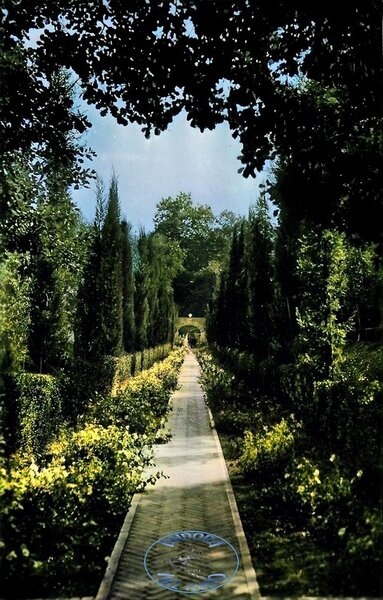



L’unico motore a scoppio abituale quotidiano che si sentiva era quello della corriera di linea del “Grillo”, per l’appunto Pietro Galleano, che faceva servizio lungo la valle. Non da ultimo, quando si spargeva la voce dell’imminente arrivo di Quaglia, cominciava a scaldare i motori anche tutta una piccola schiera di vari parassiti e tirapiedi che confidavano solamente nella generosità del nostro uomo onde poter sbarcare il lunario in maniera un po’ più dignitosa, come vedremo meglio più avanti.
Arrivava alfine il giorno in cui si udiva rombare un’auto di grossa cilindrata lontano sullo stradone bianco e una nuvola di polvere faceva da corona alla grande auto scura pilotata dal fido autista Renato, dentro la quale sui sedili posteriori sedevano impeccabili i due consorti.
I lavoranti che si trovavano nei campi accorrevano per osservare più da vicino quel mezzo inusuale ed al contempo per salutare festosi da vicino verso l’auto che risaliva il viale sbuffando mentre dall’interno dell’abitacolo “u Sciù Giuvanni” rispondeva chiamando gli uomini e le donne per nome e cognome mentre la Signora più compostamente faceva cenni con la mano inguantata.
Il nucleo storico della servitù era formato da cinque elementi che si riveleranno fedeli anzi fedelissimi per decenni e fino all’ultimo giorno al punto che, tranne Renato, l’unico con famiglia, gli altri quattro rinunceranno addirittura a farsene una pur di rimanere tutta la vita totalmente a servizio. Solo quando la Contessa, ormai vedova, passerà a miglior vita e potranno alfine ritirarsi dal lavoro, decideranno di continuare a vivere assieme in una unica casa comune fino al termine dei propri giorni.
Oltre al già citato autista Renato gli altri erano Athos il maggiordomo del Conte, Ines la cameriera della Contessa, Pasqualina, detta Pasqua, la cuoca e Maria la cameriera di servizio a tavola.
Tra queste cinque figure quella più importante e che spicca per personalità è sicuramente quella di Renato Matteucci, che sia nelle fattezze che nella voce rivela un’incredibile somiglianza con l’allora famosissimo cantante Alberto Rabagliati.
Sposato con la signora Pina e padre della vivace Renata e più tardi del piccolo Angelo va incontro a notevoli sacrifici pur di esercitare il proprio dovere con professione ed al contempo ricoprire il giusto ruolo di padre di famiglia.
Infatti il poveretto, al contrario del resto della servitù che erano tutti singoli, era periodicamente impegnato in continui ed estenuanti traslochi onde poter sistemare la famiglia al seguito, ma nonostante ciò si adattava sempre.

Il viale di accesso alla villa.
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora
Era dotato di grande resistenza e a prima vista incuteva anche una certa soggezione agli estranei, poiché era un omaccione alto e robusto dotato di un vocione stentoreo con tono baritonale che all’occorrenza, quando si trovavano in trasferta, si calava anche nei ruoli di segretario, cameriere, guardaspalle, insomma un vero e proprio factotum nonchè guardia del corpo ante litteram.
Genovese a tutto tondo, pur rivolgendosi “au Sciù Giuvanni” con tutti i riguardi che il ruolo gli imponeva, gli parlava però, anzi si parlavano in genovese stretto e ciò risultava oltre che più efficace nella comunicazione, anche molto utile quando si trovavano all’estero o in presenza di importuni non genovesi in maniera tale che nessun altro potesse comprendere ciò che si dicevano. Nel complesso era una bella figura di uomo, imponente ed elegante al tempo stesso.
Lui e le auto erano una cosa sola: le curava in maniera a dir poco maniacale, soprattutto l’Alfa Romeo di lui e più tardi la Lancia decapottabile di lei.
Passava ore ed ore a lavare e lucidare ed all’occorrenza si improvvisava anche meccanico, elettrauto, gommista soprattutto quando si trovavano ad Andora durante il periodo bellico. Infatti il periodo peggiore lo visse certamente durante la guerra quando per forza di cose i ricambi erano diventati merce rara se non introvabile.
Anche per chi possedeva denaro in quantità era parimenti difficile se non impossibile procurarsi dei pezzi di ricambio oppure la benzina che era più che razionata e la benzina ad un certo punto diventò talmente poca e preziosa che da razionata si trasformò in introvabile a tal punto che l’auto fu modificata e dotata di una piccola caldaia a vapore alimentata da una piccola stufa dentro la quale venivano messe legna e carbone. Il fumo che diffondeva quell’auto così trasformata non era quantificabile, sembrava una piccola locomotiva!

Il parco della villa.
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora
Rielaborazione a colori - Mario Vassallo
Da notare che l’auto così modificata, non avendo sufficiente potenza, non riusciva a percorrere l’ultimo tratto di viale quello più ripido e tortuoso, pertanto Renato doveva parcheggiarla in una fascia a metà salita.
Altre volte se riusciva a prendere il viale a tutta velocità poteva guadagnare qualche decina di metri in più, ma se, all’opposto, la velocità di base era più bassa del solito, poteva addirittura non essere grado di salire nemmeno pochi metri ed allora Renato doveva preventivamente fermarsi in fondo. In questo malaugurato caso, previo armamento di sacrosanta pazienza, scendeva dal mezzo e si recava alle rimesse dove solitamente si trovava al lavoro Marco “Marchin” Bertolino, il quale aggiogava prontamente due potenti cavalli da tiro usualmente adoperati per i lavori di aratura dei campi, i quali venivano attaccati all’auto, che, in cotal guisa, veniva trainata su fino alla villa.
Si poteva così assistere ad una scena a dir poco surreale ed irrituale, in cui si notava l’elegante auto con al volante il compito Renato, impeccabile nel suo abituale completo grigio con camicia azzurra, e sul sedile posteriore il compassato principale venire su lemme lemme fino alla villa trainati da due cavalli con il conduttore a lato.
Altro motivo di sofferenza non secondario durante il periodo bellico era costituito dalla penuria di copertoni e camere d’aria. I testimoni dell’epoca raccontano di un povero Renato quotidianamente sull’orlo di una crisi di nervi, strenuamente e continuamente impegnato a tentare di rattoppare in qualsiasi maniera le già lise e stralise camere d’aria che vulcanizzava ormai più con gli improperi e le bestemmie che con il mastice, camere d’aria che a fine conflitto avevano assunto un aspetto sicuramente più simile a quello della carta vetrata che a quello del tubolare liscio e morbido.
La sua frase ricorrente che roteava nell’aria a mò di tormentone facendola rimbalzare dalle pareti della villa a quelle della foresteria con quel vocione stentoreo era: “U me manca u tenacciu!!!” cioè il mastice e giù un’imprecazione o di peggio ancora.
A volte la sua potente ugola, rubata alla lirica ed impegnata in questi sfoghi istintivi e sanguigni, riusciva a perforare gli spessi muri della villa e a far vibrare i delicati e sensibili timpani della Signora che si trovava in casa, la quale, se si trovava in presenza di qualche amica ospite, con estrema nonchalance, quasi a voler giustificare il suo iracondo autista, bisbigliava a mezza voce: “Oggi Renato mi sembra un po’ contrariato……”
Ma i suoi compiti istituzionali non si esaurivano qui, un altro suo incarico ufficiale più particolare e certamente insolito, che il buon Renato doveva assolvere quando si trovava a Stampino, era quello di andare alla ricerca sistematica di lumache ogni qual volta che il principale glielo ordinava.
Infatti Quaglia per le lumache riservava una vera e propria venerazione. Non appena terminato di piovere, “u Sciù Giuvanni” chiamava Renato e gli pronunciava la fatidica frasetta: “Renato, vanni in po’ a vedde….” E Renato, svestiti i panni dell’autista e, calzati gli stivali con il cesto sottobraccio, si trasformava in un implacabile razziatore dello sfortunato gasteropode.
Le prede venivano poi affidate alle sapienti mani di Pasqua che le trasformava in una leccornia per il palato del padrone, ma la pietanza, ad onor del vero, non era altrettanto apprezzata da parte della Signora e pertanto, quando si trattava di andare a tavola, la circostanza assumeva contorni a dir poco grotteschi.
Infatti allo stesso tavolo da pranzo si potevano osservare ad una estremità la signora Tina che si accingeva a desinare con atteggiamento compito e signorile come sempre e all’altro estremo della lunga tavola “u Sciù Giuvanni”, emulo di Trimalcione, che, prima di tuffarsi letteralmente nella terrina di lumache, si faceva mettere al collo un enorme bavaglio, delle dimensioni più simili a quelle di un lenzuolo che a quelle di un tovagliolo, e, dopo esserselo fatto legare dietro la nuca, poteva dedicarsi al mollusco liberamente senza tema di imbrattarsi e sempre con il medesimo al contempo forbirsi la bocca.
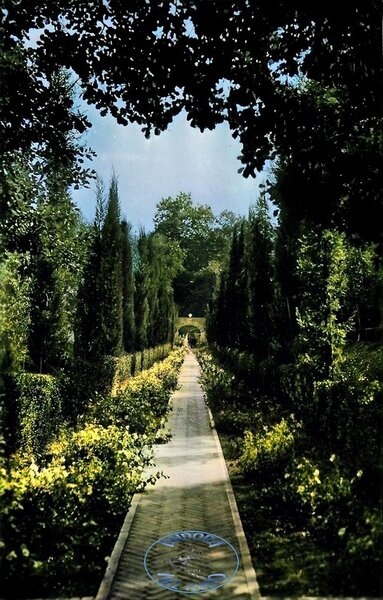
Il viale delle rose.
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora
Rielaborazione a colori - Mario Vassallo
A quel punto la signora Tina, di fronte a tanto scempio comportamentale, non potendo più resistere esclamava:” Giovanni, Giovanni, è una cosa terribile vederti mangiare!”
E lui di rimando in dialetto: “E lascime stò sinque menuti sensa tegnì in certu cumpurtamentu!!”
Al che lei chiamava Maria la cameriera e gli faceva sistemare un paravento davanti in modo tale da occultare la visione di quell’orrore che oltraggiava dalle fondamenta non solo i dettami di monsignor Dellacasa, ma anche ogni forma di galateo più elementare, mentre il consorte impippandosene altamente di ogni formalismo compiva fino in fondo la propria impresa gastronomica.
Al termine della gloriosa battaglia gourmandesca potevano rimanere riversi sul campo anche oltre un centinaio di gusci vuoti che avevano sicuramente contribuito a creare un notevole buonumore al marito, ma non altrettanto sicuramente alla moglie, la quale, decisamente seccata, proferiva “Meno male che non dormo con te”.
Infatti non dormivano assieme in quanto ognuno aveva la propria stanza da letto, ma se la Signora da un lato provava così tanta repulsione nei confronti di certe performances gastronomiche del marito, dall’altra però chiudeva un occhio ed a volte anche due riguardo la presenza ovunque dei loro due cani da compagnia Brik e Natia, che lei inconsciamente considerava e teneva alla stregua di due figli dato che non ne avevano avuti.
Questi erano due fox-terrier di ridotte dimensioni ed erano liberamente ammessi in tutta la casa compresa la cucina e la sala da pranzo dove partecipavano attivamente al desinare senza che alcuno potesse trovare alcunché da ridire su questo fatto, men che meno la loro padrona così ligia alle regole del galateo.
Entrambi i cani poi, al contrario di quelli da guardia, cani plebei e senza pedigree come i poveri ed umili Flock e Melampo, che naturalmente vivevano e dormivano in cucce sistemate fuori della villa, alla notte dormivano con i propri padroni ognuno sul letto del proprio preferito, Brik stendendosi sul proprio lenzuolino azzurro e Natia rosa.
Ma nonostante tutta questa domesticità anche questi cani rimanevano per natura pur sempre dei cani dentro di sé e quando avevano occasione di uscire di casa si comportavano da tali quali erano coltivando ognuno dei due i propri istinti e passioni.
Brik era assolutamente il terrore dei gatti del circondario e, se ci arrivava, si rivelava un killer implacabile e senza pietà, mentre Natia si dedicava alla caccia dei topi. Oltretutto non si limitava a prenderli, ma, per far bella mostra di sé, li portava pure a casa, cosa che inorridiva letteralmente la Signora la quale la sgridava come si sgrida un bambino che abbia commesso una marachella. Ma non era tutto dato che, se capitava l’occasione, Natia andava ben oltre dal momento che, trovandosi la villa situata tra le campagne ed il bosco, luoghi dove era naturale che a volte i contadini ed il personale di servizio facessero i propri bisogni un po’ dove capitava, allora, se durante il suo girovagare per campagna e bosco Natia trovava qualcuno di questi reperti, era assolutamente sicuro che si comportasse proprio alla maniera di tanti altri cani meno nobili e di razza e, dopo essercisi rotolata sopra con massimo diletto, se ne tornava a casa trionfante col suo candido manto non più tanto candido ed ancor meno profumato.

Viale degli agrumi.
Codeste gioie canine, incomprensibili per noi umani, si trasformavano poi automaticamente in altrettante controgioie e maledizioni umane, forse parimenti incomprensibili per i cani, da parte di Maria ed Ines le quali dovevano alfine provvedere a lavare e profumare adeguatamente la cagnetta prima di poterla riammettere in alta società.

Ingresso della villa.
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora
Rielaborazione a colori - Mario Vassallo
Questo era il momento in cui l’agreste Melampo, complice il suo basso lignaggio, si prendeva la propria piccola rivincita, poiché, qualora si fosse parimenti comportato, nessuno si sarebbe mai e poi mai sognato di sottoporlo ad altrettanta tortura prima di legarlo nuovamente alla catena della cuccia e, non solo, ma se uno dei due signorini gli fosse capitato a tiro nei rari momenti in cui era slegato, avrebbe dimostrato loro coi denti chi era il vero padrone di casa e dintorni ( sempre caninamente parlando).

Il parco della villa.
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora
Rielaborazione a colori - Mario Vassallo
I PERSONAGGI

U sciù Carlin insieme al Commendatore, la contessa, la piccola Rina e il cane Flock.
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora
Rielaborazione a colori - Mario Vassallo
Chi può facilmente pensare che Stampino fosse frequentato solo da persone di alto rango, come già annotato in precedenza, si sbaglia di grosso. Infatti, oltre ai già citati pezzi grossi, molto più frequentemente vi arrivavano per visite puramente amichevoli, oppure variamente interessate, anche delle persone di estrazione molto più popolare, che svariavano dai vecchi amici di un tempo ai conoscenti, che in vario modo ed a vario titolo andavano semplicemente a richiedere dei piaceri o dei soldi al padrone di casa.
Sicuramente uno dei personaggi più caratteristici ed al contempo simpatici a detta di tutti era “U Sciù Carlìn”.
“U Sciù Carlìn” era un lontano cugino aristocratico di Quaglia che proveniva da Albenga, dotato perfino di titolo nobiliare di marchese, il quale però era caduto in disgrazia a tal punto che non possedeva più il becco di un quattrino. Quando Carlìn veniva a conoscenza che il lontano parente si trovava nei paraggi aggiogava la domatrice al suo cavallino e si precipitava a Stampino con l’unico scopo di qualche lauto pranzo da scroccare e, se il cugino era rimasto particolarmente soddisfatto della sua esibizione cabarettistica, perché no, anche di una mancia del buon ricordo che nei giorni successivi si precipitava a scialacquare in spese voluttuarie o ancor peggio al casinò.
Quando la gente lo vedeva arrivare cominciava a sorridere ancor prima che cominciasse a parlare, servitù compresa, che si dava di gomito presagendo già chissà quali racconti inverosimili avrebbe raccontato sia che fossero del genere d’azione con inseguimenti e sparatorie aventi per teatro la pampa argentina, sia che fossero avventure galanti durante le quali avrebbe ridicolizzato addirittura Casanova (e ciò risultava ancor più incredibile considerato il suo aspetto così dimesso e penoso).
Questi racconti di solito si rifacevano ad una sua esperienza di parecchi anni prima quando costui era emigrato in America a cercar fortuna, con l’intento di far cosa non si capì mai con precisione, forse per tentare di mettere su un allevamento di bestiame nella pampa argentina, ma per sua malasorte di fortuna ne ebbe ben poca, a tal punto che rimase così ripulito nel portafogli che per poter acquistare il biglietto per far ritorno a casa dovette farsi spedire i soldi dal ben più abile e facoltoso cugino Giovanni.
Comunque alla fine della vicenda ancor più grave della debacle economica si era rivelato il fatto che “u Sciù Carlin” era tornato a casa con addosso gli esiti incurabili di alcune pistolettate rimediate in quei luoghi selvaggi a causa della sua incautezza ed approssimazione.
Altro che fortuna, cornuto e mazziato, era riuscito a rimpatriare salvando a malapena la pelle con una gamba ed un braccio offesi per sempre dalle pallottole, ma nonostante ciò il suo abituale ed ottimistico buonumore non ne aveva risentito minimamente e con grande abilità, pari a quella di un politico navigato, aveva saputo rielaborare tutta la vicenda a proprio uso e consumo tirando fuori dal cilindro racconti paradossali e mirabolanti.
Già quando arrivava a palazzo assumeva un fare così disinvolto e disinibito che il vero padrone di casa sembrava lui e non Quaglia. Immediatamente dopo, evidentemente era più forte di lui, iniziava a inanellare racconti talmente improbabili e farciti di balle così grossolane che avevano il potere di scatenare l’ilarità generale. Se qualcuno avesse tenuto il conto delle persone che aveva ucciso nei conflitti a fuoco che aveva sostenuto laggiù ne avrebbe certamente perso il conto, roba alla Tex Willer, per non parlare poi delle donne che aveva sedotto e conquistato…..
Quaglia si divertiva come un bambino ad ascoltare una tale accozzaglia di storie ed aneddoti recitati con maestria da avanspettacolo al punto che non nascondeva assolutamente la propria soddisfazione affermando ripetutamente: “Quando sono con Carlino (così lo chiamava intimamente) io mi diverto un mondo”.E si divertiva veramente e con lui tutti coloro i quali a turno avevano la fortuna di assistere a quelle esibizioni estemporanee.
Manco a dirlo anche in queste situazioni la Signora dissentiva dall’atteggiamento del marito non trovandosi completamente a proprio agio e ogni tanto non riusciva proprio ad esimersi dal riprendere il cugino acquistato: “Ma Carlino per favore…..ora basta , penso che tu abbia parlato e straparlato abbastanza”.
Allora lui proseguiva a parlare, ma a bocca chiusa, un po’ come fanno i bambini quando si divertono a fare cose senza senso, oppure per rimarcare il proprio disappunto quando era arrabbiato si metteva a parlare in spagnolo e terminava il discorso con un usuale e plateale “Mierda!” che ovviamente tutti avevano imparato ad aspettarsi come se fosse un tormentone e che aveva il potere di continuare a scatenare l’ilarità generale.
Però ogni tanto, il nostro sedicente eroe, marchese vero, doveva comunque sottostare a sentirsi rampognare dal cugino conte acquisito che non gliele risparmiava: “Ti sei andau a fò u belinun in America, mia cosa ti l’hai guagnau!” riferendosi all’invalidità fisica rimediata.
Ma lui non se ne faceva nulla dei paternali rimbrotti del cugino e così trascorreva le giornate come un parassita di lusso andando su e giù per le sue proprietà come se ne fosse stato il fratello spostandosi con un calessino trainato da un bel cavallino di nome” Stelin”.
Per onore di verità ogni tanto quel calessino, ad onta del poco feeling che ci poteva essere tra i due, tornava comodo anche alla Signora Tina, la quale, usando Carlino come cavalier servente, soprattutto in tempo di guerra quando la benzina era razionatissima e d’estate con il bel tempo, si faceva trasportare ad Andora Marina a svolgere delle commissioni oppure ad Alassio in spiaggia o dalla parrucchiera.
Lui sempre umile, gentile e ubbidientissimo con l’immancabile berretta in testa e lei elegantissima con il vestito bianco ed il parasole rosso.
Stelin trottava e trottava allegro come il suo padrone finchè un brutto giorno verso la fine della guerra i tedeschi ad Albenga non gli requisirono il cavallo e qui praticamente terminò l’avventura du Sciù Carlin e della sua domatrice. Il poveretto ne ebbe un dispiacere incolmabile come se gli fosse morto un congiunto e da allora si fece vedere raramente in villa.
Se da un lato le lumache continuavano a rivelarsi un aspro ed inconciliabile terreno di scontro tra “u Sciù Giuvanni” e la signora Tina non altrettanto però ciò avveniva quando a tavola si trattava dell’argomento uccelletti che, al contrario, risultavano motivo di seria e profonda riconciliazione coniugal-gastronomica tra i due consorti. L’ambasciatore capace di cotanta pax familiare era rappresentato dall’amichevole figura di “Cecchìn u Gumbaiò”.
Cecchìn, che di mestiere faceva il frantoiano ed era anch’egli castellotto, era un vero e proprio esperto di caccia agli uccelletti che solitamente catturava mediante trappe o fili d’erba, detti “buschìn”, ricoperti di vischio, che disponeva in luoghi strategici durante i periodi secchi invernali nei pressi di laghetti o pozze d’acqua lungo i ruscelli laddove era molto probabile se non certo che gli uccellini assetati sarebbero andati ad abbeverarsi.
In effetti bisogna sapere che gli uccelletti costituivano un’altra delle grandi passioni culinarie “du Sciù Giuvanni” e per fortuna sua ed un po’ meno di quelle care bestiole a quel tempo la loro caccia non era ancora stata proibita.
Quando Cecchìn arrivava Quaglia, fremente come un bambino che attende unicamente la fine del preanzo per poter mangiare le paste, lo accoglieva con un: “Alùa ti n’hai ciappàu, ti n’hai ciappàu?”e Cecchìn , sorridente come al solito, apriva il sacco mostrando fieramente la cacciagione e con ciò presagendo già una lauta ricompensa.
Comunque fosse la sua presenza costituiva una certezza, quella che la sera successiva in villa si sarebbe consumata una succulenta cena a base di polenta ed uccelletti che in questo caso possedevano il potere di allietare anche le esigenti e raffinate papille gustative della Signora….. e non solo dato che da sotto la tavola ne usufruivano indirettamente pure Brik e Natia.
L’unica persona che al termine della storia non rimaneva entusiasta né delle lumache e tantomeno degli uccelletti era la povera Pasqua alla quale toccavano le lunghe, penose ed elaborate preparazioni di queste piccole povere prede, ma tant’è il sorriso compiaciuto ed i complimenti del padrone di casa valevano la ricompensa per tanta fatica.
Un altro personaggio degno di nota era Pellegrìn l’operaio tuttofare preposto a tutti i lavori di manutenzione alla villa e nella proprietà più in generale.
Pellegrìn viveva a metà del viale in un piccolo alloggio situato a lato delle rimesse.
I suoi compiti potevano svariare da quelli del muratore a quelli dell’idraulico od ancora dell’imbianchino, comunque era soprattutto un muratore e che muratore. Egli era un vero e proprio artista tanto che riusciva a realizzare delle opere talmente valide e ben rifinite cimentandosi in qualsiasi genere di tipo murario tanto da strappare l’elogio dei padroni di casa. Ma come tanti altri artisti oltre ai pregi possedeva anche qualche difetto. Purtroppo il suo difetto maggiore consisteva nella passione per il vino, vino che gli piaceva a tal punto che in certi giorni lo avrebbe usato pure per impastare la calcina, ma per sua fortuna spesso e volentieri ci pensava la contessa in persona a razionarglielo in maniera che non esagerasse troppo.
Un bel giorno, quando Pellegrìn era già anziano, coloro che lo circondavano si resero conto che il vino forse non era il suo unico difetto, ma anche la pulizia e l’igiene personale non costituivano propriamente i suoi cavalli di battaglia.
Infatti quando l’amministratore ed il giardiniere decisero di andare a fargli visita a casa dato che era già qualche giorno che non si vedeva in giro poiché non stava al meglio, costoro ebbero una ben triste ed alquanto pruriginosa sorpresa. I due incauti, non appena furono entrati nel misero tugurio che da anni accoglieva il muratore, furono letteralmente assaliti e quasi sbranati vivi da nugoli di pulci fameliche con le quali Pellegrìn evidentemente conviveva tranquillamente ormai da tempo immemore e con le quali altrettanto evidentemente aveva stipulato un patto di reciproca non aggressione.
L’amministratore ed il giardiniere uscirono di corsa da quell’abitazione urlando a squarciagola come se avessero avuto un mastino alle calcagna e, grattandosi come degli scabbiosi, risalirono immediatamente alla villa dove dovettero spogliarsi all’esterno prima di rientrare in casa e prima di potersi lavare e strofinare ben bene per disinfestarsi dalle pulci.
Della cosa si interessò la Signora personalmente la quale provvide subito a far ripulire l’ammalato ed a farlo ricoverare nella casa di riposo a Diano Castello dove Pellegrìn concluse dignitosamente i propri giorni finalmente orfano delle pulci, ma, purtroppo per lui, anche altrettanto ingloriosamente orfano delle sue tanto amate bottiglie di vino.
LA GUERRA
Dopo solo un ventennio dal primo terribile conflitto mondiale, nuovi e tristi venti di guerra soffiavano nuovamente nel cuore dell’Europa e l’esperienza precedente sembrava non avere insegnato nulla; così alla fine guerra fu di nuovo.


Come la volta precedente anche stavolta noi italiani non ci impegnammo subito, ma attendemmo furbescamente quasi un anno prima di scendere in campo onde poter trarre il maggior vantaggio possibile dalla situazione e sulle prime i fatti sembrarono darci ragione.
Per circa un anno per la popolazione civile la vita scorse quasi immutata nei modi e nelle abitudini anche perché il nemico, colto di sorpresa dai nostri alleati tedeschi, impiegò un po’ di tempo prima di riuscire a riorganizzarsi, ma quando passò alla controffensiva cominciarono i dolori per tutti, non esclusi coloro i quali se ne stavano lontano dal fronte a lavorare per la nazione impegnata in uno sforzo al quale francamente non era preparata.
Anche i Signori Quaglia, seguendo l’andamento delle vicende belliche, sulle prime del conflitto non mutarono granchè stile di vita continuando a risiedere al numero 37 di Via XX Settembre a Genova, ma quando la città iniziò ad essere pesantemente bombardata sia dal mare che dall’aria dalle forze anglo-americane e non fu più ritenuta sicura come era stata considerata fino ad allora, a quel punto decisero di sfollare in campagna come tanti altri comuni cittadini che in tal modo cercavano sollievo e sicurezza dalle bombe. Pertanto per loro fu logico e naturale sfollare in pianta stabile in quel di Stampino e con loro tutta la servitù in blocco Renato compreso, che, essendo l’unico che teneva famiglia, andò a risiedere alla Casa Garotta con moglie e figli.
La signora Tina era rimasta molto scossa dalle bombe, alcune delle quali erano piombate anche sul Teatro Carlo Felice in Piazza De Ferrari, a pochissimi metri dalla sua residenza, pertanto a Stampino cercava di ricrearsi un proprio mondo dove stare in pace e fuggire dalla cruda realtà anche se la storia di lì a poco avrebbe dimostrato che le sue pur giuste e comprensibili aspirazioni si sarebbero dimostrate oltremodo utopistiche.
Nella sua mente la residenza andorese avrebbe dovuto essere un’oasi di tranquillità e pace assoluta dove anche i fiori avrebbero dovuto splendere tutto l’anno e per ottenere ciò richiese al marito che assumesse un giardiniere valido ed esperto a tempo pieno.
“U Sciù Giuvanni” sparse la voce se in giro ci fosse qualcuno atto alla situazione e disponibile a ricoprire quel ruolo.
Siccome allora i paesi erano veramente piccoli e si conoscevano tutti, ma proprio tutti, sia dentro che fuori gli stessi, dal paese natale il vecchio amico Tugnìn gli segnalò un tizio che se ne intendeva abbastanza di floricoltura e che in quel momento lavorava alla Madonna della Rovere di Cervo per conto del Sig. Pizzorno di Genova.
Quel tale si chiamava Giovanni Volpara ed era mio nonno paterno.
Nato in una cascina situata nelle campagne di Gavi Ligure e primo di ben nove figli, cosa che contribuì notevolmente a responsabilizzarlo precocemente, dopo aver terminato le scuole avendo frequentato “ addirittura” per quei tempi la sesta elementare, era poi andato a servizio come garzone in un vivaio di Novi Ligure dove aveva iniziato ad apprendere gli insegnamenti della florovivaistica appassionandosi all’argomento e divenendo in breve tempo esperto in impollinature, innesti, potature e giardinaggio in genere.
A diciotto anni era partito per il fronte ed aveva combattuto la Grande Guerra, militando in un reparto del Genio, riuscendo quasi miracolisticamente a tornarne indenne, considerato che per ben due volte gli caddero letteralmente sulla testa delle granate di mortaio. Per sua ed altrui fortuna non esplosero, vuoi perché la prima volta era inverno e c’era la neve che ammortizzò l’impatto sul tettuccio sotto il quale si riparava nella trincea, vuoi perché la seconda volta, sebbene la granata si fosse conficcata a pochi metri di distanza, non ne volle proprio sapere di esplodere, fatto sta che riuscì ad uscirne indenne.

Da sinistra Giovanni Volpara, la moglie Giuseppina, i figli Rina e Giorgio.
Rielaborazione a colori - Mario Vassallo
Una volta terminato il conflitto era tornato a lavorare nella cascina di famiglia e qualche anno dopo, tramite un cugino di Genova, in quella città aveva conosciuto una ragazza di nome Giuseppina, proveniente dall’Oltrepò, che prestava servizio presso una facoltosa famiglia genovese. Si erano piaciuti e, dopo una breve frequentazione, l’aveva sposata divenendo subito papà di Giorgio, mio futuro padre.
Però in cascina erano in tanti e si stava stretti ragion per cui appena si presentò l’occasione decise di seguire una strada tutta propria e quindi nel 1931 colse l’occasione di scendere al mare per andare a lavorare a favore di un signorotto genovese, tal Sig. Pizzorno, che alla Madonna della Rovere di Cervo aveva dei possedimenti terrieri.
Qui si era adattato subito bene a condurre l’azienda che produceva frutta, verdure ed anche fiori. Sempre qui era nata la secondogenita, Caterina, detta anche Rina o Rinetta che si era presto rivelata una bambina vivace e sveglia al limite dell’intriganza, caratteristiche che le avrebbero poi permesso di entrare in possesso di molti segreti della villa.
Quando Giovanni ricevette il contatto e l’offerta da parte di Quaglia, considerate brevemente la levatura del personaggio, la prestigiosità dell’incarico e non da ultimo che la paga sarebbe stata più gratificante, non gli parve nemmeno vero e non se lo fece ripetere un’altra volta: era veramente l’occasione della vita!
In precedenza si era adattato di buon grado a fare il contadino, ma la sua passione vera rimaneva indubbiamente il giardinaggio, che lo appassionava oltremodo ed in cui era sicuramente valido ed esperto.
Io ebbi modo di convivere al suo fianco pochi anni, poiché quando lui morì prematuramente non avevo ancora nove anni compiuti, però ricordo con precisione ed infantile stupore che di ogni pianta ornamentale conosceva sia il nome volgare sia quello scientifico in latino pur non avendo minimamente studiato il latino: insomma più che una passione!
Nonno Giovanni non si fece ripetere la proposta una volta di più, fece di nuovo fagotto con tutta la famiglia, e nell’ottobre del 1942 approdò ad Andora entrando a far parte della corte du Sciù Giuvanni e della signora Tina.
Andò a sistemarsi nella casa adibita al personale di servizio che si trova a lato del portone d’ingresso della corte interna della villa e si diede subito da fare, entrando ben presto in sintonia sia con i nuovi padroni che con il resto del personale, legando in modo particolare con Renato ed il giovane aiutante giardiniere Ernesto Bonifacino.
Mio nonno, che da questo momento in poi per comodità narrativa chiamerò semplicemente Giovanni, aveva l’incarico di accudire i giardini della villa coadiuvato da altri collaboratori quale appunto il giovane Ernesto. Poco dopo il suo arrivo, essendo sopraggiunto proprio quando la guerra e le privazioni si stavano inasprendo, si ritrovò altresì impegnato in un genere di lavoro alquanto singolare e cioè quello dell’occultamento dei generi di prima necessità e per generi di prima necessità si intendeva soprattutto generi alimentari.
Anche a Stampino, come in tutte le case italiane che potevano permetterselo, si cercava infatti di mettere da parte e nascondere in vario modo prodotti alimentari di ogni genere.
E’ noto che durante la guerra i contadini dovevano conferire tutta la produzione all’ammasso statale e solo in un secondo tempo avrebbero poi ricevuto la propria parte, ma è altrettanto risaputo che nessuno lo faceva al cento per cento poiché ognuno tratteneva per sé una certa quantità prima di depositare all’ammasso per due semplici motivi: il primo per poter ovviamente disporre di una maggior abbondanza ed il secondo per potere, con la quantità in eccesso, fare scambi al mercato nero onde ottenere beni altrimenti difficili da reperire.
Nella tenuta di Stampino si producevano soprattutto frutta d’estate ed ortaggi d’inverno, ma onde poter essere maggiormente autosufficienti Quaglia aveva dato ordine di differenziare la produzione destinando parte del terreno a seminativo cereale; in tal modo aveva fatto seminare il grano sui terreni che si trovavano tra la villa e la chiesa di San Giovanni. Il grano veniva poi portato a macinare col carro a Stellanello dove c’era un mulino che serviva buona parte della produzione della vallata dal momento che tutti coloro che possedevano abbondanza di terreno coltivabile ne avevano riconvertito una parte a cereali per non correre il rischio di ritrovarsi senza pane sulla tavola.
Pertanto anche a Stampino si diede ordine di nascondere ogni ben di dio secondo le metodiche più classiche e comuni al tempo.
Vennero riempite decine di damigiane di farina, granaglie, fagioli, vino assieme a latte d’olio, casse di biscotti, te, caffè, zucchero, sale e tonno in scatola. Vale la pena ricordare che il Conte in Sardegna possedeva anche una ditta che si occupava della lavorazione e messa in scatola del tonno, “Tonno Artiglio” , ditta che portava appunto il nome della sua arcifamosa nave recupero. Proprio per questo motivo le casse di tonno in scatola non si contavano ed il menù più ricorrente era proprio a base di tonno: tonno e fagioli, tonno e patate bollite, tonno e pomodori, tonno con contorno di tonno…..
Di queste operazioni si occuparono un po’ tutti gli esponenti della corte a cominciare dalla servitù che, per naturale uso quotidiano, doveva sapere bene dove mettere le mani quando doveva servirsi di ciò che era necessario in cucina. A seguire anche coloro che più genericamente abitavano a Stampino, ivi compresa la mia famiglia, poiché la comunità si considerava come un’unica grande famiglia allargata.
Per giorni e giorni si scavò e molto non solo per sotterrare tutto ciò, ma anche per occultarlo in superficie nel migliore dei modi.
La cosa richiedeva un lavoro non da poco, poiché se da una parte le casse metalliche erano resistenti per natura, dall’altra le damigiane di vetro risultavano estremamente fragili e quindi bisognava adottare tutta una serie di accorgimenti e precauzioni particolari onde evitare che durante il dissotterramento potessero essere frantumate con la conseguente perdita del prezioso contenuto. Allo scopo si usava una tecnica che prevedeva prima di tutto lo scavo di una fossa comune entro la quale venivano calate le damigiane vuote tutte in fila, che venivano riempite solo in un secondo tempo quando erano ormai a posto, indi sopra le stesse venivano poste delle fascine di vite con la funzione di cuscinetto e al di sopra di queste ultime dei teli ed infine solo a questo punto il tutto era ricoperto di terra.

Luglio 1943. Raccolta del grano. Il Commendatore insieme a Giovanni Volpara (a destra) e Vittoria Garassino (a sinistra) e gli altri aiutanti.
Rielaborazione a colori - Mario Vassallo
Pellegrìn, dall’alto della sua ars maestrandi, conduceva le operazioni in prima persona scavando, spiegando e dando continuamente consigli ai collaboratori. Al giardiniere Giovanni spettava infine il grazioso tocco finale di posizionare qualche pianta o fiore sopra lo scavo con lo scopo di dissimulare la terra smossa. Quando passava a livello di quelle originali sepolture indicando certe piante mormorava: “Qui c’è la pianta dell’olio, qui c’è la pianta dello zucchero….”.
Ma nonostante tutte queste precauzioni avvenne ugualmente che, durante un dissotterramento, una damigiana contenente vino si rompesse ed il vino colò nel terreno.
“U Sciù Giuvanni” liquidò il fatto con un lapidario “amen”, ma chi ne ebbe un dolore veramente insanabile fu Pellegrìn il quale portò il lutto per un mese manco quella damigiana fosse stata sua.
I VALORI
Se in una casa per così dire “ normale” il problema dell’occultamento della roba in quel particolare periodo storico si poteva limitare agli alimentari, ai medicinali essenziali oppure al massimo a qualche gioia di famiglia, a Stampino il problema non poteva porsi in termini così semplici e ristretti perché, una volta terminati i lavori di messa al riparo del cibo, se ne poneva un altro non meno importante ed ancor più delicato e riservato che consisteva nella messa in sicurezza di tutti i valori personali dei signori che si trovavano in villa: soldi, gioielli, sterline d’oro, perfino lingotti d’oro!
Un vero e proprio tesoro della cui esistenza i collaboratori stretti dei signori erano ovviamente a conoscenza, ma che nessuno mai prima di allora aveva visto e ammirato nella sua interezza o avrebbe potuto quantificare.
In questo caso più che dal personale di servizio la vicenda fu gestita dalla signora Tina in persona che godeva della completa ed illimitata fiducia da parte del proprio marito.
Sicuramente la messa in sicurezza di questi beni non avrebbe comportato un dispendio di mezzi ed energie tale come l’operazione precedente. Si trattava tuttavia di un’operazione ancor più delicata e piena di insidie dato che i padroni di casa non sarebbero mai stati in grado di portare a termine l’operazione da soli. Pertanto, dovendo forzatamente avvalersi dell’aiuto di qualche collaboratore, per ragioni di massima sicurezza bisognava restringere al massimo il numero delle persone a conoscenza dei fatti. Meno occhi avessero visto e saputo i vari luoghi dove erano state nascoste così tante ricchezze, maggiori sarebbero state le probabilità di successo dell’operazione.
Quindi, la signora Tina avrebbe dovuto individuare una persona di massima fiducia a cui affidare l’occultamento e la custodia di tutti i valori di famiglia e dopo le opportune riflessioni individuò nel giardiniere Giovanni l’uomo che avrebbe dovuto aiutarla a portare a termine l’operazione.
Mio nonno Giovanni non apparteneva al nucleo storico della servitù, dato che era arrivato a servizio da poco tempo, però egli possedeva due qualità determinanti: in primis la totale fiducia da parte dei padroni, che aveva saputo conquistarsi in breve tempo alla pari degli altri più anziani di servizio, e poi possedeva anche la perfetta conoscenza di ogni angolo della proprietà. In qualità di capo giardiniere sapeva bene dove il terreno poteva prestarsi meglio ad uno scavo, dove si poteva meglio mascherare una cassa sotterrata, quali muri a secco si prestavano ad essere demoliti e ricostruiti in poco tempo dopo che al loro interno si era nascosto qualcosa e, soprattutto, sapeva far ciò molto celermente e con l’abilità di chi riesce a non lasciare tracce. In più egli non abitava nel palazzo, ma in una anonima casa di servizio anche se ubicata a pochi metri dalla residenza dei signori e ciò era una sicurezza in più, tanto per depistare eventuali malintenzionati, quanto per i padroni che potevano controllare tutto con discrezione.
Si iniziò con i gioielli della signora Tina che furono addirittura murati in un sottoscala dell’abitazione stessa di Giovanni.
La casa possedeva una scala interna che permetteva di salire dall’ingresso, posto al pianterreno, alle camere da letto situate al primo piano.
Gli scrigni contenenti anelli con brillanti, braccialetti d’oro, collane a più giri di perle naturali, diademi vari, il cui valore oggi ammonterebbe a milioni di euro, furono posti in quell’incavo angusto e triangolare che si trovava sotto la scala dopodiché lo spazio fu fatto sparire rasandolo con una sottile parete in muratura.
Per l’opera muraria stavolta non fu chiamato Pellegrìn, che era senza dubbio alcuno un onestuomo, ma possedeva quel vizietto di cui sopra e, si sa, a volte il vino fa cantare e non solo le canzonette, ragion per cui lo fece Giovanni in prima persona, che provvide a sistemare personalmente i mattoni con la calcina e a rasare il tutto intonacando con il cemento. Da ultimo, onde dissimulare meglio la cosa, fu ritinteggiata anche tutta la stanza: proprio un bel lavoro alla fine del quale il sottoscala non esisteva più.
Se coloro i quali di lì a non molto sarebbero venuti a risiedere in quella casa avessero saputo….., ma andiamo con ordine.
Si passò quindi ai soldi ed alle sterline d’oro che furono sistemati in apposite casse a prova di infiltrazione idrica. Queste invece furono interrate proprio in aperto giardino, ma pur sempre in posti strategici e molto a portata di mano, poiché i soldi servivano quasi quotidianamente.
Doveva essere veramente singolare vedere Giovanni oppure Renato che usufruivano di quei particolari bancomat ante litteram; facendo bene attenzione di non essere osservati da occhi indiscreti si recavano dentro un’aiuola, prendevano una certa piantina per la chioma e tirandola fuori dal terreno scoprivano la cassetta dalla quale facevano il singolare prelievo ritirando il contante necessario.
Bisogna ricordare che Quaglia non recava mai denaro con sé, ma se lo faceva portare sempre e solo dal fido Renato, uno dei pochissimi a conoscenza di tutti nascondigli. In questa abitudine aveva preceduto l’allora giovanissimo Avvocato Giovanni Agnelli.
Infine fu la volta del grosso del malloppo costituito dai lingotti d’oro, milioni e milioni di euro al valore attuale!
Anche questi furono riposti in apposite casse e furono tumulati, ma non all’aperto. Per essi si studiò una soluzione originale e cioè sotterrarli nella serretta che si trovava appena sotto il vialetto delle rose ad un centinaio di metri dalla villa, serretta che fungeva da vivaio ed allo stesso tempo da ricovero invernale per le piante più delicate.
Qui Giovanni scavò una buca entro la quale furono calate le pesanti casse che, non solo furono ricoperte di terra, ma una volta ben battuta la stessa anche da una colata di cemento.
Praticamente i lingotti stavano in un bunker; Stampino aveva il suo piccolo Fort Knox! A far buona compagnia a loro fu pure riposta una bella statuetta ricoperta d’oro raffigurante un putto che si trovava abitualmente nell’ingresso della villa e che era stata conferita dal governo a Quaglia, oltre alle varie onorificenze, come riconoscimento tangibile dopo l’impresa dell’Egypt.
Oggigiorno forse si fa fatica a comprendere tanta diffidenza e cautela, ma, considerati i tempi, era meglio non fidarsi affatto ed infatti i tempi di lì a poco avrebbero riservato amare sorprese a tutti indistintamente.
Giovanni, per parte propria, pur non essendo il padrone di cotanta fortuna, sentiva fortemente il peso di tanta responsabilità ed era più preoccupato dei legittimi proprietari ed a testimonianza di ciò erano più le notti che trascorreva in bianco di quelle in cui si concedeva un sano sonno ristoratore. Ogni più piccolo rumore lo faceva sobbalzare ed alzare di soprassalto. Continuava a rigirarsi nel letto in preda all’agitazione mentre Giuseppina se la voleva dormire placidamente come se nulla fosse. Questo contrasto di atteggiamenti creava dissapori se non veri e propri litigi notturni tra la moglie, che voleva dormire, ed il marito, il quale rimproverava alla consorte di non capire la grandezza della responsabilità alla quale si era prestato. Se Giuseppina poi, niente niente osava scherzare sulla particolare situazione creatasi ed azzardava dirgli “Non sei contento? Siamo diventati finalmente ricchi!”. Allora Giovanni le digrignava a denti stretti “Stà sitta, ti nu capisci in belìn! Basta che ti dixi de belinate!”. Al che lei si girava sull’altro fianco e con estrema tranquillità gli suggeriva un serafico “Dormi!”
IL 1943
Il proposito di realizzare un libro sull’armatore Giovanni Quaglia non è stato una decisione facile ed ancor meno presa d’impulso, ma è il prodotto di lunghi anni di riflessioni e considerazioni personali. Sono arrivato a questa conclusione in seguito ad una valutazione critica di fatti e persone, senza dare nulla per scontato o per assunto come mi hanno insegnato i miei ormai lontani, ma sempre validi, studi liceali.
Se a questi fattori aggiungiamo che ho sempre posseduto un’altrettanto grande passione per la storia, intesa sia in senso generale che più ristretto a livello locale, arrivo al punto che tanto mi sta a cuore e che mi ha spinto a scrivere questo libro su Giovanni Quaglia. Molto probabilmente alla maggioranza della popolazione contemporanea questo nome dirà poco o nulla addirittura, ma negli anni trenta del secolo scorso fece il giro del mondo alla stessa stregua di quello dei potenti di turno, oppure dei divi del cinema.
E’ strano davvero che una persona di tale grandezza imprenditoriale ed umana non abbia mantenuto nel corso del tempo memoria e riconoscimento adeguati da parte delle autorità e dei media nazionali ed a livello locale abbia rischiato, se non proprio l’oblio, quanto meno di cadere nell’anticamera del dimenticatoio. Non un francobollo celebrativo, non una manifestazione commemorativa seria in occasione di un anniversario a cifra tonda. Nemmeno gli organi di informazione liguri si sono mai sprecati in occasione delle ricorrenze che riguardassero tanto lui personalmente, quanto le sue imprese. Al massimo solo qualche piccola manifestazione a livello ultralocale o qualche trafiletto sui giornali.
A Viareggio, patria indiscussa di impareggiabili, per certi versi eroici palombari, già da parecchi anni hanno realizzato una fondazione denominata “Artiglio Europa” con tanto di premio da attribuirsi a chi a livello internazionale si è distinto nell’opera di esplorazione sottomarina.
Sempre a Viareggio hanno inoltre realizzato un museo della marineria intitolato ad Alberto Gianni, mitico maestro della palombaria italiana e mondiale.
Tutto ciò va ad onore dei viareggini e di tutti coloro che non vogliono che la memoria collettiva si perda, anche se costoro hanno voluto campanilisticamente ricordare i soli meriti dei propri conterranei dimenticandosi un po’ chi contribuì in maniera decisiva a rendere così grandi ed imperituri quei palombari stessi.
Ma in Liguria abbiamo saputo fare altrettanto con il più grande armatore-recuperatore sottomarino di tutti i tempi che tanto onore e gloria seppe conferire all’Italia nel mondo?
Purtroppo, e lo dico con una punta di rammarico, non mi risulta altrettanto né a Genova, né nel ponente ligure più in generale, considerando che costui fu tanto nativo di Diano Castello, quanto risiedette per quasi tutta la vita a Genova, città dove ebbero sede le sue società.
Forse questo atteggiamento può essere imputato al tradizionale pudore ed al carattere schivo ed elusivo della gente ligure, la quale notoriamente tende a fuggire dai riflettori delle scene e raramente ha il coraggio di tributare i dovuti onori a chi della propria gente ha dimostrato veramente di meritarlo.
Per motivare questa patina di oblio potrebbe essere anche chiamata in causa l’altrettanto arcinota ingratitudine dell’Italia matrigna che non sa essere riconoscente verso i propri figli migliori, proprio quelli che le sanno conferire vanto e prestigio a livello mondiale.
Inoltre, non avendo egli lasciato eredi, si è perso il filo conduttore generazionale familiare ed anche questo fattore potrebbe aver inciso in maniera negativa sulla memoria collettiva alla pari del fatto che la sua flotta recuperi, essendo stata prettamente una sua creatura, commercialmente parlando, morì anch’essa appena dopo la sua morte.
Comunque al di là di queste potenziali attenuanti, penso che il mondo dell’informazione e della storiografia italiana, che non ha esitato a conferire il giusto tributo nei confronti di altri personaggi, magari neppure italiani, sia ancora fortemente in debito nei confronti di questa persona che molto ha dato sia in termini di prestigio, che in termini umani.
Anche il mondo della televisione e del cinema, sempre alla caccia di fatti e personaggi a cui attingere per le proprie produzioni, non si sa come abbia potuto trascurare, se non proprio dimenticare, fatti di cronaca così epicamente appassionanti realizzati da un uomo che gli anglosassoni non avevano esitato a definire “attractive”, dove il termine attractive sta si per attraente ma significa anche interessante ed appassionante.
Oggi molti giovani ed anche meno giovani, liguri e non, poco o nulla sanno degli avvenimenti che videro protagonista l’Avvocato Giovanni Quaglia, il quale con le imprese dei propri marittimi e dei propri palombari seppe stupire il mondo intero, marinaresco e non, ricevendone in cambio un prestigio ed un’ammirazione profonda e sincera al punto che, per anni all’estero, risultò essere l’italiano più famoso e rispettato di chiunque altro nostro connazionale.
Ora sembra che qualcosa finalmente stia muovendosi anche da noi, poiché il nuovo Museo Navale di Imperia ha riservato un ampio spazio dedicato proprio alla società dell’armatore castellotto, dove si possono ammirare reperti originali appartenuti alla sua flotta nonché attrezzature varie atte al lavoro di recupero sottomarino.
Speriamo quindi, che tra non molto si possa rendere il giusto onore, storicamente parlando, ad un grande della nostra terra che ha saputo rinnovare in epoca moderna ed in maniera sui generis i fasti dei grandi uomini di mare liguri.
L’Avvocato Quaglia non è stato certamente andorese di nascita, ma la sua quarantennale presenza sul nostro territorio, avendo risieduto nella villa di Stampino, seppur non in maniera continua, è stata comunque più che importante, per non dire influente, sia a livello economico lavorativo che storico sociale e proprio per questi motivi gli può ben valere la cittadinanza onoraria.
Questo scritto non ha la pretesa di essere una biografia né tantomeno un’ulteriore narrazione delle imprese compiute dai suoi intrepidi equipaggi, a suo tempo già state meravigliosamente descritte da altri autori ben più autorevoli del sottoscritto, ma vuole essere solo un omaggio alla sua persona, che fu presente e residente per molti anni in seno alla nostra comunità.
E’ mia intenzione presentarne un ritratto inedito e più ampio sotto il profilo umano, arricchito dal racconto di aneddoti a lui relativi con il contorno di vicende che si intrecciano con quelle relative alla mia famiglia, nel contesto storico, sociale e paesaggistico dell’Andora di quei tempi.
Per ottenere ciò, oltre ai già noti racconti di famiglia ed alla collaborazione di tanti amici, mi sono anche impegnato nell’opera di recupero della memoria degli ultimi testimoni di quel tempo, che ebbero modo di conoscere ed apprezzare quell’uomo.
Ho così messo sotto torchio ed ho spremuto ripetutamente, spero non me ne vogliano più di tanto, un gruppetto di arzilli vecchietti che, devo riconoscerlo con profonda gratitudine, hanno sempre attivamente collaborato alla mia opera con grande entusiasmo e talora con incitamenti e altrettanto validi suggerimenti.
A tutti, giovani e meno giovani, va il mio più profondo riconoscimento per l’indispensabile contributo apportato. Una citazione particolare e’ per i miei insostituibili e fantastici senatori alcuni dei quali, complice l’età avanzata, da quando iniziai a raccogliere le informazioni molti anni fa, purtroppo non sono più tra di noi e non hanno potuto vedere realizzato questo lavoro al quale hanno personalmente contribuito.
E’ pertanto a loro che va il mio primo pensiero ed ad un paio in particolare, primi inter pares, se mi è consentito.
Per ragioni affettive il primo è mio padre, che, quando gli manifestai la mia intenzione solo pochi mesi prima della sua dipartita, contribuì in maniera decisiva a scrollarmi di dosso le ultime esitazioni dandomi l’impulso affinchè tutti quei ricordi di famiglia e della comunità non andassero perduti e così impugnai carta e….. coraggio e decisi di mettere tutto per iscritto.
Il secondo, per ragioni storico testimoniali, è il signor Francesco Tagliatini, ultimo esponente rimasto dell’equipaggio dell’Artiglio, che ebbi l’onore ed il piacere di incontrare nella sua casa di Diano Castello durante un piovoso pomeriggio invernale. Con lucidità e chiarezza d’espressione disarmanti, ad onta dei suoi novantanove anni, mediante poche ed efficaci parole in pochi minuti seppe trasportarmi indietro di ottant’anni facendomi rivivere l’epica impresa dell’Egypt, quasi come se si fosse trattato di guardare un film. Chapeau!
Un ringraziamento particolare a voi tutti poiché siete stati e continuate ad essere la memoria storica della comunità perché, come disse il grande Indro Montanelli
“Un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente ed è un paese senza futuro.”
UNA VISITA INSPETTATA
Dopo l’8 Settembre, essendo venuta meno l’alleanza militare italiana coi tedeschi, come prima conseguenza questi ultimi occuparono tutti i centri di interesse militare strategico della penisola.

Anche Andora non sfuggì alla regola. Già durante il periodo precedente molte truppe italiane stazionavano in attesa nei vari alberghi e colonie marine andoresi, poiché si era nelle immediate retrovie del fronte meridionale francese. Poche settimane dopo la fatidica data, dileguatesi anche qui come altrove le nostre milizie in base al passaparola “tutti a casa”, gli stessi alloggi non rimasero sfitti a lungo e furono rioccupati in breve tempo sempre da gente in divisa, ma stavolta si trattava di divise della Wehrmacht.
E così truppe tedesche si erano variamente installate all’Albergo Milano e nelle colonie marine di Cuneo ed Asti dal momento che, essendo ormai sbarcate le truppe alleate in Sud Italia, i Tedeschi temevano un altro sbarco molto più a nord in Liguria e Costa Azzurra.
A testimonianza di ciò costruirono sulla spiaggia un paio di casematte in cemento armato, una dove attualmente si trova il porto, che venne demolita all’inizio degli anni 60’ proprio a causa della costruzione dello stesso e l’altra, ancora visibile all’inizio degli anni ’80, collocata all’estremità occidentale degli attuali Bagni “Colombina”, che fu distrutta quando fu realizzata la passeggiata di ponente. Sulla collina di Capo Mele, dove nei primi anni cinquanta sarebbe stata realizzata l’attuale base radar dell’Aeronautica Militare, posizionarono una batteria contraerea ed un’altra sulla scogliera più o meno dove termina oggigiorno la passeggiata di ponente. Lungo la via Aurelia, in una fascia a pochi metri di distanza dall’attuale condominio “Sito di sogno”, non possedendo le truppe dell’Asse la tecnologia del radar, allora solo di pertinenza di quelle anglo-americane, posizionarono un marchingegno particolare, un cosiddetto “aerofono”. Questo era uno strumento capace di ampliare le onde sonore e tale da permettere loro di udire con ampio anticipo l’arrivo dei caccia e bombardieri anglo-americani che solitamente provenivano dalla Corsica. Onde proteggerlo da eventuali sabotaggi lo circondarono con un campo minato. Per completare l’opera misero un posto di blocco per il controllo stradale all’altezza di Villa Martinetto dopo averla occupata con un corpo di guardia ed anche a Molino Nuovo, all’imbocco del ponte sul Merula, misero una sbarra con tanto di cartello che metteva in guardia che oltre quel punto si entrava in una zona pericolosa, cioè infestata dalle bande ribelli.
Contemporaneamente alle truppe che si alternavano in attesa di essere chiamate su qualche fronte, ce n’erano anche altre che, seppur in quantità molto più esigua, stazionavano fisse in loco con compiti di puro presidio territoriale.
Il comando di queste ultime fu installato a Villa Stefania, già residenza di proprietà del marchese Pippo Maglione ed attuale sede dell’Istituto Sacra Famiglia.
Un bel giorno costoro, probabilmente all’interno del programma di presa di conoscenza della valle e di monitoraggio dei suoi abitanti, pensarono di andare a fare un giro pure a Stampino per visionare la situazione, forse anche nell’eventualità di un insediamento nella villa.
Il loro arrivo fu sicuramente improvviso e quanto mai inaspettato poiché, nonostante Quaglia potesse contare sempre su una fitta rete di informatori, quel giorno non si attendeva certo una visita a domicilio così repentina ed improvvisa da parte di quei signori in divisa.
All’effetto sorpresa contribuirono di certo sia il fatto che costoro erano arrivati sul nostro territorio comunale da poco, sia la difficoltà di comunicazione linguistica con gli ex alleati ora diventati improvvisamente nemici.
E così quando quel giorno gli ufficiali della Wehrmacht arrivarono in auto alla villa e, dopo esserne scesi, coi propri stivali di cuoio calpestarono il piazzale interno, fu semplicemente il terrore.
In quel momento era presente solo la Contessa, la quale, non appena li vide, andò immediatamente con il pensiero a quelle casse di esplosivo non utilizzate, che erano avanzate per lo scavo del rifugio antiaereo appena realizzato e che qualcuno molto improvvidamente aveva lasciato ancora là in bella vista nella fascia sotto il viale delle rose.
Se i tedeschi avessero fatto un giro d’ispezione o solamente quattro passi per ammirare il giardino, non avrebbero potuto fare a meno di vederle, considerato che sia il loro formato che le scritte erano chiaramente inconfondibili.
Certamente Quaglia aveva sempre avuto confidenza con gli esplosivi considerate le sue attività di recupero sottomarine, ma quello non era certo il tempo in cui si potevano detenere armi ed ancor più esplosivi di sorta dato che, essendo ora noi italiani diventati nemici dei tedeschi, questi avevano proclamato ben chiaro che dovevano essere consegnate tutte le armi comprese le munizioni. Men che meno si potevano detenere bombe od esplosivi di qualsiasi genere. Oltretutto anche la più veritiera delle spiegazioni avrebbe potuto non essere riconosciuta come tale poiché un po’ ovunque c’erano già stati episodi di resistenza ai tedeschi.
Quaglia, e con lui qualcun altro, avrebbe anche potuto essere scambiato per un fornitore di materiali bellici a qualche resistente e per tutte queste situazioni la legge del momento contemplava la corte marziale con tutto ciò che ne poteva conseguire, ragion per cui la Contessa dopo il primo attimo di smarrimento chiamò Giovanni e Giorgio, che si trovavano lì vicino, e sibilò loro come un serpente a sonagli:
” Giovanni faccia sparire immediatamente quella roba, altrimenti non si sa come va a finire! Mentre io li blocco lei e Giorgio portatela via e poi andate a gettarla nel vascone”!
Quindi, sfoggiando un sorriso da miss ed una cordialità suadente degna dei più fastosi ricevimenti, si fece incontro agli ufficiali facendo gli onori di casa come non mai.
Li invitò ad entrare in casa, ma quelli non vollero; da buoni tedeschi erano affascinati ed attratti, dalle piante, dai fiori, dalla bellezza del giardino insomma e continuavano a commentare tra di loro scandendo dei gran “Schone, schone”, cioè erano stati conquistati dalla bellezza del luogo e qualcuno di loro, preso dalla curiosità stava già per incamminarsi nella direzione vietata ai loro occhi cioè verso il viale delle rose.
A quel punto la Contessa, con fare oltremodo civettuolo, ma anche con notevole polso, li chiamò tutti a sé facendo intendere loro che sì…..sì certo …..poi avrebbero avuto modo di visitare tutto il parco con calma, ma prima di ciò li invitava a prendere un tè in terrazza.
Per fortuna accettarono di buon grado e quindi li fece accomodare su un terrazzino che domina la corte interna facendoli sedere in modo tale che dessero le spalle al vialetto delle rose. In quella posizione non potevano rendersi conto di ciò che accadeva a pochi metri di distanza alle loro spalle, mentre lei, seduta di fronte a loro in posizione strategicamente favorevole, con un occhio guardava intensamente gli interlocutori per tenerli attenti e con l’altro controllava che l’operazione rimozione andasse a buon fine nel minor tempo possibile.
Chiamò Ines e le ordinò di preparare il tè per gli ospiti aggiungendo:
“Mi raccomando Ines, servi anche la pasticceria francese, quella per le occasioni importanti!”
In pochi minuti, mentre veniva preparato il tè, fecero le presentazioni.

Uno degli ingressi del rifugio antiaereo, a destra del campo da bocce.
In una scena di profonda serenità in terrazza si sorseggiava con rara delizia il tè accompagnato da pasticcini di ottima fattura, che oramai erano diventati roba veramente rara da trovarsi, perfino alla borsa nera.
La Signora infatti, considerata l’eccezionalità dell’evento, non aveva lesinato sulla qualità del trattamento per gli inattesi ospiti stranieri, mentre poche decine di metri più in là Giovanni e suo figlio Giorgio continuavano la loro apparente routine di giardinieri intenti a ripulire la proprietà portando via con le carriole sterpi, erbacce e fogliame.
Furono pochi, ma interminabili minuti, durante i quali non si ebbe nemmeno il tempo e la mente di aver paura, almeno fino a quando padre e figlio non furono più a portata di vista dei presenti in terrazza. Sotto quel sottile strato di vegetazione, peraltro malfermo, c’era tanto esplosivo da far saltare in aria una caserma.
Comunque tutto filò liscio e la dinamite venne gettata in un enorme vascone rasoterra tuttora esistente, oggi proprietà Bertolino, sito a poche decine di metri di distanza dalla vecchia strada mandamentale a metà distanza tra la villa e la Casa Garotta, che serviva come riserva idrica per far girare le ruote delle macine del Gumbasso in periodo di carenza di acqua.
Sarà stata la bontà del trattamento ricevuto, oppure sarà stato che per il momento i tedeschi erano saliti alla villa solo per curiosità, comunque fosse, l’inaspettata visita si esaurì senza ulteriori complicazioni
Lo spavento era stato notevole, ma non perciò le preoccupazioni potevano ritenersi terminate, anzi erano appena iniziate.
In coda alla giornata Giovanni commentò così:
“Almeno durante la Prima Guerra quando i nemici arrivavano sparavano come dei satanassi e li sentivi arrivare, ora te li ritrovi in casa e non te ne accorgi nemmeno…..”
UN'ALTRA VISITA INASPETTATA
Pur essendo già autunno inoltrato, dal momento che faceva ancora caldo, la piccola Rina se ne andava ancora in giro col suo bel vestitino bianco estivo completato dal classico fiocco tra i capelli.
Era quasi mezzogiorno e, dopo esser stata istruita dalla mamma per una commissione, era uscita di casa trotterellando e, canticchiando allegramente come suo solito, si stava accingendo ad entrare in villa per recarsi nelle cucine.
Rina era la vera regina della situazione poiché si ritrovava ad essere l’unica bambina abitante a Stampino ed in quanto tale nessuno si sognava minimamente di renderle conto delle sue azioni.
La piccola in ogni caso se ne approfittava, andando spesso e volentieri a ficcanasare ovunque, perfino nelle segrete stanze dei padroni, ma non per ciò alcuno l’aveva mai rimproverata, anzi tutti le volevano un gran bene perché era simpatica e veramente carina con quel suo candido vestitino che la rendeva simile ad un confetto, al punto che non solo la servitù, ma anche i padroni non osavano rimproverarla mai, arrivando a considerarla alla stregua di una nipotina acquisita.
Così fece anche quel giorno con fare allegro e sbarazzino canticchiando come sempre, ma quando fu sul punto di entrare in villa si ritrovò davanti un signore di una eleganza insolita per quei tempi. Era vestito con un completo marrone scuro e portava in testa un cappello a larghe tese in tinta del tipo “Borsalino”.
Le si parò di fronte con voce gentile ma risoluta chiedendole:
“Dove vai bella bambina?”
Rina, colta di sorpresa da quella domanda rivoltale a bruciapelo da quello sconosciuto, ristette un attimo ma si riprese subito e rispose disinvolta da par suo:
“A farmi dare una cosa dalla cuoca!”
“No bella bambina, tu non puoi entrare!”
“E perché, ci vado sempre!”
“No bambina, non puoi entrare!” ripetè il tizio in maniera brusca e senza darle spiegazioni di sorta.
Allora Rina ristette un attimo pensosa a metà tra il sospettoso e l’incuriosito, lo squadrò con fare di sfida, poi si girò sui propri passi senza replicare e tornò in casa dove riferì tutto al papà.
“C’è un signore che non mi lascia entrare in cucina!” disse con tono perentorio.
“Eh cosa dici, com’è possibile?” commentò Giovanni.
“Si, si, è proprio così papà, non mi lascia entrare!” confermò Rina con un pizzico di petulanteria.
Giovanni, più che altro incuriosito da ciò che andava affermando la figlia, uscì di casa e percorse quella ventina di metri che separava l’uscio di casa propria dal portone della corte del palazzo. Non appena fu all’interno, notò un furgone insolito mai visto in precedenza e quindi, volgendo lo sguardo verso sinistra in direzione della villa, notò anche quel misterioso signore.
Si avvicinò e gli chiese che cosa desiderasse.
Quello freddamente rispose:
“Siete tutti sotto sequestro!”
Non fu necessario porre altre domande né attendere ulteriori delucidazioni.
Nonostante il tempo fosse ancora tiepido Giovanni sentì immediatamente un brivido corrergli lungo la schiena. Comprese al volo che doveva trattarsi della temibile polizia politica della neonata Repubblica Sociale Italiana o qualcosa del genere, e che quello che aveva primitivamente ed erroneamente scambiato per un furgone qualsiasi, in realtà, ora che lo osservava meglio, altro non era che un cellulare atto a rinchiudervi dentro eventuali arrestati.
Giovanni tornò istintivamente sui propri passi prima che quel losco figuro potesse bloccarlo lì su due piedi e rientrò in casa. Al chè, non sapendo bene cosa fare, come prima misura cautelativa e preventiva, impose subito a suo figlio Giorgio di fuggire scappando dalla finestra che dava sul bosco retrostante.
Gli diede un tascapane con una bottiglia d’acqua ed una pagnotta e lo raccomandò così:
“Scappa e non farti vedere finchè questi non se ne saranno andati via! Vai a rifugiarti alla Cà di Baracco: da lassù potrai vedere il piazzale ed osservare le loro mosse!”
Come buona compagnia gli affidò anche la piccola Rina, lanciandogliela letteralmente al volo attraverso la finestra. All’occorrenza avrebbe potuto fargli da staffetta informatrice. E così si incamminarono e salirono la montagna fino a raggiungere un casolare disperso nel bosco che si trova a circa metà collina e dal quale si domina la tenuta.
Ma l’oggetto dell’interesse della polizia era rappresentato da ben altro; non era certo un potenziale renitente alla leva che interessava loro, bensì il contenuto del carteggio che Quaglia teneva con la famiglia Ciano dal momento che Galeazzo, figlio di Costanzo Ciano suo amico e socio d’affari, era stato appena arrestato con l’accusa di alto tradimento.
Il regime fascista era caduto con la lunga riunione notturna del Gran Consiglio del Fascismo, conclusa la mattina del 25 Luglio, durante la quale i componenti avevano approvato la mozione di sfiducia a Benito Mussolini presentata da Dino Grandi, sfiducia votata a larga maggioranza e tra gli altri anche da Galeazzo Ciano membro del Gran Consiglio ed oltretutto genero del Duce.
Ora che il Partito Fascista era risorto sotto forma di neonata Repubblica Sociale Italiana, retta sempre da Benito Mussolini, seppur repubblica fantoccio dei tedeschi, erano iniziati i regolamenti dei conti nei confronti dei gerarchi che avevano tradito la causa determinando la caduta del vecchio regime e non si facevano sconti a nessuno, nemmeno a colui che aveva impalmato Edda la figlia del Duce.
Nell’ambito di questa logica erano possibili vendette e ritorsioni nei confronti di tutti coloro che avevano variamente tramato e contribuito alla caduta di Mussolini e Quaglia poteva essere ritenuto giustamente uno dei sostenitori e fiancheggiatori della fronda.
Non dimentichiamo che egli era anche da sempre in ottimi rapporti con Dino Grandi, altro esponente dell’ala moderata del Fascismo, nonché promotore della mozione di sfiducia in questione.
Dopo circa un’ora dall’arrivo di quegli sbirri arrivò in auto pure Quaglia proveniente dalle parti di Diano.
Silenzioso e scuro in volto non era solo; con lui c’erano altre due auto che lo scortavano, una davanti e l’altra dietro con altri poliziotti all’interno.
Erano già stati a Diano Castello nella sua residenza natale e nel suo ufficio di Diano Marina ed avevano già provveduto a perquisirle, ora si accingevano a fare altrettanto a Stampino.
Quando la Signora lo vide arrivare gli disse a denti stretti:
“Ciao Giovanni, siamo sotto sequestro.”
“Anch’io” fu la sua laconica risposta.
Quindi si avviarono tutti in casa dove fu fatta una perquisizione minuziosissima, ma i biechi figuri non trovarono nulla nonostante avessero rivoltato tutta la residenza come un calzino.
In effetti e per loro fortuna pochi giorni prima la Contessa, non si seppe mai se per premonizione oppure per una soffiata giunta al marito, aveva distrutto e bruciato tutto il carteggio cancellando ogni possibile traccia compromettente. Sesto senso da parte di Quaglia oppure amicizie giuste, nessuno lo saprà mai!
Così, a metà pomeriggio, dopo ore di manifesto disagio e trepidazione da parte di ognuno, gli importuni inquisitori se ne andarono via con le pive nel sacco e tutti poterono tirare alfine un sospiro di sollievo Quaglia in primis e tutti gli altri a ruota, Giorgio compreso, che da lassù duecento metri più in alto vide le auto ridiscendere lentamente il viale.
A sua volta, assieme alla sorellina, potè quindi ridiscendere la collina e tornare a casa a cuor leggero, ma il destino stava tramando una dura prova anche nei suoi confronti, prova che avrebbe dovuto affrontare in capo a pochi mesi all’inizio del nuovo anno.
GIORGIO CHIAMATO NELLA REPUBBLICA
La nascita della Repubblica Sociale Italiana aveva automaticamente significato anche la ricostituzione di un esercito che doveva continuare a combattere al fianco e nel segno della continuità del primigenio alleato germanico.
Pertanto poco dopo la sua costituzione era stata di nuovo istituita la leva obbligatoria con gran disappunto dei giovani potenzialmente interessati, i quali si erano vanamente illusi che per gli italiani la guerra, almeno quella attiva, fosse ormai di fatto terminata.
Giorgio, che dopo l’8 Settembre era riuscito a rientrare a casa senza grossi problemi, di fatto vivacchiava in famiglia dando una mano al padre nel suo lavoro e, al pari di tanti altri suoi coetanei, restava più che altro in attesa degli eventi ascoltando ogni giorno Radio Londra.
Uno dei suoi compiti particolari, affidatogli per l’appunto dau Sciù Giuvanni in persona, era proprio quello di ascoltare quotidianamente le notizie di Radio Londra che riportava i bollettini di guerra che arrivavano dai vari fronti.
La radio era stata nascosta nei bassifondi della villa, dove un tempo si trovava il frantoio, sotto un cumulo di masserizie varie e Giorgio, dopo aver ascoltato, saliva al piano superiore dove provvedeva a riferire quanto ascoltato.
Però, per quanto gli alleati potessero ottenere vittorie sul campo e progredissero nella riconquista del terreno perduto, l’avanzata richiedeva comunque il proprio tempo, e la fine del conflitto appariva ancora lontana.
A causa della guerra aveva dovuto interrompere il rapporto di lavoro con il Dott. Amoretti e per forza di cose non avrebbe potuto riprenderlo prima che le ostilità fossero terminate. Pertanto doveva accettare la dura realtà in attesa di tempi migliori.
La tranquilla vita di campagna gli andava un po’ stretta, lui che si era abituato a lavorare in città, ovvero ad Oneglia, dove aveva avuto modo di conoscere tanta gente, anche importante e rinomata, alla quale aveva contribuito a fare dei lavori odontoiatrici, come al famoso clown Grock.
Pertanto, come tanti ragazzi par suo, non si faceva scappare quelle rare occasioni in cui ci si poteva distrarre e divertirsi un po’, dato che la guerra aveva ristretto molto le possibilità di divertimento.
Pertanto, all’approssimarsi del 2 Febbraio, non vedeva l’ora di poter ritornare alla Madonna della Rovere per poter stare un po’ in dozzina con i suoi vecchi amici dell’infanzia ed al contempo poter riassaporare il gusto di quel giorno di festa, la festa di quello che in fondo in fondo considerava ancora il “suo” paese.
Quando il giorno precedente manifestò la propria intenzione, il papà tentò di dissuaderlo mettendogli di fronte i rischi ai quali poteva andare incontro, ma come tutti i ragazzi di diciannove anni non ne volle proprio sapere di ascoltare i preziosi consigli che provenivano dalla saggezza fatta persona e nemmeno la mattina successiva il babbo riuscì a farlo ragionare.
Così il fatidico giorno si mise in cammino e nella sua incoscienza giovanile se ne andò bel bello a San Bartolomeo del Cervo per l’annuale festa.
Ritrovò alcuni dei suoi vecchi amici, scherzò, bevve, cantò, insomma si stava divertendo e la festa, per quanto fosse condizionata dalle ristrettezze del momento, nel primo pomeriggio era all’apice, quando improvvisamente dal basso, provenienti dalla direzione della Via Aurelia, giunsero delle urla strozzate:
“I Fascisti, i Fascisti, scappate, scappate!!”
Sul più bello della festa era giunta una squadra Milizia Repubblicana con l’intento di fare una retata alla fiera della Madonna della Rovere per verificare se fossero presenti dei renitenti alla leva oppure qualche ribelle sceso dalle alture in cerca di divertimento.
Tempo un battito di ciglia e fu il fuggi fuggi generale da parte di tutta la parte maschile compresa tra i venti e i trent’anni.
Giorgio, come tutti gli altri giovani presenti, non si fece troppe domande se aveva qualcosa da temere o meno dalla legge, ma, onde non correre rischi inutili, pensò bene di squagliarsela il più velocemente e il più lontano possibile da quel luogo trasformatosi in pochi secondi da paese dei balocchi ad inferno.
Trovandosi in quel momento proprio nella piazzetta della chiesa e conoscendo a menadito quei luoghi in cui era cresciuto, si diresse istintivamente verso il carrugio che si trovava di fronte alla chiesa e che conduceva in salita su per le campagne retrostanti quel gruppo di case.
Mentre lo imboccava fece appena in tempo a girarsi a sinistra ed a distinguere con la coda dell’occhio i primi soldati in divisa nera che sbucavano di corsa dalla strettoia che dà accesso sulla piazzetta.
Altri giovani si erano già lanciati su per la ripida erta, altri se l’erano data a gambe prendendo la strada che conduceva verso levante, altri ne sentiva correre ed ansimare dietro di sé.
In basso sentiva le intimazioni secche e minacciose che provenivano dai fascisti:
“Fermatevi, fermatevi tutti o spariamo!!” continuavano a ripetere.
Un attimo dopo udì crepitare alcune raffiche di arma da fuoco secche e ripetute ritmicamente.
Il rumore delle pallottole, invece che dissuaderlo dal fuggire, al contrario, ebbe il potere di spronarlo ancor più nella fuga facendolo letteralmente volare.
Sentiva i colpi sibilare tra le fronde degli olivi, ma non si voltò nemmeno una volta, anzi, accelerò ancor di più il ritmo delle gambe e ringraziò il cielo una volta in più di aver fatto atletica di mezzofondo fino a che non si era trasferito ad Andora.
Per sua fortuna conosceva quelle fasce coltivate ad oliveto una per una, dato che erano state il luogo di gioco della sua infanzia e mai e poi mai avrebbe immaginato che quel terreno, che lo aveva visto giocare coi suoi amici a guardie e ladri, un giorno sarebbe diventato luogo in cui il gioco si sarebbe trasformato in cruda realtà.
Dopo qualche minuto di corsa, col cuore pulsante in gola e grondante sudore forse più per lo spavento che per la prestazione atletica, non sentì più rumore di passi, né urla. Ormai aveva messo una certa distanza tra sé e gli inseguitori ed aveva raggiunto il versante della valle che guarda verso Diano San Pietro.
A quel punto, non vedendo più nemmeno altri fuggitivi, si fermò ansante e tentò di ragionare un poco: tornare indietro meno che mai, ma anche andare troppo avanti o peggio ancora, tentare di tornare a casa per lo stradone potevano rivelarsi soluzioni più che pericolose. Allora pensò bene di attendere che le acque si fossero calmate e per far ciò in sicurezza prima di tutto decise di riparare in un rifugio sicuro per qualche ora.
Pensò allora di dirigersi verso l’abitazione di Bruno a Diano Castello e così fece.
A casa di Bruno c’erano i suoi genitori che lo accolsero e lo ospitarono come un figlio.
Quando fu sera lo aiutarono a riprendere la strada di casa accompagnandolo in stazione a Diano Marina con tutte le cautele del caso, in maniera da risparmiargli brutte sorprese.
Quando, a notte fonda, fu arrivato a casa propria e raccontò l’accaduto, papà Giovanni, per manifestargli la propria contentezza per lo scampato pericolo, gli rovesciò addosso una tale gragnuola di calci e colpi da fargli rimpiangere le pallottole dei fascisti di qualche ora prima.
Dopo questo episodio premonitore trascorsero pochi giorni e purtroppo per lui, sempre durante il mese di febbraio, ricevette la rinnovata chiamata alle armi, anche se stavolta non proveniva più da parte del Regno d’Italia, ma da parte della neonata Repubblica Sociale Italiana: praticamente dalla padella alla brace, destinazione Vercelli.
Il fatto ovviamente generò preoccupazione e sconforto in famiglia, non escluso il Commendatore, il quale si prodigò immediatamente per cercare di far esentare il ragazzo dal servizio di leva attivando ogni conoscenza in proprio possesso.
Giorgio, come tanti altri ragazzi come lui, in quei giorni confusi e travagliati, non sapeva bene come comportarsi: nascondersi, unirsi alle bande partigiane che ormai si erano costituite anche nella nostra zona oppure obbedire alla chiamata nell’attesa che nel frattempo arrivasse qualche buona notizia da parte “du Sciù Giuvanni”?
Fatti i dovuti calcoli, seppur mortalmente e controvoglia, considerando anche che il 18 di febbraio era stato appena promulgato il famigerato “Bando Graziani”, che prevedeva la pena di morte per renitenti alla leva e disertori, alla fine fu deciso che si sarebbe presentato alla chiamata e poi avrebbero valutato il da farsi.
Papà Giovanni, che la guerra l’aveva fatta, sapeva bene che il mestiere di combattente partigiano non era da meno pericoloso che quello del soldato repubblicano e, se malauguratamente catturati, il plotone d’esecuzione non era assolutamente da escludersi, anzi era quasi una certezza.
Da ultimo anche “u Sciù Giuvanni” si era espresso in maniera nettamente contraria circa questa scelta dal momento che non gradiva affatto che il figlio di un suo stretto dipendente si unisse ai partigiani, poiché questo fatto lo avrebbe messo fortemente in difficoltà di fronte alle gerarchie nazifasciste ed anche lui in persona sarebbe diventato un sorvegliato ancora più speciale a causa della vicinanza fisica con la famiglia del ragazzo.
In virtù di questi ragionamenti Giorgio si presentò regolarmente in caserma in quel di Vercelli e vi rimase in attesa per circa due settimane sperando ogni giorno che al portone d’ingresso prima o poi si presentasse qualche volto conosciuto con un’esenzione alla mano.
Intanto a Stampino anche la sua famiglia viveva quotidianamente nell’attesa, finchè una decina di giorni dopo la sua partenza finalmente “u Sciù Giuvanni” tornò a casa trionfante e dal suo cappello a cilindro estrasse non un coniglio bianco, ma un ancor più fantastico ed incredibile pezzo di carta sopra il quale campeggiava un’aquila teutonica e sul quale si attestava che Giorgio Volpara, in qualità di dipendente di una delle tante ditte dell’Avvocato Quaglia, era esentato dal servizio militare. Sempre nel segno dell’imprenditore politico, il nostro uomo nel frattempo si era inventato anche l’attività di rifornitore di vettovaglie per l’esercito tedesco, ma al solo scopo di poter intrattenere buoni rapporti con l’occupante straniero ed al contempo con il fine ultimo di poter inserire di volta in volta nella sedicente azienda ogni giovane di sua conoscenza che poteva essere chiamato alle armi, permettendogli in tal modo di trascorrere quell’incerto periodo senza troppi pericoli.
Gioia, esultanza, papà e mamma in lacrime che non sapevano nemmeno come ringraziare l’eterno uomo della provvidenza, il quale da parte propria, con notevole senso di realismo e lucida presenza, incitò Giovanni a non perdere nemmeno un minuto ed a precipitarsi istantaneamente a Vercelli per riprendersi il figlio prima che partisse per la Germania. Mentre lo spronava a ciò, per agevolargli ulteriormente il viaggio, gli infilò anche 500 lire nel taschino della camicia.
Papà Giovanni non se lo fece ripetere una seconda volta, si precipitò in stazione e saltò sul primo treno utile a raggiungere la meta, ma quando, arrivato a destinazione, si presentò in caserma chiedendo del ragazzo, si sentì rispondere che quella recluta non si trovava là.
Insistette chiedendo di controllare bene, ma la risposta fu di nuovo quella: Giorgio Volpara non si trovava in quella caserma. Altro non seppero aggiungere anche perché durante quel particolare periodo storico la confusione regnava sovrana, le comunicazioni erano difficoltose ed i conflitti di competenza la regola quotidiana.
Tornò a casa con il cuore a pezzi pensando che il figlio fosse già partito per la Germania dove c’erano i campi di addestramento.
“U Sciù Giuvanni”, appresa la notizia, scrollò il capo manifestando palese insoddisfazione, quindi seguendo il proprio istinto o forse ancor meglio le informazioni ricevute dai propri informatori, lo spronò nuovamente quasi con violenza a tornare indietro sui propri passi ed a riprenderne la ricerca con più accuratezza perché secondo lui Giorgio si trovava ancora là da qualche parte.
“Và, - gli urlò in faccia- e non tornare finchè non lo avrai trovato!”
E così dicendo, stavolta estrasse non uno, ma parecchi biglietti da 500 lire e, nonostante Giovanni li rifiutasse, glieli ficcò a viva forza nel taschino della giacca come viatico per un viaggio dalla durata imprecisata.
Giovanni partì nuovamente alla volta di Vercelli e si ripresentò al comando della caserma chiedendo di nuovo del figlio il quale questa volta, come quella precedente era scomparso, stavolta per incanto riapparve seppur notevolmente malconcio.
Ma cos’era successo?
Appena giunto in caserma a Vercelli, lui ed altri assieme a lui erano stati sistemati in una camerata coi vetri rotti. Non essendo ovviamente presente alcuna forma di riscaldamento ed essendo febbraio, la temperatura, già di per sé rigida di giorno, di notte nelle camerate scendeva ampiamente sotto lo zero, cosicchè si erano impossessati di alcune coperte in più, sottraendole al magazzino, onde poter resistere meglio all’inclemenza dell’inverno.
Essendo stati scoperti erano stati rinchiusi in cella di rigore per alcuni giorni e durante quei giorni, essendo puniti, non risultavano tra la forza disponibile, pertanto, quando suo padre si era presentato la prima volta, era stato come se suo figlio non fosse risultato presente.
Quando invece Giovanni si presentò la seconda volta, Giorgio era appena uscito dalla guardina ed appariva in uno stato veramente pietoso per via delle dure condizioni di reclusione.
Gli ufficiali addetti, all’inizio, di fronte alle affermazioni del papà, che affermava di essere in possesso di un’esenzione per il figlio, rimasero alquanto scettici e stentavano a prenderlo sul serio, ma quando si trovarono di fronte al documento con tanto di aquila, timbri, firme e quant’altro non poterono fare altro che prender atto della cosa ed acconsentire affinchè il ragazzo se ne andasse e potesse far ritorno a casa.
Ancora più attonito ed imbambolato era rimasto Giorgio che non si capacitava di cotanta fortuna, dato che oramai aveva perso le speranze di potersela scansare ed oltretutto era reduce da giorni e giorni di stenti in cella di rigore.
Il papà gli diede uno scrollone e lo trascinò via quasi di peso; era conciato veramente male, indebolito dagli stenti e soprattutto aveva una fame boia che si sarebbe mangiato il mondo intero, ma papà Giovanni non perse tempo neanche per sfamarlo più di tanto e si precipitò in stazione prima che quegli ufficiali potessero ripensarci obiettando qualcosa.
Quaglia, molto avvedutamente, aveva insistito affinchè Giovanni ripartisse immediatamente alla ricerca del figlio e questa fu una fortuna, poichè il giorno successivo quelle reclute sarebbero partite per i campi di addestramento in Germania.
Giorgio e tutti gli altri ne erano perfettamente a conoscenza, infatti molti di loro avevano già programmato di fuggire nottetempo per darsi alla macchia oppure per unirsi alla resistenza locale, ma per Giorgio non fu necessario perchè anche quella volta “u Sciù Giuvanni” era arrivato giusto in tempo a scongiurare il peggio.
Quando fu ritornato a casa, la mancata recluta non fece altro che mangiare e dormire per due giorni.
I PARTIGIANI
Anche nella nostra zona si erano da tempo costituite ed agivano bande di partigiani resistenti e Quaglia aveva iniziato a sostenerli sia mediante contribuzioni in denaro che con donazioni in natura.

Così ogni tanto capitava di vedere “u Sciù Giuvanni” scendere allegramente il viale a piedi dalla residenza fino alle “Pigne” fischiettando e roteando il bastone con una mano, mentre con l’altra teneva stretto tra le dita il suo immancabile sigaro.
Una volta giunto sotto i due grandi pini, si sedeva pigramente sul muretto di sostegno della fascia sovrastante ed osservava attentamente se intorno a sè poteva esserci qualcuno che lo osservasse. Quindi si chinava ed estraeva una pietra dal muretto sul quale si era seduto e ne estraeva una scatoletta metallica vuota entro la quale metteva alcuni biglietti di carta moneta. Terminata la rapida operazione, riprendeva la lenta passeggiata in salita verso la villa con estrema nonchalance. Verso sera arrivava qualcuno che era ben a conoscenza di quel piccolo nascondiglio e che, con le stesse accortezze di cui sopra, provvedeva a svuotare la scatoletta del suo prezioso contenuto, lasciando al posto dei soldi, un biglietto che fungeva da ricevuta per la somma percepita. Quel qualcuno potevano essere tanto una staffetta partigiana, quanto il comandante partigiano Nino Agnese, il quale a volte poteva anche incontrare di persona il padrone di casa sotto le “Pigne”; in un secondo tempo, quando a Stampino arrivarono le truppe repubblichine e non fu più possibile per tutti esporsi così apertamente, le donazioni avvenivano allora esclusivamente tramite persone fidate al confine settentrionale della proprietà in zona Donnetta. In questo modo Quaglia poteva continuare a sostenere economicamente la lotta armata di liberazione senza correr alcun rischio di compromissione personale.
Le ricevute, che ogni volta i comandanti partigiani rilasciavano in cambio dei soldi ricevuti, ovviamente non venivano custodite in casa, ma erano riposte in un’altra scatola vuota di lucido da scarpe, marca “TANA”, molto comune allora, che veniva occultata in un muro di sostegno di una fascia di olivi appena sottostante la dimora di Giovanni dentro una piccola cavità retrostante una pietra facilmente rimovibile.
Manco a dirlo, erano pochissime le persone di indiscussa fiducia ad essere al corrente di queste contribuzioni in quanto per il reato di protezione e fiancheggiamento dei cosiddetti “ribelli” esisteva solamente la corte marziale con tutto ciò che ne poteva derivare.
Ma non era tutto.
Come già detto, durante gli anni più duri della guerra, in alcuni campi della tenuta di Stampino era stato seminato il grano per avere una migliore autosufficienza alimentare. Il grano, una volta trebbiato e posto nei sacchi, veniva poi caricato sul carro e con un lento viaggio portato a macinare a Stellanello.
Questa operazione durava una giornata intera dal mattino presto fino a tarda sera.
Accadeva così che, durante l’altrettanto lento viaggio di ritorno, qualche sacco di farina si vaporizzasse dalle parti di San Lorenzo o Bossaneto. Ovviamente i beneficiari di queste sparizioni erano sempre i partigiani che operavano nell’alta Val Merula e che in questa maniera riuscivano a lenire i morsi della fame durante la permanenza in montagna.
Questi fatti potrebbero far pensare che tutti quanti i partigiani, in virtù della manifesta generosità e solidarietà evidenziate dall’imprenditore Quaglia, dovessero essere riconoscenti, ma ad onor del vero non tutti si comportarono da gran signori.
Siccome si dice che l’appetito vien mangiando, tutta quell’insolita abbondanza dovette dare alla testa a qualcuno e scatenargli dentro una malsana ingordigia come avvenne per l’appunto un giorno di maggio.
Infatti era una bellissima domenica di sole e la temperatura cominciava ad innalzarsi.
La cameriera Ines e la piccola Rinetta si erano recate nel bosco retrostante la villa alla ricerca di qualche fungo primaticcio da consegnare a Pasqua onde poter variare un poco il menù.
Mentre risalivano lentamente la pineta impegnate nella ricerca, tutto ad un tratto ebbero un soprassalto vedendo sbucare dalla vegetazione tre baldi giovanotti armati di fucili che scendevano la collina veloci e con fare circospetto.
I tre indossavano pantaloni corti e camicia, calzavano calzettoni alti e scarponi: erano inequivocabilmente dei partigiani.
Le salutarono, ma non si soffermarono minimamente a parlare con loro e tirarono diritto in direzione della villa.
In quel momento il Commendatore e la signora Tina si trovavano sotto il platano della corte interna a godersi il primo caldo vicino alla vasca delle ninfee.
Lui se ne stava tranquillamente seduto a fumarsi il suo abituale “Magretti” mentre lei leggeva un libro in attesa di andare a messa.
All’improvviso i tre figuri si materializzarono davanti a loro e, senza tanti preamboli, uno di quelli si parò di fronte a Quaglia, allungò la mano e, togliendogli il sigaro di bocca con fare spavaldo, esordì con queste parole:
“Adesso fumo un po’ io, tu hai già fumato abbastanza!”
E così dicendo se lo portò alle labbra ed inspirò con voluttà.
L’interessato rimase per un attimo sbigottito, ma non fece una piega e nemmeno parlò cercando di capire ciò che stava accadendo.
La Signora a propria volta, dopo un primo momento di altrettanto sbigottimento, reagì con sdegno ed irritazione proferendogli decise parole:
“Ma come si permette, chi è lei? Se ne vada immediatamente da qui!”
Ma un secondo del terzetto fece un gesto brusco che non prometteva nulla di buono, come a dire “guai a te se non stai zitta!”. Al che anche il marito a propria volta fece un gesto con la mano alla consorte come a dirle “stai calma!” ed allora la Signora ristette.
Buon per tutti che in quel momento Renato fosse assente, sennò chissà che cosa sarebbe potuto accadere.
A quel punto il primo dei tre, colui che gli aveva strappato il sigaro di bocca, riprese la parola e motivò chiaramente la ragione della loro presenza in quel luogo chiedendogli apertamente dei soldi.
“U Sciù Giuvanni” non si scompose più di tanto e con olimpica calma rispose così:
“Guardate ragazzi che io non porto mai denaro con me (il che era vero) e poi io non sono una banca che elargisce denaro a degli sconosciuti, quindi vi consiglio di non insistere e di andarvene”.
Ma l’altro era insistente eccome:
“Allora se non ci vuoi dare i soldi ti rapiremo e ti porteremo via con noi in montagna finchè non ti sarai deciso a darceli!”
E Quaglia più serafico che mai:
“Vedete ragazzi, io oramai sono vecchio ed ho il bastone, peso centotrenta chili, io non ce la faccio proprio a camminare su per la montagna, se proprio mi volete portare con voi mi dovrete portare a spalle.”
Ma i tre non avevano la minima intenzione di mollare la presa e si facevano sempre più duri ed insistenti iniziando ad insultarlo e a minacciarlo fisicamente. Proprio quando sembrava che le circostanze stessero precipitando, osservandoli bene, una luce illuminò il volto del Commendatore che, senza alcun timore, riacquistò personalità e ne chiamò uno di fronte a sé.
“Tu vieni un po’ qua, che devo dirti una cosa! ……e voi due allontanatevi un po’!”
Quello ubbidì prontamente pensando che finalmente la sua vittima avesse deciso di addivenire a patti. Fece un gesto verso gli altri invitandoli ad assecondare la volontà del padrone di casa, ma non sognava certo la brutta sorpresa che lo attendeva.
Quaglia lo fissò profondamente negli occhi e gli disse:
“Caro ragazzo, ora io ti riconosco. Tu sei del mio paese. Non ti ricordi più quando accompagnavi tua madre che veniva a piangere da me perché tuo padre era in prigione e voi venivate a chiedere aiuto a me per farlo uscire ed io alla fine gli permisi di essere scarcerato? Ed ora tu vieni qui al mio cospetto con questi ricatti a minacciarmi e chiedermi dei soldi in questo modo? Vergognati, è questa la tua riconoscenza?”
Il partigiano ristette, accusò il colpo ed arrossì, abbassò gli occhi e mogio mogio chiese scusa a testa bassa, quindi, che fosse un elemento influente oppure no, altrettanto fece fare anche agli altri due.
Pochi secondi dopo lo scellerato trio, ripresa la via del bosco, come improvvisamente era apparso, altrettanto velocemente scomparve nella vegetazione.
In ogni caso l’episodio non si concluse così impunemente come si potrebbe pensare, poiché i tre scellerati partigiani-rapitori “fai da te”, che così follemente e maldestramente avevano tentato di mettersi in proprio onde ottenere vantaggio personale, non la passarono liscia.
Infatti Quaglia fece riferire l’accaduto a chi di dovere e i tre malandrini in seguito furono duramente puniti dai propri superiori dato che il comandante Agnese, quando venne a conoscenza del misfatto, dopo aver duramente deprecato l’episodio, fece comminare una dura pena contro coloro che avevano osato tanto nei confronti di un amico e per di più generoso sostenitore come Quaglia.
Un secondo episodio non così grave, ma comunque pur sempre discutibile, si verificò pochissimi giorni dopo la fine della guerra.
Si presentarono in villa tre rappresentanti delle forze partigiane, due uomini ed una donna, i quali chiesero di poter parlare con il Commendatore.
Tutti e tre erano ben acconciati ed indossavano il vestito della festa, al collo portavano un vistoso fazzoletto rosso.
Quando furono al cospetto del padrone di casa, seppur in buone maniere, ma fermamente, esposero le proprie istanze.
Uno dei tre si fece avanti e depositò l’ambascia senza tanti preamboli.
“Signor Quaglia, siamo stati inviati qui dal nostro comando poiché dobbiamo sequestrarle temporaneamente l’auto dal momento che ci serve”.
E così dicendo non specificò per quali non meglio definiti scopi dovevano sequestrargli l’auto, né per quanto tempo.
L’auto che faceva loro gola non era certo la berlina nera che usava solitamente il Conte, che oramai, da quando le era stata installata la piccola caldaia a vapore assomigliava più ad una piccola locomotiva che ad un’auto vera e propria, ma era la bellissima Lancia azzurra decapottabile con i sedili in pelle rossa della signora: una vera sciccheria!
Dopo aver ascoltato la particolare richiesta, Quaglia come al solito non battè ciglio, abbozzò un tenue sorriso e si limitò ad un parco assenso senza minimamente protestare, anzi, onde ottemperare meglio allo scopo fece chiamare immediatamente Renato al quale con voce stentorea e scandita ordinò:
“Renato vai a prendere l’auto e guarda di sistemarla bene dal momento che è un po’che non viene usata e quindi controlla che tutto funzioni a dovere, hai capito?!?”
Renato lo guardò intensamente per un attimo, accennò un inchino con il capo e rispose a propria volta con un sintetico:
“Si, signore!”
Quindi da perfetto padrone di casa “u Sciù Giuvanni” invitò i tre partigiani ad entrare in casa a prendere un caffè:
“Mentre Renato controlla l’auto perché non entrate in casa a prendervi un caffè considerato che ci impiegherà un certo tempo a controllare e mettere a posto tutto?”
Un bel caffè, un vero caffè e non uno schifosissimo surrogato dato che in quel periodo in cui si era perso non solo la cognizione, ma anche il ricordo del sapore e del colore di un vero caffè?!?
Non se lo fecero ripetere due volte e si fiondarono diritti in villa.
Ne uscirono una ventina di minuti dopo ed all’uscita trovarono Renato puntuale nel consegnare loro l’auto.
I partigiani appena la videro rimasero estasiati da tanta bellezza ed ordinarono di metterla in moto per potersene andare con l’elegante trofeo senza perdere altro tempo. L’autista però non aveva un volto rassicurante e li avvertì subito che c’erano dei problemi. Si stava grattando la testa ed affermava che aveva dovuto spingerla per farla uscire dal garage dal momento che non voleva saperne di partire, insomma c’era qualcosa che non andava.
Non paghi di quella descrizione ed evidentemente non fidandosi di lui pretesero di poter metterla in moto loro stessi, al che Renato li lasciò fare.
Provarono e riprovarono per alcuni minuti, ma senza successo alcuno.

L’autista Renato Matteucci.
L’auto faceva dei rumori strani, borbottava, tossiva, rantolava, ma non voleva saperne assolutamente di mettersi in moto.
Renato giurava e stragiurava che fino all’ultima volta aveva funzionato benissimo, ma…..chissà cosa era accaduto nel frattempo?
Guardarono e controllarono il motore, riprovarono ancora per una decina di minuti, ma non ci fu proprio nulla da fare ed alla fine dovettero alzare bandiera bianca.
E così gli insoliti visitatori, come erano giunti a piedi, a piedi se ne tornarono da dove erano arrivati con le pive nel sacco.
“U Sciù Giuvanni” se li era giocati e li aveva fregati con un semplice caffè, oltre che grazie alla perspicacia ed all’esperienza del fido Renato. Renato l’autista, Renato il gommista, Renato il carrozziere, e all’occorrenza Renato il ….. meccanico, il quale non aveva fatto altro che rispettare rigorosamente le consegne padronali: l’aveva proprio sistemata bene!
I SAN MARCO
Dopo la primavera arrivò un’altra estate e come tutte le precedenti, anche durante quella del 1944, il Conte e la Contessa ripresero i loro riti e le loro consuetudini estive cercando un’apparente normalità anche nelle cose abitudinarie nonostante le difficoltà quotidiane create da quel particolare momento storico, che, seppur in proporzioni differenti, colpivano tanto i poveracci quanto gli abbienti.
Durante quei giorni passati alla storia per la confusione e drammaticità delle vicende giornaliere generate da una guerriglia civile fratricida, la normalità era proprio l’ultima delle cose da attendersi ed ogni giorno poteva riservare amare sorprese. Già all’inizio dell’estate un gruppetto di tedeschi territoriali della Wehrmacht si era stabilito a fianco della villa, nella parte di casa libera dove abitava Giovanni con la propria famiglia, ma la cosa, dopo un iniziale comprensibile disagio da parte di tutti, in realtà non aveva poi disturbato più di tanto. Invece i veri disagi sarebbero arrivati di lì a poco. Infatti la reale brutta sorpresa fu rappresentata dall’arrivo ad agosto dei soldati della Repubblica Sociale in quantità notevole ad Andora e a Stampino in particolare.
A dire il vero bisogna aprire una parentesi, poichè già nel mese di giugno ad Andora Marina era stato inviato in missione un modesto reparto della Guardia Nazionale Repubblicana Giovanile, costituito da una quarantina di elementi comandati da un tenente, per contrastare la nascente attività delle bande partigiane. Si trattava soprattutto di ragazzi molto giovani tutti dai diciotto ai vent’anni. Purtroppo, durante un servizio di pattugliamento lungo la valle, in quel di San Lorenzo di Stellanello, una squadra fu circondata e fatta prigioniera dai partigiani praticamente senza sparare un colpo. Forse nella loro giovanile ingenuità pensavano che sarebbero stati trattati secondo le convenzioni di guerra, ma si resero subito conto che non era così anche perché erano caduti in mano ad un distaccamento del terribile e spietato comandante onegliese “Mancìn”, un personaggio al quale era più caro premere il grilletto che proferire parola. I suoi uomini, fedeli alle consegne, non facevano prigionieri e volevano fucilarli subito in paese a Stellanello sul greto del fiume, ma poi, dato che i vecchi del paese si erano loro ribellati facendo notare che si trattava di ragazzini imberbi meritevoli al massimo di essere disarmati e rimandati indietro scalzi con un calcio nel sedere, desistettero dall’intento, almeno apparentemente, rispondendo che certamente avrebbero fatto come consigliato dai senatori stellanellesi, ma quando furono di nuovo a San Lorenzo invece di rilasciarli presero per la montagna e li portarono al loro accampamento in “Ciàn de Belòtto”, poco sotto il Pizzo della Ciresa. Poi fu solamente il martirio e quei ragazzi, ai quali nel frattempo se ne erano aggiunti altri che erano stati catturati in quel di Casanova Lerrone, furono tutti sommariamente fucilati e gettati in una fossa comune fatta loro scavare prima di essere passati per le armi.
Con tali premesse, era naturale che la Repubblica passasse al contrattacco, pertanto in quel periodo reparti armati della divisione San Marco si stavano stanziando lungo tutta la Liguria di ponente. Andora non fu da meno, infatti la prima settimana di agosto arrivò il II Battaglione del 6° Reggimento di Fanteria di Marina agli ordini del Maggiore Luigi Uccelli.
Le truppe si sistemarono all’interno poiché sulla costa, cioè alla Marina, erano già presenti le truppe tedesche e pertanto si alloggiarono dove poterono, vale a dire a Molino Nuovo nella Casa del Fascio, in alcune case private e, per la gioia degli stampinesi, soprattutto a Stampino dove per giunta fu insediato anche il comando.
L’arrivo dei San Marco fu così inaspettato e senza preavviso che chi ne fece le spese maggiori fu la famiglia di Giovanni che si ritrovò sfrattata li per lì su due piedi, senza tanti complimenti, dal momento che dovette cedere la casa agli ufficiali nel minor tempo possibile affinché vi potessero insediare il comando di battaglione.
Lo sgombero fu effettuato a tempo record e tutte le masserizie e gli effetti personali furono traslocati in pochissime ore, più o meno dal primo pomeriggio alla sera. Alla fine, dopo una contrattazione, Giovanni e Giuseppina riuscirono ad ottenere il permesso di conservare almeno l’uso della cucina, poiché in foresteria, dove nel frattempo avrebbero dovuto andare a soggiornare e dormire, non era presente.
Per fortuna di Quaglia non entrarono nella corte interna della villa, in compenso l’aria che si respirava era quella da sindrome da accerchiamento, in quanto l’occupazione era generale dato che si accamparono con le tende un po’ ovunque sia nel parco che nella pineta retrostante.
Il grosso della truppa, invece, si attendò a circa tre-quattrocento metri in linea d’aria dalla villa in un campo delimitato dai due ruscelli Coloi, dove attualmente si trova la porzione più settentrionale della vigna di proprietà Isnardi, laddove allora si trovavano delle enormi mimose, sfruttando le quali cercavano di rendersi invisibili all’avvistamento dell’aviazione nemica.
Per avere un buon rifornimento idrico sistemarono la cucina campale vicino all’attuale pozzo di proprietà Ciccione, situato qualche decina di metri a valle delle “Pigne” lungo l’antica mandamentale ed ogni giorno, se non si trovavano fuori in missione, andavano e venivano con le gavette dall’accampamento al pozzo per i pasti giornalieri.
In quei giorni, immediatamente successivi all’arrivo dei soldati nonché al forzato sfratto, Giovanni non lavorava più né in giardino né altrove. Aveva ricevuto ordini chiari e tassativi da parte dei padroni: stare all’erta tutto il sacrosanto giorno da un coprifuoco all’altro. Affinché prima di tutto i San Marco non arrecassero danni alla proprietà e, non da meno e da ultimo, non saltasse fuori qualcosa di valore o di compromettente dal momento che scavavano per sistemare tende, posti di guardia, ricoveri un po’ dove capitava o sembrava più idoneo, senza la minima preoccupazione per i giardini e le piante ornamentali che tanta fatica erano costati a chi li accudiva. Infatti i bei prati livellati oppure le aiuole che Giovanni curava con tanto amore, furono i primi luoghi ad essere coperti da quel campeggio militare. Se poi qualcuno fosse stato a conoscenza che nel giardino della villa era stato sepolto un tesoro, quelle ricchezze avrebbero potuto sparire in pochi minuti. Pertanto Giovanni più che il giardiniere, ormai faceva il cane da guardia dei beni sotterrati pronto in ogni momento ad intervenire
Infatti mai come quel giorno la guardia dovette tenersi alta, anzi altissima; ma non a riguardo di qualche cassetta di sicurezza piena di sterline d’oro oppure banconote, come si potrebbe erroneamente pensare, bensì a causa di una piccola, piccolissima scatoletta di lucido da scarpe, ormai vuota del suo contenuto originario, ma contenente un materiale ancor più esplosivo della dinamite.
Ed in effetti quando Giovanni vide quel maledetto San Marco che, cercando di piantare un picchetto per la tenda, in realtà stava maldestramente demolendo mezzo muro di sostegno della fascia soprastante, si sentì quasi svenire.
Quel disgraziato stava improvvidamente armeggiando proprio su quel muro e proprio a pochi centimetri di distanza da quella pietra, per giunta malferma, che occultava quell’anfratto entro il quale era stata riposta la famosa scatola di lucido da scarpe marca “TANA” entro la quale c’erano le prove fattive che il Conte finanziava la resistenza.
Ansimante e con un groppo alla gola entrò in villa come un turbine senza neanche bussare trovandovi la Signora:
“Signora, siamo messi male; un San Marco ha piantato un picchetto proprio là……se la trovano ci fucilano tutti!”
“Vai là immediatamente e portala via quando non c’è!” commentò la Contessa.
“Eh no, signora, non è così semplice se vado io viene anche lei!”
La Contessa acconsentì ed insieme si incamminarono studiando un piano ed accordandosi sul da farsi.
La Signora simulò allora di transitare di là per caso passeggiando con noncuranza all’ombra del suo abituale ombrellino rosso, facendosi accompagnare dal giardiniere, che a sua volta simulava di spiegarle qualcosa di non ben definito riguardo il parco.
Quando fu nei pressi del milite che stava erigendo la tenda gli si avvicinò e con voce suadente gli disse:
“Ciao bel ragazzo, come ti chiami, da dove vieni?”
Il marò tutto inorgoglito, vedendosi al centro delle attenzioni della nobil signora, si fermò e rispose a tono. Il ghiaccio era rotto e la conversazione era stata instradata, ma, quel che più contava, quello si era bloccato dal demolire ulteriormente il muro.
La Contessa continuò a lavorarsi il ragazzo per qualche minuto poi andò a bersaglio e gli chiese:
“Cosa stai facendo di bello?”
Quello le spiegò che stava piantando una tenda di servizio.
Allora lei lanciò l’affondo finale e con voce e tono molto materni e protettivi lo commiserò così:
“Ma tu non sai cosa stai facendo, povero ragazzo mio, perché quando verranno le piogge qui si allagherà tutto e tu ti ritroverai con l’acqua fin dentro gli scarponi! Sarebbe meglio che tu piantassi la tenda laggiù!” e gli indicò un luogo distante a sufficienza quel tanto che uscisse dal raggio della visuale di quel muro.
Quello abboccò:
“Grazie, grazie infinite signora per il consiglio!” fu la sua replica di getto.
E così in breve rismontò tutto e se ne andò ad installarsi altrove.
A quel punto la prima parte del piano si poteva ritenersi felicemente conclusa, ma quella bomba ad orologeria era ancora là dentro al muro e bisognava assolutamente portarla via perché sui buoni rilasciati dai comandanti partigiani, con tanto di firme, c’erano scritte le cifre con tanto di generalità e passarsela liscia sarebbe stato improbo per chiunque.
La Contessa pertanto ordinò un’altra volta a Giovanni di rimuoverla, ma il pericolo di essere visti da qualcuno in divisa che passasse da quelle parti non era comunque venuto meno poiché era tutto un brulicare di soldati in movimento. Giovanni obiettò nuovamente:
“Eh no signora, il lavoro lo abbiamo iniziato in due e in due lo terminiamo: lei fa la guardia e io recupero la scatola.”
Allora la Signora si pose all’angolo del muro di sostegno della fascia e, non appena il panorama fu sgombero dalla visione di chicchessia, fece un gesto repentino con la mano e Giovanni fu ancora più lesto di un prestigiatore nello spostare il sasso, prendere la scatoletta dal ricovero, mettersela in tasca e ripiazzare la pietra al medesimo posto.
Più tardi Giovanni, meditando sull’accaduto, pensò che era venuto a Stampino per lavorare come aveva sempre desiderato e perché no, per starsene finalmente un po’ in pace e per di più con una paga decente. Invece il destino gli stava riservando emozioni a non finire delle quali avrebbe volentieri fatto a meno non ultima quella di fare anche la quinta colonna della Resistenza. Forse sia a Caporetto, che sul Piave, non si era trovato col cuore così in gola come allora dal momento che, incoscienza dei diciott’anni a parte, quando vestiva la divisa grigioverde il nemico si sapeva bene dove stava e da dove arrivava ed ogni volta che stava per arrivare era preceduto da un terribile fuoco di artiglieria, ma ora se lo ritrovava direttamente e subdolamente in casa e qualsiasi momento poteva essere quello decisivo, ma tant’è, bisognava forzatamente stare all’erta più che sul fronte dell’Isonzo e soprattutto fare buon viso a cattivo gioco.
Comunque, al di là dell’episodio appena riportato, i rapporti tra gli stampinesi e le truppe repubblichine si rivelarono già da subito difficili e pieni di problemi, al contrario di ciò che era avvenuto poco tempo prima con i tedeschi che a Stampino li avevano preceduti.
Ciò accadde sia perché il battaglione di fatto aveva occupato militarmente tutta la proprietà, fatta eccezione appunto per la villa stessa e per la foresteria retrostante, sia perché gli ufficiali erano veri fascisti convinti e sentivano molto la causa cercando di servirla al meglio secondo gli ordini che erano stati loro impartiti, al contrario di ciò che i tedeschi già da subito avevano dimostrato di essere.
A differenza degli ufficiali, la truppa non brillava eccessivamente per attaccamento alla divisa. Sì, certo ci poteva essere qualcuno che sentiva la cosa, ma la maggior parte vestiva quella divisa solo per opportunità in quanto non aveva avuto altre alternative per sopravvivere in quello sfortunatissimo periodo storico.
La truppa comunque era pur sempre composta da ragazzi che, se da un lato cercavano di scansare le operazioni belliche vere e proprie, come d’altronde era logico che fosse, dall’altra parte, però, cercavano indubbiamente di sfruttare la divisa onde trarne qualche piccolo vantaggio personale. Tradotto in termini pratici significava che per quei ragazzi partire armi in pugno ed andare a fare dei rastrellamenti contro i partigiani, non esclusi eventuali scontri a fuoco, non era proprio il massimo della vita e più di uno cercava mille maniere per evitare potenziali incontri ravvicinati con il nemico, come quel ragazzo milanese che più di una volta si era imboscato in maniera originale ed al contempo fantasiosa, facendosi chiudere a chiave nel locale del forno da Giovanni per non essere reclutato in operazioni di giornata. Cionondimeno più di uno approfittava della divisa e delle armi in pugno per andare piuttosto a fare qualche razzia in casa dei contadini onde fare provviste supplettive, dal momento che il trattamento gastronomico che garantiva la Repubblica di Salò si rivelava decisamente scarso sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.
In questo caso le prime vittime della guerra erano veramente i contadini, soprattutto quelli delle borgate dell’interno, che si trovavano stretti fra l’incudine e il martello dato che di giorno erano soggetti agli espropri dei militi repubblichini e nottetempo ricevevano visite dello stesso tenore da parte dei partigiani i quali avevano giustamente fame anche loro e se ne avevano!
I contadini, costretti controvoglia e armi in pugno da entrambe le parti in causa a diventare fornitori alimentari, se da un lato diventavano delle bestie per la protervia e talora la violenza dei San Marco, dall’altra se ne facevano poi ugualmente un baffo che i partigiani rilasciassero loro le ricevute per la roba confiscata con altrettanta violenza, poiché con i buoni rilasciati dalle forze resistenti non ci si riempivano ugualmente la pancia. E poi….. si poteva essere così certi di chi garantiva che quei pezzi di carta un giorno, quando venivano rilasciati, avrebbero valso qualcosa?!?
E così, stretti tra coloro che salivano dal basso di giorno e coloro che scendevano dall’alto nottetempo, tutti i contadini erano sempre lì ad inventarsi qualche nascondiglio particolare per nascondere il cibo, oppure per le fasce a scavare allo scopo di occultare quel poco che riuscivano faticosamente a produrre.
Dulcis in fundo talora ci si mettevano pure i tedeschi, i quali riservavano una vera passione per le uova delle quali erano veramente ghiotti e per le quali andavano matti. Ad onor del vero bisogna precisare che erano degli onesti pagatori. Caso mai la loro pretenziosità si limitava al fatto che esigevano che la merce fosse disponibile, ma poi la pagavano regolarmente senza fare questioni di prezzo. Morale: i tedeschi, ovvero gli invasori cattivi, pagavano regolarmente la merce, mentre noi italiani che eravamo gli invasi e ci contendevamo con una vergognosa guerra civile il diritto ad essere i depositari della legalità, facevamo di tutto per non onorare i debiti con la società civile.
In conclusione, tutto era buono pur di riempirsi la pancia in qualche modo, un po’ di farina, legumi, qualche gallina, delle uova quanto un bell’albero carico di frutti.
A riprova di ciò, non di rado, quando Giuseppina vedeva qualcuno di quei ragazzi che avevano la stessa età di suo figlio che si lamentava della fame che gli batteva nelle costole, presa da sentimento di pietà materna, gli allungava qualcosa da mettere sotto i denti facendogli però al tempo stesso promettere solennemente di non dirlo a nessuno sennò si sarebbe ritrovata la coda davanti casa.
Era estate e guarda caso nelle fasce al limitare inferiore del parco facevano bella mostra di sé due belle piante di fico cariche di frutti.
Un giorno, mentre “u Sciù Giuvanni” se ne stava in terrazza, vide alcuni San Marco che si avventavano su quelle belle piante cariche di frutti, al che, prima che ne fossero stati spogliati completamente, chiamò Giovanni e lo pregò di andare a dire loro che quelle piante possedevano un legittimo proprietario e non erano state messe là per servirsene liberamente.
Giovanni, che era sempre sul chi va là tutto il giorno per via di quell’occupazione forzata, che oltretutto lo aveva sfrattato di casa, obbedì prontamente e quando vide quell’orda di ladruncoli in divisa che si erano avventati sui fichi come delle arpie, non ci vide più e finalmente pensò di avere trovato un motivo valido e fondato per poter far esplodere la rabbia che covava in seno da giorni e giorni, ma soprattutto un obiettivo vivo e vegeto su cui sfogare il livore e il risentimento che quotidianamente lo consumavano.
Oltretutto in quel preciso momento gli era tornato in mente un episodio di molti anni prima, che gli rodeva ancora dentro, quando era giovane ed abitava ancora a Novi Ligure. Infatti un giorno un reparto di fascisti in uniforme stava sfilando per le vie della città e lui se ne stava sul bordo del marciapiede ad osservare la scena come tanti altri. La consuetudine consigliava che al passaggio dei militanti ci si dovesse togliere il cappello in segno di riverenza, ma lui, da buon socialista convinto, non ritenne opportuno farlo. Il fatto non passò inosservato ad uno dei manifestanti, il quale, avvicinatosi velocemente a lui, gli menò una proditoria manganellata in testa senza tanti complimenti che gli fece volare il cappello ad una decina di metri di distanza oltre a procurargli un violento mal di testa che lo accompagnò per molto tempo sia fisicamente, ma soprattutto spiritualmente.
Ecco, in quel preciso momento dopo aver fatto la sommatoria di tutte queste ingiustizie, passate e recenti, scese in basso come una saetta dal cielo ed investì quegli incauti con tutta la voce ed il fiato che aveva nei polmoni e bisogna dire che ne aveva di voce, se ne aveva.
Solo che quelli erano una decina e lui, anche se agiva a nome del legittimo proprietario, era solo. Quelli non si spaventarono più di tanto e risposero per le rime asserendo che loro rappresentavano l’esercito della repubblica ed erano in diritto di fare ciò ed altro ancora.
Come se non bastasse una voce uscita dal coro gli urlò “imboscato!”
Non l’avesse mai detto!!
All’udire quella parola diventò letteralmente una belva.
Giovanni era stato un “ragazzo del ‘98” e ad appena 18 anni era andato in guerra contro gli austro-ungarici stando a lungo in trincea.
Aveva vissuto in prima persona la disfatta di Caporetto, poi, con il proprio reparto del Genio, durante la ritirata aveva contribuito a far saltare l’ultimo ponte rimasto sul Piave sotto il fuoco dei nemici, azione per la quale aveva anche ricevuto una onorificenza sul campo assieme ai commilitoni del reparto. Quindi non poteva certo spaventarsi ora davanti alla protervia ed all’arroganza di quattro ragazzotti di vent’anni anche se in divisa, arrivati da chissà dove, che si comportavano come dei bulletti da strapazzo e che pretendevano di dettare legge a casa sua, ma soprattutto quella parola, quella parola no, non avrebbero dovuto mai dirla: “imboscato”, imboscato a lui che aveva rischiato la vita per l’Italia cento volte sotto le mitragliate e i colpi di mortaio austriaci?!?
“Imboscato a chi – tuonò - a chi imboscato? Sappiate che io ho contribuito a fare l’Italia, io sì!! E voi chi siete, cosa fate? Voi siete l’esercito di Pulcinella, ecco cosa siete, l’esercito di Pulcinella!! Voi la state distruggendo l’Italia che io ho contribuito a fare!!”
La sua reazione leonina per un attimo li disorientò, ma poi, consci del fatto che erano pur sempre tanti contro uno e forti dell’anonimato, un po’ come dei teppisti da stadio, ripresero ad insultarlo con maggior vigoria e dalle parole si stava velocemente scivolando verso i fatti. Senonché, per sua fortuna, dall’alto della terrazza “u Sciù Giuvanni”, che stava seguendo tutta la vicenda da distante e aveva compreso che per Giovanni si stava mettendo male, chiamò velocemente a sé il sempre presente Renato e gli ordinò immediatamente di scendere a dare manforte all’impavido giardiniere, ma soprattutto di portarlo via prima che potesse subire i danni che non gli avevano causato due anni abbondanti al fronte della Grande Guerra.
Renato volò giù e mentre scendeva si era già tirato su idealmente le maniche (dato che aveva già la camicia a maniche corte poichè era estate), pronto a far valere il proprio fisico nerboruto e massiccio e con una gran voglia di togliersi un improvviso prurito alle enormi mani, più simili a dei badili che a delle estremità superiori, prurito che gli era sopravvenuto osservando la scena dall’alto. Anzi, per essere certo di toglierselo meglio, durante il breve tragitto dalla villa agli alberi di fico, si era attrezzato anche di un manico di zappa che aveva trovato abbandonato a terra lungo la via. Quando comparve sulla scena della contesa, anche i più accesi tra i piccoli teppisti compresero al volo che con quel possente bestione armato di bastone era meglio non confrontarsi e, per salvare l’onore senza darsi ad una ingloriosa fuga disordinata, si limitarono a proferire ancora qualche insulto e minaccia generica, ma a debita distanza.
Il giorno successivo Giovanni e Giorgio presero le contromisure e spogliarono completamente gli alberi dei frutti.
Al di là del momento contingente, che obbligava la maggior parte di quella gioventù a vestire una divisa che non sentiva affatto e che se ne fregava altamente del presunto dovere di condurre una guerra fratricida e senza senso contro altri italiani, gli unici veramente motivati erano gli ufficiali i quali nella fattispecie non perdevano occasione per dimostrare di essere solerti e zelanti, applicando alla lettera ed anche oltre le consegne ricevute dalla neorepubblica., soprattutto il comandante.
Il giorno che fucilarono tre partigiani al ponte di Molino Nuovo quando tornarono alla base a Stampino ridevano e sghignazzavano delle vittime fieri del fatto che li avevano …..“ridotti come colabrodi”…..e poi, alla stessa maniera dei legionari che crocifissero Gesù, si spartirono i pochi averi che i giustiziati recavano con sé.
Questa assenza di umanità potevano riversarla tanto nei confronti dei nemici quanto contro le proprie milizie senza differenza alcuna.
Già dai primi giorni in cui i San Marco furono arrivati si era assistito al lento, ma continuo ed inesorabile fenomeno della diserzione da parte della truppa.
Era uno stillicidio continuo; c’era chi se ne andava da solo e chi lo faceva in gruppetti da due o tre alla volta, un po’ per cameratismo, un po’ per farsi coraggio reciprocamente.
Potevano trascorrere alcune settimane durante le quali non gettava la divisa nessuno, ma poi la consuetudine riprendeva e magari disertavano di nuovo parecchi assieme.
Alcuni attendevano l’occasione propizia per ritornare semplicemente a casa e nascondersi in attesa della fine della guerra, mentre altri più idealisti o semplicemente più utilitaristi, andavano ad ingrossare le file della Resistenza portando con sé in dotazione le proprie armi. Altri infine solamente più calcolatori, che, non potendo ritornare a casa in quanto tagliati fuori dalla linea del fronte, andavano nella Resistenza solo per non sottostare agli ordini ed ai pericoli derivanti da qualche ufficiale che prendeva la situazione troppo sul serio come nella fattispecie.
Infatti la gran parte di quei ragazzi era stata reclutata a viva forza ed aveva scelto di aderire alla Repubblica Sociale solo per convenienza del momento e se si presentava l’occasione di svignarsela non se la lasciava scappare di certo. D’altronde quelli che erano veramente convinti nel combattere per la Repubblica si erano arruolati volontariamente nelle Brigate Nere o reparti d’elite similari.
Onde tentare di tenere alto il morale della truppa, un giorno gli ufficiali pensarono di ingaggiare occasionalmente, o per meglio dire, arruolare per un giorno, pure una arcinota meretrice della zona, che nel periodo in questione andava per la maggiore ad Imperia e dintorni. Al fine di avvalersi delle sue particolari prestazioni, alcuni emissari andarono a contattarla e prelevarla direttamente a casa sua in valle Steria recandola a Stampino. Qui le misero a disposizione una alcova di fortuna, ovvero un semplice e spoglio magazzino a pianterreno nell’ala della casa di servizio dove erano alloggiati i tedeschi. Per giaciglio un misero pagliericcio e per toilet un altrettanto misero bugliolo pieno di acqua (!). Un paio di sottufficiali stavano fuori di guardia a regolare il traffico. Comunque, nonostante la reale pochezza di comfort, intimità ed atmosfera, la onesta lavoratrice del sesso ebbe alquanto da fare e comportandosi da vera professionista, nello spazio di un pomeriggio, riuscì a soddisfare le esigenze di tutti coloro che ne vollero approfittare e ci fu anche chi fece il bis. Verso sera riprese le sue poche cose, ma soprattutto la propria borsa piena di soldi e facendosi riportare a casa.
Nonostante occasionali e rari diversivi come il sopracitato, il morale dei soldati languiva e l’entusiasmo di vestire la divisa lasciava facilmente il posto alla nostalgia per la casa natia, ragion per cui le diserzioni continuavano.
Questo continuo calo di forza dovuto a diserzione, o, peggio ancora, a tradimento, aveva il potere di incattivire ulteriormente quegli ufficiali già di per sé non propriamente atti alla benevolenza, al punto che non esitarono a condannare a morte mediante fucilazione alla schiena, in quanto traditori, due dei loro che facevano il doppio gioco, poiché, seppur continuando a vestire la divisa della Repubblica Sociale, in realtà tenevano rapporti con la resistenza locale cercando di farne adepti. I due poveretti, scoperti e condannati, furono fucilati sulla spiaggia nei pressi del bunker di ponente.
Andò male anche a quel marò che quella mattina presto aveva tentato a propria volta la fuga e che per sua malasorte si fece riprendere mentre percorreva la galleria ferroviaria tra Andora e Laigueglia e ne fece le spese anche per tutti i suoi predecessori.
Lo riportarono a Stampino al cospetto del comandante e costui riversò sul malcapitato tutta la propria frustrazione ed il proprio risentimento per la piega che stavano prendendo gli avvenimenti sia a riguardo del reparto sia della guerra più in generale.
Dapprima iniziò ad insultarlo e minacciarlo di farlo fucilare lì su due piedi per direttissima, poi prese a schiaffeggiarlo e percuoterlo.
Il poveretto ad un certo punto cadde a terra implorando pietà, ma il feroce aguzzino non si placava minimamente ad anzi lo prendeva a calci con ostinata insistenza manifestando una cattiveria ed una compiaciuta soddisfazione nel fare ciò.
Il ragazzo piangeva ed invocava la mamma stando istintivamente raggomitolato a terra per ripararsi dalla gragnuola di colpi che l’ufficiale gli riversava addosso.
A quel punto, siccome la punizione sommaria stava consumandosi nell’ufficio personale del comandante, ex salottino della casa di Giovanni, e nella stanza di fronte era ubicata la cucina entro la quale in quel momento si trovava Giuseppina, questa non ne potè più di assistere a cotanto scempio ed esplose facendo valere tutto il proprio cuore di mamma. Si fece avanti senza alcun timore ed apostrofò in malo modo il maggiore:
“Ma non ne ha vergogna per quello che sta facendo? Ma non se ne rende conto di come si sta comportando? Neanche le bestie si trattano così! Se lei ha un briciolo di cuore e di coscienza si deve solo vergognare, ecco cosa deve fare!”
Ma siccome il cuore del dirimpettaio era veramente inesistente e la pietà un termine assolutamente sconosciuto, il risultato fu solo la sospensione di quello strazio per pochi secondi poiché ne sortì solamente un’ulteriore minaccia e stavolta nei suoi confronti:
“Signora, se lei non si ritira immediatamente prima di tutto non metterà più piede in questa casa e poi mi vedrò obbligato a prendere dei provvedimenti anche nei suoi confronti! Ha capito? Sono stato chiaro?”
Quelle parole, per giunta proferite in un modo che non lasciavano spazio alcuno alla speranza, risultarono più che una minaccia e così con il cuore sanguinante ed il volto rigato dalle lacrime Giuseppina dovette farsi da parte e ritirarsi.
Alla fine dei maltrattamenti il poveretto fu preso in consegna e portato altrove per essere sottoposto a giudizio di fronte alla corte marziale.
Non se ne seppe più nulla, anzi, nei giorni successivi si mormorò che anche lui fosse stato fucilato.
Anche se quel duello impari si era concluso in pochi secondi e a favore del più forte, come del resto era logico che fosse, comunque la piccola Giuseppina, un metro e sessanta con i tacchi, non si scoraggiò affatto. Anzi, quell’episodio ebbe il potere di rinvigorirle le forze e di far giurare a sé stessa che gliela avrebbe fatta pagare cara a quel brutto elemento crudele e senza dio e nella sua mente immaginava già come.
Infatti abbiamo visto come il comandante, quando era giunto a Stampino, l’avesse sfrattata in quattro e quattr’otto senza tanti complimenti e solo dopo una tenace contrattazione le avesse concesso a fatica di conservare l’uso della cucina.
Ma quella che il maggiore reputava fosse stata una qualsiasi concessione nei confronti di una noiosissima e fastidiosa massaia che non possedeva più un fornello su cui spignattare, col tempo si sarebbe rivelato essere un errore imperdonabile.
In effetti sulle prime Giuseppina non aveva fatto caso ad un certo particolare, ma col passare dei giorni si era resa conto che quando nella stanza di fronte, dove era situato l’ufficio personale del comandante, si riunivano gli ufficiali per discutere, se si tendeva l’orecchio si riusciva quasi ad ascoltare le conversazioni. Se poi si lasciava la porta della cucina socchiusa e per giunta qualcuno dei presenti alzava un po’ i toni, si riusciva a carpire il senso dei discorsi molto bene.
A questo punto decise di simulare di rigare diritto, ma al contempo di marcare stretto il tizio e di sfruttare al meglio quell’insolito e quanto mai provvidenziale punto d’ascolto ogni volta che il comandante entrava in casa coi suoi più stretti collaboratori.
Fu così che più di una volta riuscì a carpire segreti ed a sapere in anticipo le mosse del battaglione che negli intenti del capo doveva ovviamente condurre una feroce e serrata lotta contro le bande ribelli.
Non appena veniva a conoscenza di qualcosa che le truppe repubblichine avrebbero dovuto fare il giorno successivo, Giuseppina si premuniva di attivare immediatamente una staffetta partigiana trasmettendole le preziose informazioni.
Altre volte, quando non era possibile passare le informazioni in quel di Stampino, poichè i controlli erano troppo stretti oppure le staffette non erano disponibili, allora si recava essa stessa di persona verso sera alla Ferraia dove poteva trovare i contatti giusti per passare le notizie di giornata.
Tutto ciò, se da un lato risultava un aiuto inaspettato per la lotta di liberazione locale, però dall’altra aveva il potere di rendere ulteriormente insonni le notti di Giovanni, il quale riprovava il comportamento della moglie, ed a ragione, poiché riteneva che fosse troppo pericoloso.
Infatti andava ripetendole continuamente:
“Un bel giorno ti scopriranno ed allora ti fucileranno! Oh si, si, ecco cosa faranno, ti metteranno al muro e ti fucileranno!”
Ma per fortuna di Giuseppina o per grazia di qualche santo protettore delle massaie ciò non avvenne mai e fu così che raramente i San Marco riuscirono ad agganciare o sorprendere le bande partigiane in valle e ciò grazie anche al contributo di una normalissima ed insospettabilissima donna di casa madre di famiglia, la quale, ogni qual volta c’era una riunione ufficiali si trovava casualmente nella stanza di fronte a cucinare.
LO SCEMO
Era quasi mezzogiorno e Giovanni si era già riportato nei pressi di casa in attesa che Giuseppina lo chiamasse al desinare dopo aver trascorso la mattinata ad aiutare Pellegrìn a rifare un muro a secco.
Stava pigramente appoggiato al muretto di sostegno del piccolo giardinetto prospiciente l’ingresso di casa, godendosi il tiepido sole invernale e fumandosi con voluttà una sigaretta fatta con la cartina, quando la sua attenzione fu attratta da un vociare che si avvicinava salendo da sotto.
Ancora pochi istanti e vide apparire una squadra di marò che arrancava faticosamente su per l’ultima ripida erta che termina nel piazzale esterno, proprio di fronte a casa sua, entro la quale era situato il comando.
I soldati, al contrario delle altre volte, non erano soli, insieme a loro c’era anche un civile che scortavano assieme al suo mulo caricato con la soma.
Il volto del civile non gli era proprio nuovo, ma non lo conosceva bene e men che meno per nome, anche se a prima vista gli pareva che fosse uno che abitasse nella valle di Cervo, dalle parti di Chiappa.
Incuriosito dalla situazione stette ben attento, cercando di capire ciò che stava accadendo.
Il caposquadra entrò in casa ed andò a chiamare il comandante, che, nel frattempo, era cambiato.
A conti fatti costui si sarebbe rivelato meno efferato e crudele del precedente, comunque non c’era ugualmente da scherzare in alcun modo: la lotta senza quartiere alle forze partigiane resistenti continuava su tutto il fronte.
Pochi istanti dopo il caposquadra ne uscì con il comandante mentre gli spiegava ciò che era avvenuto.
Costoro, come altre volte, erano stati inviati in missione a controllare i sentieri collinari dove istituivano dei posti di blocco onde evitare che si praticasse il mercato nero oppure, ancora peggio, che i partigiani potessero muoversi tranquillamente e senza ostacoli di sorta.
Al Passo di Chiappa avevano pizzicato un civile, all’apparenza un contadino del luogo, che con il proprio mulo tra le altre cose portava anche dei fucili.
Certo, un carico di fucili da caccia sarebbe stato già più che compromettente, figuriamoci poi se quelli erano da guerra, come nell’occasione.
Il poveraccio se ne stava a capo chino a tal punto che non esponeva neanche il volto tanto che era frastornato dalla situazione. Probabilmente aveva già dovuto sottostare alle precedenti domande e minacce da parte del sottufficiale che lo aveva catturato, ma ora lo attendeva l’interrogatorio da parte del comandante del presidio e la situazione non prometteva assolutamente nulla di buono.
Il tenente gli si parò di fronte ed andò subito al sodo:
“Chi sei, come ti chiami e dove stavi portando quel carico di armi?” furono le prime scontatissime domande che gli pose.
Ma il poveraccio stava zitto e non rispondeva una sillaba.
L’inutile interrogatorio si ripetè diverse volte e ciò ottenne il solo risultato di rendere ancora più nervoso e incarognito l’inquisitore, che ovviamente cominciava a minacciarlo di mandarlo di fronte al plotone d’esecuzione lì su due piedi e senza tanti complimenti se non avesse parlato.
Giovanni era veramente in ambasce per quel poveretto che stava veramente rischiando la vita ed avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di aiutarlo a trarsi d’impiccio, ma non sapeva proprio cosa fare perché era una situazione veramente insostenibile. Quel carico di fucili sistemato sul suo mulo era un’accusa pesante come il piombo e talmente evidente che non lasciava spazio a nessuna via d’uscita.
Stava arrovellandosi su tutto ciò, quando ad un certo punto il tenente, sempre più impaziente ed incattivito, gli urlò:
“Rispondimi, ti ordino di rispondermi, hai capito o sei sordo?”
“Sei sordo?”, sordo no, ma..... scemo….. forse si! Ma certo! Pensò tra sé e sé. Quella poteva essere un’idea, azzardata fin che si vuole, ma in fin dei conti forse era l’unica ipotesi valida e l’unica speranza cavalcabile in una situazione disperata come quella.
Non fece nemmeno in tempo a fare due calcoli mentali su cosa avrebbe rischiato personalmente nel caso fosse andata male che prese la decisione di buttarsi allo sbaraglio e di recitare come un attore consumato.
Uscì dalle quinte con passo deciso e si fece avanti di getto dirigendosi verso il tenente con fare apparentemente sicuro e convinto dicendogli:
“Tenente, lei pensa di aver a che fare con una persona normale, ma guardi che quest’uomo è scemo!
Io questo qui lo conosco, è di Chiappa ed è lo scemo del paese! A Chiappa e dintorni lo sanno tutti che è come un bambino e si divertono a fargli fare le cose più impensabili e ridicole senza che lui se ne renda conto! A volte fa delle cose che nessuno farebbe, ma lui non se ne rende assolutamente conto, oltretutto non sa neanche parlare in maniera chiara e comprensibile e ancor meno difendersi proprio perché è privo di volontà! Guardi!”
E così dicendo, prima che l’ufficiale potesse obiettare qualcosa, si avvicinò all’uomo quel tanto che bastò per mettersi tra lui e l’altro in modo da potergli strizzare l’occhio e fargli una smorfia col viso, senza essere visto dagli altri, come a significargli che lo assecondasse nella sua recita e lo sostenesse nelle ulteriori mosse.
“Guardi signor tenente! Guardi che cosa gli faccio e lui non reagisce!”
Al chè gli tirò un paio di ceffoni e quello si mise a piagnucolare con le mani sul volto rannicchiandosi per terra.
Per fortuna di entrambi quello sventurato aveva compreso e stava collaborando.
Gli tirò ancora un paio di calci e quello continuò a lamentarsi dicendo solo: “No, no, nooo!” e farfugliando frasi indistinte proprio come si sarebbe comportato un bambino inerme.
“Può interrogarlo finchè vuole, ma non so proprio cosa le saprà dire, magari è arrivato qualcuno da fuori, che neanche lui conosce, il quale gli ha dato un fiasco di vino in cambio del favore di trasportare il carico, qualcuno che sapeva bene i rischi che si correvano a trasportare quel carico!
A Chiappa e dintorni lo sanno tutti che è scemo!” ribadì ancora una volta.
Quindi tacque e scrollò il capo con gli occhi rivolti al cielo in direzione del tenente con un’espressione del viso tale, come a voler dire che dove non ce n’è non se ne può prendere.
L’ufficiale ristette qualche secondo pensieroso ed in silenzio, volgendo ritmicamente ed alternativamente lo sguardo sia verso il prigioniero sia verso Giovanni, quasi a voler valutare sia l’uno sia l’altro, istanti che a Giovanni sembrarono un’eternità durante i quali il suo cuore non batteva nemmeno più e le sue gambe avevano perso molto della sicurezza con la quale era entrato in scena. Furono istanti durante i quali rimpianse perfino gli austriaci di bellica memoria
Alla fine di quei pochi, ma eterni istanti, il comandante allargò le braccia e le sbattè sui fianchi con un’espressione mista tra lo sconfortato, il deluso, l’incazzato.
Aveva pensato di aver catturato una pedina interessante per capire da dove e come arrivavano i rifornimenti ai partigiani ed invece si ritrovava tra le mani un imbecille che non sapeva nemmeno riferirgli le proprie generalità.
Lanciò un’imprecazione e poi un’altra ancora, quindi, schiumando rabbia, diede l’ordine di rilasciare quel “deficiente”.
I sottoposti fecero capire al prigioniero che era libero e poteva togliersi dai piedi e subito Giovanni si offerse di accompagnarlo poiché, a suo dire, non sarebbe stato nemmeno in grado di “ritrovare la strada di casa”.
Non appena ebbero girato la prima curva Giovanni tirò un respiro così profondo che inalò, oltre che dalla bocca, anche da tutti gli altri orifizi di cui disponeva, ma, paradossalmente, l’altro invece di ringraziarlo per tutta la vita, cominciò a lamentarsi che gli avevano sequestrato il mulo e che quasi quasi voleva tornare indietro a reclamarlo.
“Sì, bravo - proruppe Giovanni- così se non l’hanno capito prima che non sei assolutamente scemo, lo capiranno ora e così, oltre che te, fucileranno pure me!!
Se non ti hanno ammazzato loro ti ammazzerò io con le mie mani se non ti togli immediatamente dai piedi ed al più presto possibile!!”
Allora il mulattiere gli domandò:
“Ma sei sicuro che mi volesse fucilare veramente?”
“Sai quanti ne hanno già fucilati questi? Vattene immediatamente prima che ci ripensi, sparisci coglione!!”
Il mulattiere, anche se a fatica, finalmente comprese il rischio corso e, mulo o non mulo, ripresa la mandamentale a grandi falcate, un minuto dopo era già oltre la chiesa di San Giovanni che volava su per la collina sul sentiero per Chiappa.
Giovanni non lo vide mai più, nemmeno a guerra finita, e un po’ ci rimase male perché almeno un “grazie”, anche a distanza di tempo, pensava di esserselo meritato….. che fosse un po’ scemo per davvero?
I TEDESCHI
I soldati della neonata Repubblica di Salò, in ogni caso, non erano poi stati così originali nello scegliere di stanziarsi dalle parti della villa, poiché un paio di mesi prima erano stati preceduti da un manipolo di tedeschi che facevano parte del reparto adibito al presidio territoriale della zona.

Costoro appartenevano alla 13° Compagnia della 34° Divisione Fanteria della Wehrmacht. Questo reparto dapprima era stato inviato ad Alassio, ma siccome sul territorio alassino i partigiani non costituivano un grosso problema, erano stati successivamente deviati ad Andora, dove la lotta partigiana era viva ed i ribelli numerosi. Sulle prime si erano stabiliti a Molino Nuovo a Villa Musso, ma in seguito, perseguendo un preciso ed alquanto furbesco disegno, decisero di trasferirsi alla corte di Quaglia onde poter essere più tranquilli ed al riparo da eventuali attacchi nemici. in quanto, in base ad un ragionamento tutto loro, reputavano che a casa dei ricchi sarebbe stato molto difficile che si sarebbero verificati episodi bellici e pertanto anche loro ne avrebbero indirettamente beneficiato.
Quando salirono a Stampino per manifestare la loro intenzione Quaglia non la prese proprio bene. Per non esasperare la situazione ed addivenire ad un accordo utile per tutti, le parti interessate pensarono bene di invitare in loco Guido Gagliolo in qualità di interprete e mediatore, che già altre volte aveva svolto questo delicato ruolo diplomatico tra andoresi e tedeschi dato che era l’unico locale pratico della lingua teutonica.
I tedeschi, risoluti e gentili al tempo stesso, fecero capire che era assolutamente nelle loro intenzioni insediare un drappello fisso a Stampino e che ciò sarebbe stato utile a tutti e magari anche al Conte stesso.
Quaglia, che era abituato a vagliare al volo uomini e situazioni, non impiegò molto a comprendere con chi avesse a che fare e soprattutto a capire le reali intenzioni delle persone che aveva di fronte, quindi acconsentì, a patto però che non gli occupassero una sola stanza della villa.
Trovato l’accordo, si stabilirono nella parte più a monte della casa dove abitava Giovanni, quella posta più a settentrione.
Comunque, quantunque i tedeschi fossero preceduti da una fama tutt’altro che rassicurante e a volte ancor più sinistra dei fascisti, quelli di stanza ad Andora non si rivelarono mai e poi mai più feroci di tanto, anzi, averne qualcuno come loro a così stretta vicinanza, col tempo si sarebbe rivelata una scelta quanto mai felice ed opportuna e forse Quaglia l’aveva compreso sin da subito.
A Stampino erano solo una squadra, non più di dieci o quindici, ma la loro presenza era ancora più discreta del già loro esiguo numero.
Oltre che alla villa erano presenti anche al Gumbasso, nelle cui stalle avevano alloggiato alcuni cavalli adibiti al traino di un grosso carro, un “tamagnone”, usato sia per i servizi, sia al trasporto di alcuni pezzi d’artiglieria.
Anche un paio di cannoni furono portati a Stampino e sistemati nella zona verso il bosco presso il laghetto, quantunque anche i San Marco disponessero già di per sé di una squadra di mortaisti. Ogni tanto tiravano qualche colpo, tanto per tenere attivi i pezzi, e, per non correre il rischio di creare danni a cose o persone, lo scaricavano verso il mare. Questo fatto però inquietava fortemente le beghine della parrocchia, le quali temevano fortemente che i tiri potessero essere troppo bassi e perciò colpire il campanile della chiesa di San Giovanni. Comunque il presunto pericolo era solo nella loro testa e alla fine le uniche vittime di quei rari colpi furono solo gli sfortunati pesciolini che ebbero la sventura di nuotare troppo in superficie laddove caddero quei proietti.
Gli addetti alle bestie alloggiavano al Gumbasso e con loro c’era il veterinario militare che con il tempo aveva fraternizzato con il medico condotto di allora, il Dott. Caviglia, con il quale si fermava spesso a parlare, essendo entrambi uomini di medicina, seppur con competenze notevolmente diverse, dedicandosi notoriamente l’uno ai quadrupedi e l’altro ai bipedi.
Resta singolare il fatto che, non avendo nessuno dei due conoscenza della lingua dell’altro e non possedendo nemmeno un’altra lingua viva in comune con la quale poter comunicare, non avevano trovato altro idioma parimenti e reciprocamente conosciuto per conversare che….. il latino, sì proprio il latino di ginnasiale memoria.
Gli estemporanei ed occasionali spettatori dei loro discorsi rimanevano interdetti da quel declinare di sostantivi e coniugare di verbi, ma, a quanto pare, si intendevano benissimo ed ogni tanto si facevano pure qualche risatina…..e poi dicono che il latino è una lingua morta e smorta. Evidentemente l’avevano studiato bene!
“U Sciù Giuvanni” per parte sua, al contrario di quanto sarebbe poi accaduto coi San Marco, legò subito coi rappresentanti della Wehrmacht, a tal punto che talvolta qualche sottufficiale era suo gradito ospite al desco in villa. Per non parlare poi dei pressoché quotidiani omaggi a base di bottiglie di vino che loro elargiva, perseguendo l’intento nemmeno poi tanto segreto di tenerseli buoni.
Forse quelle presenze straniere, seppur in una situazione del tutto particolare, ridestavano in Quaglia il suo innato spirito cosmopolita, però il rapporto era sincero e non di facciata.
Gli unici tedeschi che avrebbero potuto rappresentare un problema erano la squadra di “SS” che alloggiava alla Marina e che aveva pensato bene di stanziarsi in una casa privata dell’allora Strada della Stazione poi diventata nel dopoguerra via Carminati. Guarda caso quella casa era proprio quella del già noto primo elettricista andorese Marco Soleri “Burrasca”. Al tempo della guerra “Burrasca” era già prematuramente trapassato da una decina d’anni, ma aveva lasciato due figlie, una delle quali, di nome Lea, pur essendo femmina all’anagrafe, aveva ereditato annessi e connessi di cotanto padre. Seppur obbligata a trasferirsi altrove per via dello sfratto impostole dall’occupante straniero, ciononostante non demordeva affatto. Anzi, nonostante i ripetuti avvertimenti da parte del marito Emanuele “Nello” Codino di mantenere una condotta prudente, pressoché quotidianamente ritornava a controllare la casa affinché tutto fosse a posto ed in ordine, fregandosene altamente che quelli fossero i pretoriani di Hitler. Infatti il giorno che si accorse che alcuni mobili erano stati spostati, ma soprattutto alcune suppellettili erano scomparse, e la ragione era che anche le famigerate “SS”in fin dei conti erano dei giovanotti, i quali, per farsi belli presso qualche ragazza locale, non avevano esitato ad omaggiarla del primo oggetto regalo venuto loro sotto mano in quella casa, Lea, di nome e di fatto, fece una scenata tale che chi se la fece sotto furono proprio le “SS” tanto che strillava ed inveiva. Il marito per parte sua rimase talmente impressionato, ma soprattutto impaurito dalla reazione della moglie che, temendo come risposta una feroce controreazione da parte tedesca, fuggì e si fece ricoverare in una clinica privata di Alassio per alcuni giorni. Ad ogni modo, alla fine l’ebbe vinta l’indomita Lea “Burrasca”, che riebbe la casa ammobiliata come prima ed anche indietro gli oggetti indebitamente regalati: la ligurità di Lea era riuscita a sottomettere anche i più feroci nazisti!
Comunque fosse, in pratica i tedeschi si limitavano a controllare la situazione generale in valle con discrezione e, dopo l’arrivo dei repubblichini, anche il loro operato e, mai e poi mai, nemmeno una volta, premettero il dito sul grilletto per colpire un potenziale nemico.
Non spararono con la contraerea di cui disponevano, posizionata in alcuni punti sul territorio comunale, nemmeno quando gli aerei americani bombardarono in pieno giorno la ferrovia un paio di volte.
Il primo bombardamento fu quando colpirono la linea lungo la costa all’altezza dell’attuale Hotel Trieste nel mese di giugno. La ferrovia venne danneggiata seriamente e rimase interrotta praticamente per tutta l’estate al punto che parecchie famiglie andoresi che vivevano lungo la linea ferrata, onde non correre ulteriori pericoli durante eventuali altri bombardamenti, decisero di trasferirsi dentro le gallerie della ferrovia stessa. Al loro interno, avendoci trasportato brande e tavoli, ci passavano la notte e ci pranzavano. Se ne andarono solo quando la linea fu ripristinata.
Il secondo bombardamento avvenne quando si avventarono contro il ponte ferroviario sul Merula il 26 luglio 1944. I bene informati, a bombardamento avvenuto, dissero che erano piovute dal cielo ben 82 bombe; però stavolta la precisione fu relativa, poiché molti proietti piovvero veramente distante dall’obiettivo, quasi tutti a monte del ponte, alcuni perfino nel greto del Merula davanti ai Lanfredi.
Che qualche puntatore da lassù in alto avesse scambiato le traversine con le quali era stato realizzato il ponticello di Moltedo per la linea ferroviaria? Più probabilmente il comandante dello stormo inviato a bombardare il ponte, non voleva correre il rischio di essere colpito dalla contraerea e quindi aveva scelto di rimanere ad una quota di assoluta sicurezza anche se ciò comportava necessariamente una minore precisione nel puntamento dell’obiettivo.
Comunque fosse stato, per fortuna non si riscontrarono danni alle persone né alle cose, anche perché allora la densità abitativa era infinitamente inferiore a quella attuale, solamente il naturale spavento dovuto all’evento eccezionale ed una enorme nuvola di polvere. Il ponte ferroviario risultò danneggiato solamente nell’arcata più a levante, mentre le altre due rimasero indenni al punto che i treni, seppur molto lentamente, in capo ad alcune settimane, poterono riprendere a transitare sul ponte che presentava un’arcata restaurata provvisoriamente in legno. Quando il traffico ferroviario riprese, i treni, dovendo transitare su un ponte precario, erano obbligati a procedere a passo d’uomo. Allora i soliti opportunisti pensarono bene di approfittarsene subito per viaggiare a scrocco: infatti diventò prassi abituale veder gente in attesa del treno non in stazione, come consuetudine avrebbe voluto, ma lungo la massicciata della ferrovia all’altezza del ponte sul Merula onde poter salire al volo.
I tedeschi, come non spararono contro i bombardieri, così non aprirono il fuoco neppure contro i caccia nemici che di tanto in tanto mitragliavano le loro batterie sulle alture. Sempre a proposito di incursioni dal cielo una volta questi ultimi fecero un raid in valle mitragliando ripetutamente dei potenziali obiettivi militari, riuscendo solo a colpire ed incendiare una camionetta dei San Marco che risaliva Via Merula all’altezza dell’attuale ponte autostradale. Gli occupanti si salvarono gettandosi nella cunetta prima che il mezzo fosse colpito. Un’altra volta fu il turno di una squadra di San Marco che svolgeva il compito di guardialinea alla ferrovia con base in un casello posto all’altezza di capo Mimosa. Videro avvicinarsi un aereo nemico che prese a roteare minacciosamente su di loro al che, non comprendendo bene cosa avesse intenzione di fare, pensarono bene di fuggire ed andare a rifugiarsi nel condotto del ruscello che passava sotto la ferrovia posto appena sotto la piccola costruzione: mai scelta si rivelò più saggia poiché pochi istanti dopo una bomba ridusse ad un cumulo di macerie il casello.
Ritornando ai tedeschi, non fecero ricorso alle proprie armi in dotazione personale nemmeno quella volta in cui un caccia passò talmente basso sulla villa da rasentare la cima degli alberi, compresa la chioma dell’enorme platano che fa ombra alla terrazza, permettendo a Giovanni di riuscire a distinguere nettamente la stella bianca a cinque punte dell’esercito americano sul casco del pilota.
Di operazioni sul territorio contro i partigiani poi, neanche a parlarne, era come se non esistessero.
Al massimo conducevano qualche civile arruolato nella “Todt”, l’agenzia governativa tedesca preposta alla difesa, a scavare qualche trincea nei terreni prospicienti la spiaggia o sui crinali delimitanti la valle, laddove ancora oggi sono facilmente distinguibili dal colle del Castellaretto fino al Pizzo Muntin.
Sembrava che per loro la guerra fosse stata solo uno spiacevole incidente di percorso riservatogli dal destino o poco più.
D’altronde il loro comandante, l’Oberleutnant Helmut Geiersbach, proveniente da Coblenza, che nella vita civile esercitava la professione di magistrato, non manifestò mai nei fatti di essere un fanatico nazista, anzi in un momento confidenziale un giorno confessò a Guido Gagliolo che lui “non era il magistrato di Adolfo” (Hitler).
A proposito di capi, il comandante del piccolo presidio stampinese era il Maresciallo Heinrich Kaptein, proveniente da un paesino in provincia di Coblenza, che proprio nella città capoluogo faceva il giornalista alla “Rhein Zeitung”. Insomma, egli era una persona di un certo livello culturale e che possedeva certi valori, allora già sposato e padre di un bimbo. Nel contesto andorese era solito fare coppia abituale con il Caporale Karl Kappes, pure lui proveniente da un paesino di campagna situato nelle vicinanze di Coblenza. Avevano entrambi fatto la campagna di Russia, alla pari dei camerati di reparto, e tutta la ritirata a piedi sotto il fuoco ricorrente della controffensiva russa. Ciononostante erano riusciti a ritornarne vivi, il che non era poco. Kappes era rimasto gravemente ferito a Kiev ed era stato convalescente alcuni mesi prima di ritornare abile al reparto. Entrambi ne avevano più che abbastanza della guerra e i loro piedi bruciavano ancora tanta era stata la strada fatta per tornare in patria. Tanto per questi motivi quanto per altri più strettamente personali, fin dal primo momento della loro presenza a Stampino, dimostrarono quale fosse la loro vis pugnandi e quali fossero i loro reali obiettivi bellici. Infatti essi erano rappresentati dalle osterie, possibilmente dotate di buon vino e dalle feste paesane preferibilmente condite di belle ragazze, ancor meglio se compiacenti.
Eh si, perché Kappes di vino se ne intendeva, in quanto nella vita civile era viticoltore e coltivava i suoi vigneti nell’azienda di famiglia a Zeltingen lungo le rive della Mosella. Quindi per lui e l’inseparabile maresciallo, tappa fissa giornaliera e doverosa era quella presso l’osteria con locanda di Pietro Galleano, detto il “Grillo”, a Molino Nuovo. Era frequente vederli rientrare la sera a Stampino allegri e rubizzi, soprattutto Kaptein, che non era abituato a bere, intenti a canticchiare qualche motivo in lingua madre o talvolta qualche strofa in italiano imparata ai tavoli dell’osteria da qualche elemento locale.
Complice anche l’opera di presentazione e mediazione di Giorgio che, alla pari degli altri stampinesi, aveva subito legato con loro e che a volte li accompagnava in quel peregrinare giornaliero, poco a poco divennero familiari alla gente del luogo, che imparò se non proprio ad apprezzarli comunque a rispettarli. Il meglio doveva ancora venire poiché al pomeriggio, al “Dopolavoro” di Molino Nuovo, soprattutto la domenica, si suonava e si ballava ed i tedeschi di cui sopra erano ospiti fissi e con loro ne arrivavano pure degli altri.
Al contrario, i San Marco non erano della partita, poiché i tedeschi si erano furbescamente arrogati il diritto dovere di controllare l’ordine pubblico nel locale in prima persona e così avevano automaticamente escluso i fascisti.
Tutta la gioventù della zona si recava a ballare al “Dopolavoro” e Giorgio non era da meno, poichè si divertiva anche a suonare e fare virtuosismi col suo amato mandolino.
A volte la vicenda si dipingeva di grottesco e surreale perché assieme a loro erano presenti anche dei giovanotti locali che militavano tra i partigiani, i quali, essendo in fin dei conti dei ragazzi di vent’anni od anche meno, pericolo o non pericolo, non resistevano alla tentazione di scendere dalla montagna per tornare un momento a casa o ancor meglio per divertirsi un po’ sentendo musica e ballando con qualche ragazza.
Era praticamente impossibile che i tedeschi non lo sapessero, anzi ne erano perfettamente a conoscenza, perché conoscevano benissimo le identità di quei ragazzi, la loro condotta di vita e la loro situazione: renitenti che si nascondevano, o, ancor peggio, partigiani alla macchia. Ogni tanto chiedevano qualche informazione a Giorgio su questo o quello e Giorgio da parte sua cercava sempre di essere diplomatico o minimizzare. Essi capivano tutto e lo facevano solo a scopo di curiosità personale e per sapere come comportarsi, ma mai per schedare o perseguire qualcuno. Che quei ragazzi fossero partigiani o meno non interessava a nessuno e men che meno ai tedeschi anche quando dalle loro tasche traspariva un abnorme gonfiore sospetto che faceva intendere che dentro la tasca fosse celata una pistola.
Nessuno si poneva il problema che da un momento all’altro si potesse rompere l’incanto, perché ciò che prevaleva in tutti era la voglia di spensieratezza e divertimento. Sembrava quasi che quello fosse un territorio franco al pari di una chiesa o un’ambasciata: ognuno si faceva i fatti propri cercando di divertirsi come meglio poteva e portava rispetto per l’altra parte. Infatti fin dal primo momento del loro arrivo quei tedeschi avevano cercato di instaurare un rapporto con la popolazione locale, dimostrandosi umani e comprensivi oltre ogni immaginazione, tanto che ad un certo punto avvenne addirittura la fraternizzazione con i partigiani stessi, i quali si guardarono bene dal rompere quell’idillio.
L’unica volta in cui i partigiani rivolsero le loro attenzioni contro un obiettivo tedesco fu nel maggio del’44, ma non fu contro dei militari, bensì contro un treno merci che era rimasto bloccato in stazione ad Andora a causa dell’interruzione della linea dovuta al bombardamento del ponte ferroviario sul torrente Steria nel comune di San Bartolomeo del Cervo.
Il podestà Vatterone era stato informato dal capostazione Randone che il treno, carico di ogni genere di conforto e generi alimentari destinati alle truppe tedesche dislocate in Francia, avrebbe dovuto stare fermo in stazione fino al ripristino della linea.
“Pippo” Vatterone, oltre a quello di podestà, ricopriva anche l’incarico di segretario della sezione andorese del Partito Fascista, ma non per ciò, essendo dotato di grande senso di equità e responsabilità, non disdegnava di passare quotidianamente informazioni ed aiuti concreti tanto alla popolazione civile quanto ai partigiani. Quest’ultimi scesero prontamente dalle colline ed attuarono un blitz.
Nottetempo, complice pure il fatto che i tedeschi locali non avevano disposto guardie armate a tutela del convoglio, scesero e svuotarono i vagoni caricando tutto su alcuni carri trasportando il bottino a Stellanello. Il resto del saccheggio fu completato dalla popolazione con grande soddisfazione da parte di tutti gli andoresi.
Al termine di questo episodio, l’unico che non ci guadagnò materialmente nulla, pur essendo stato l’ideatore ed il regista dell’operazione, fu proprio il “fascista” Vatterone che, anzi, dovette subire le ire dei tedeschi scontando alcuni giorni di prigione, ma c’è anche da sottolineare che Geiersbach non aveva messo alcun soldato a guardia del treno e quindi qualche sospetto circa una loro potenziale collusione poteva essere giustamente ipotizzabile: insomma si può supporre che avessero realizzato una bella sceneggiata in cui tutti i protagonisti avevano recitato alla perfezione.
Se da una parte i partigiani ignoravano totalmente i tedeschi, anzi avevano addirittura fraternizzato con loro, tuttavia dall’altra, non ignoravano i fascisti, presenti sotto forma dei San Marco, verso i quali continuavano a tenere una certa costante pressione, onde fiaccarne il morale già di per sè stesso non al massimo.
Una delle loro azioni abituali e ricorrenti era scendere e posizionarsi a metà pomeriggio nella curva dei cipressi della strada che porta a Conna e tirare un paio di raffiche verso l’abitazione che ospitava i San Marco a Molino Nuovo, quasi a voler ricordare loro che erano ben vivi e presenti e che li aspettavano al varco. Poi, come erano apparsi, altrettanto velocemente si dileguavano prima che gli altri potessero rispondere. Erano più che altro azioni “mordi e fuggi” che miravano a snervare il nemico tese a ricordargli che poteva essere colpito anche a domicilio. Il vero e ultimo scopo di quelle azioni di guerriglia era quindi di indurlo alla diserzione ed al tradimento.
Una notte con un temerario colpo di mano osarono molto di più, arrivando addirittura a fare decine di prigionieri direttamente in caserma a Molino Nuovo e bottino di armi e munizioni. Gran parte dei prigionieri abbracciò la causa della lotta di liberazione.
Un’altra azione temeraria la compirono il giorno in cui osarono scendere fino a Stampino.
Qui i partigiani sbucarono dalla pineta più o meno all’altezza del salottino all’aperto dove Quaglia trascorreva le calde ore estive sotto le querce.
In quel momento sullo stradone stava transitando un drappello di San Marco che si vide improvvisamente bersagliato da un fitto fuoco che proveniva proprio da poco distante il proprio quartier generale.
Lo scambio di colpi fu breve ma intenso; dall’alto i partigiani mitragliavano col pezzo fisso e dal basso i marò replicavano coi moschetti.
Era sicuramente una scena di guerra come tante altre già accadute in precedenza, ma c’era un particolare che la rendeva surreale, quasi kafkiana. A circa duecento metri di distanza dai partigiani, più o meno a livello del piazzale esterno della villa, si erano radunati alcuni tedeschi la cui attenzione era stata inevitabilmente attirata dal rumore del crepitio delle armi da fuoco ed osservavano attentamente la scena, quasi come se stessero guardando un film, oppure una partita di tennis e ne fossero i giudici arbitri seduti in alto sul seggiolone.
Avrebbero certamente e sicuramente potuto intervenire a sostegno dei camerati italiani, ma non fecero una piega e tennero i propri machinepistole rigorosamente a tracolla come sempre, rimanendo perfettamente immobili come se la cosa non li avesse riguardati minimamente.
L’unica loro preoccupazione fu la presenza alcune fasce più sotto del piccolo Giacomino, che, essendosi malauguratamente trovato nel luogo sbagliato nel momento sbagliato, si era ritrovato involontariamente preso tra due fuochi mentre si trovava nei campi sottostanti, con le pallottole che gli volavano sopra la testa. Infatti i tedeschi gli facevano ampi e chiari segni di gettarsi a terra e non muoversi.
La breve scaramuccia per fortuna si concluse senza morti né feriti da ambedue le parti ed il piccolo Giacomino nella sua incoscienza giovanile quasi non si rese conto del pericolo che aveva corso.
Queste scaramucce tra partigiani e soldati della Repubblica Sociale non sortirono vittime di sorta in paese fino al giorno in cui due San Marco, di servizio su un carro trainato da un cavallo, subirono un’imboscata all’altezza del curvone della Ferraia rimanendovi uccisi.
A sentire i bene informati probabilmente il fattaccio c’entrava poco con la guerra di liberazione ed in realtà doveva trattarsi più di un regolamento di conti per una questione di donne che di un’azione di guerriglia, ma quand’anche ci fosse stata la certificazione scritta a riguardo, agli occhi del comandante nulla sarebbe cambiato. I due marò erano rimasti uccisi in un’imboscata e ciò rendeva necessaria una ferma e forte azione repressiva e punitiva. Pertanto, secondo l’usanza tipica del periodo, ordinò subito una violenta rappresaglia contro la borgata dove era accaduto il misfatto, che, nelle sue intenzioni, prima doveva essere bombardata coi mortai e poi data alle fiamme.
Le insane intenzioni del comandante fortunatamente non passarono inosservate alla vigile attenzione dei tedeschi lì accanto, i quali compresero al volo il massacro al quale sarebbe andata incontro la popolazione della borgata.
Intervenne immediatamente il Maresciallo Kaptein il quale si precipitò immediatamente alla Ferraia con alcuni dei suoi armi in pugno. Lì vide che i San Marco avevano già catturato alcuni abitanti della borgata ed altri ne stavano cercando. Avevano messo al muro anche donne e ragazzi senza distinzione pronti per una fucilazione sommaria. Alla vista di ciò la sua reazione fu altrettanto brutale, ma efficace. Con il mitra in pugno, spalleggiato dai suoi, alternando urla in tedesco che non necessitavano di traduzione ad ordini in italiano, li prese letteralmente a sberle ed a calci nel sedere sollevando quei ragazzi da terra finché non fu lui a mettere loro al muro. Dopodiché diffidò assolutamente l’ufficiale italiano dall’attuare una simile iniziativa che avrebbe ottenuto solo lo scopo di realizzare una gratuita vendetta e delle vittime innocenti.
Ma il comandante dei San Marco insisteva con vigoria nel proprio intento. Di conseguenza ne nacque una animata discussione tra i due che in breve sconfinò nel diverbio conclamato.
L’ufficiale italiano urlava la propria rabbia e frustrazione e per contro il maresciallo tedesco continuava a ripetere “Nein, nein!”
Furono minuti pieni di urla ed incertezza, ed i due facevano a gara a chi urlava più forte.
L’italiano urlava:
“Gli uomini sono i miei e se dico che sarà rappresaglia, rappresaglia sarà!!”
Il tedesco si opponeva urlando a propria volta ripetendo:
“Nein, nein! Io non volere!! Io andare da mio comandante!!”
Fortunatamente non ci fu bisogno che il Maresciallo Kaptein si avvalesse del contributo del proprio comandante poiché l’italiano, dopo aver visto la forza, la decisione e più in generale l’atteggiamento con le quali il sottufficiale tedesco si opponeva alla rappresaglia, seppur a malincuore, dovette desistere dal proprio intento.
Per fortuna, in questo caso bisogna convenire, in quel tragico momento storico contava più la parola e soprattutto la volontà di un sottufficiale tedesco che quella di un ufficiale italiano della Repubblica Sociale e pertanto la cosa non ebbe seguito e soprattutto conseguenze nefaste per l’innocente ed inerme popolazione civile della Ferraia.
Questo episodio non deve far credere che tutti e proprio tutti i tedeschi fossero così pacifisti come il Maresciallo Kaptein, anche tra di loro si annidava qualche nazista convinto, come un tenente che, al corrente della consuetudine da parte di molti partigiani di andare a ballare al “Dopolavoro” di Molino Nuovo, un giorno propose alla truppa di recarsi in blocco al locale per attuare un colpo di mano e catturare in un sol colpo tutti i ribelli presenti.
Questa volta ci pensò il Caporale Kappes a mandare a monte il blitz. Appena poté rintracciò il partigiano, ormai suo amico, Vincenzo Marchiano, detto “Ceno”, e gli rivelò le insane intenzioni del bellicoso tenente. Quando, al pomeriggio convenuto, i tedeschi si recarono al ballo, non trovarono nessuno dei giovani che avrebbero dovuto catturare. Ovviamente il tenente non la prese assolutamente bene e subodorò che qualcuno di loro avesse fatto una soffiata ed iniziò ad interrogarli per cercare di capire chi fosse la spia, ma Kappes lo stroncò anticipatamente, rimproverandogli di aver parlato troppo forte in presenza altrui in quanto c’era gente che capiva il tedesco e quindi per trovare il colpevole doveva solamente guardarsi allo specchio……
Ancora più singolare e portata agli estremi doveva rivelarsi poco dopo la vicenda del partigiano Giovanni Moreno.
Moreno era un ragazzo della Ferraia che a soli sedici anni si era arruolato nei Carabinieri. All’indomani dell’8 Settembre, all’età di diciotto, si era ritrovato nella condizione di dover scegliere se essere deportato in Germania per essere riaddestrato in qualità di futuro soldato della neonata Repubblica Sociale, oppure disertare. Scelse la seconda opzione e decise di salire in montagna arruolandosi tra i partigiani. A dicembre del ’44, mentre si spostava sopra Conna, finì su un sentiero minato e saltò in aria a causa di uno di quegli infidi ordigni sotterrati. Non era la prima volta che accadeva un fatto simile, in precedenza c’erano già state due vittime: un bambino ed una donna anziana erano deceduti saltando in aria a causa delle mine antiuomo che i San Marco avevano posizionato sui sentieri collinari onde contrastare le discese dalla montagna dei partigiani. L’esplosione per fortuna non uccise Moreno, ma egli rimase praticamente senza abiti, con un piede quasi spappolato, un polmone perforato e privo di coscienza. Un pastore lì vicino gli diede i primi soccorsi come potè, indi chiamò altri in aiuto, gli costruirono una barella di fortuna e lo trasportarono a valle fino alla sua abitazione della Ferraia dove i suoi genitori lo nascosero in soffitta. Comunque la prognosi rimaneva riservata ed il ragazzo, non essendo disponibili analgesici adeguati, soffriva intensamente.
Il Maresciallo Kaptein, durante i suoi soliti giri di ricognizione quotidiani tra Stampino e Molino Nuovo, si fermava frequentemente alla Ferraia presso la casa Moreno situata sullo stradone. Spesso il padre di Giovanni, quando lo vedeva transitare, gli offriva un bicchiere di vino e scambiavano qualche parola. Un giorno, mentre si rinnovava la tradizione, il maresciallo udì dei lamenti provenire dal piano superiore e chiese chi stesse male. Il padre rispose che era suo figlio che, durante i lavori nei campi, si era dato una zappata su un piede, ma Kaptein, che era al corrente che suo figlio militava tra i partigiani, non abboccò e chiese di poterlo vedere. Una volta di fronte a lui, si rese immediatamente conto della gravità della situazione e che il ragazzo necessitava di cure appropriate e soprattutto che non poteva rimanere là perché troppo pericoloso. Oltretutto prima o poi il fatto sarebbe stato di dominio pubblico e ci sarebbe stata sicuramente una soffiata ai fascisti oppure alle SS, che erano alloggiate alla Marina in alcune case private della Pigna.
Anche in questo frangente il Maresciallo Kaptein, prevedendo lucidamente la situazione che poteva svilupparsi, ebbe subito le idee chiare sul da farsi, quindi, onde evitare eventuali altre situazioni pericolose, decise di portare il partigiano Moreno proprio a Stampino nella casa dove era alloggiato Giovanni, in altre parole, all’interno della proprietà di Quaglia, il quale da parte sua lo fece curare ed accudire degnamente fino al termine del conflitto e dove il ragazzo rimase praticamente per tutto il tempo restante sotto l’ombrello protettivo di Quaglia, l’accudimento della famiglia Volpara e la complicità dei tedeschi stessi.
Purtroppo tanta generosità ed umana solidarietà da parte di quello che era universalmente considerato il nostro nemico non vennero da tutti riconosciute.
Infatti ad aprile, a una manciata di giorni dal termine del conflitto e proprio pochissimi giorni dopo il terribile ed efferato, ma peraltro quanto mai monitorio eccidio perpetrato sui civili di Testico da parte delle truppe tedesche di stanza ad Albenga, un tedesco dei territoriali andoresi, che si trovava in servizio di pattugliamento notturno sull’Aurelia, rimase ucciso a causa di una insensata ed inutile imboscata dell’ultimo minuto.
La sciagurata prodezza di quel partigiano irresponsabile gettò nella immediata costernazione tutta la comunità andorese che a quel punto, a guerra praticamente terminata, temette realmente un’altra terribile rappresaglia come quella avvenuta pochi giorni prima a Testico, anche se perpetrata da parte delle “SS” di stanza ad Albenga. Infatti tutti gli uomini validi scapparono immediatamente dalle proprie abitazioni per nascondersi. Chi si diede alla macchia sulle alture, chi nelle campagne, chi preferì nascondersi più comodamente nei sottotetti o nelle cantine. Alcuni si nascosero perfino negli anfratti della costa sulle scogliere. Addirittura ci fu più di uno che si fece trasportare in barca dal pescatore “Beppollu”, perfino nella “Grotta dei Colombi”, irraggiungibile via terra, ma solo per mare, e lì ci stettero per un paio di giorni, finché il buon “Beppollu” non tornò a recuperarli. Comunque, onde scongiurare un’altrettanta sanguinosa rappresaglia l’amministrazione comunale inviò prontamente una delegazione a Villa Stefania con lo scopo di esprimere non solo condanna e riprovazione per il vile attentato, ma anche per esprimere solidarietà ai camerati del caduto, i quali, prima che soldati, si erano obiettivamente dimostrati uomini leali e rispettosi nei confronti della comunità locale.
Anche in questo difficile frangente il buon Guido Gagliolo si dimostrò all’altezza della situazione e seppe far valere le proprie doti umane e di conoscitore della lingua germanica.
Quando la delegazione, capeggiata dal podestà Vatterone, fu al cospetto degli ufficiali tedeschi, notò che su un tavolo avevano srotolato delle carte geografiche e quindi pensarono con preoccupazione che stessero pianificando qualche rastrellamento.
Essi con brusco tono di rimprovero fecero loro vedere il corpo del caduto che giaceva in una stanza ricoperto da un telo e, dopo averlo scoperto, fecero notare la raffica che lo aveva colpito alla schiena. Si trattava del maresciallo Leib, che era il quarto di quattro fratelli tutti soldati, i primi tre dei quali già tutti morti in Russia: la guerra era quasi terminata e la loro madre confidava di riabbracciare almeno lui….. Quindi li accommiatarono altrettanto bruscamente e con poche parole come li avevano accolti.
La delegazione se ne tornò indietro turbata e preoccupata soprattutto dalla vista delle carte geografiche aperte sul tavolo, che potevano far presagire a ragione una azione studiata sul territorio, ma i fatti successivi avrebbero dimostrato che i tedeschi, anche se delusi ed addolorati per quanto accaduto, non avevano alcuna intenzione di vendicarsi ed anche in occasione di questa ultima dolorosa situazione rimasero coerenti e responsabili come avevano dimostrato di essere fino a quel momento.
Evidentemente era ormai chiaro che la guerra, oltre che persa, era anche terminata e le carte geografiche probabilmente servivano loro solamente per studiare un percorso di rientro in Germania.
A marzo del 1945 quei pochi San Marco che erano ancora presenti a Stampino si erano squagliati insieme ai loro comandanti come la neve di maggio.
Ad aprile anche il piccolo presidio tedesco presente a Stampino si accomiatò dai residenti, ma, mentre la partenza dei fascisti fu vissuta con enorme sollievo e reale senso di liberazione, quella dei tedeschi fu commovente tanta era stata l’empatia reciproca vissuta alla villa durante quei mesi.
Se gli italiani pregustavano ormai il sapore della libertà riacquistata dopo anni ed anni di sofferenze e con esso un futuro radioso di pace e prosperità, i tedeschi da parte propria ed in particolar modo quei tedeschi presenti a Stampino, erano consci di andare incontro ad un destino incerto di sconfitti all’interno di una patria a pezzi distrutta dalle bombe e dalla storia. In un certo qual senso avevano quasi paura a rientrare in Germania.
Emblematico il sentimento e le parole del Caporale Kappes che piangendo ripeteva:
“Cosa io fare? Cosa io fare?”
Se ne andarono da Andora il 20 Aprile, ad Albenga presero la strada verso il Piemonte valicando il colle San Bernardo e scendendo a Garessio. Passarono per Ceva e Mondovì dirigendosi verso Torino, intorno a Milano furono attaccati per l’ultima volta dai partigiani ed infine furono fatti prigionieri dagli americani. Quindi furono internati in un campo di prigionia a Ghedi dove rimasero alcuni mesi. Il Maresciallo Heinrich Kaptein ed il Caporale Karl Kappes fecero ritorno a casa assieme ai loro camerati il 28 Luglio del 1945.
Dopo il ritorno in patria si perse notizia di quegli uomini per diversi anni, ma essi non avevano dimenticato affatto la loro esperienza italiana.
Già nel ’53 Kappes scrisse una lettera a Quaglia in cui lo informava che si era sposato e che era diventato padre. Il Commendatore gli aveva prontamente risposto con una missiva il cui contenuto diceva così:
“Genova 18 Settembre 1953
Caro Amico, mia moglie ed io siamo molto lieti della vostra lettera del 17 Agosto e di ricevere buone notizie.
Il nostro primo desiderio che esprimiamo per vostro figlio è che non debba mai vivere una guerra.
Sarà un grande piacere ricevere lei e sua moglie in un tempo futuro e pertanto la attendiamo a Stampino lei e la sua famiglia.”
Kappes non fece in tempo a rivedere Quaglia, poiché il Commendatore sarebbe scomparso solo due anni dopo quella missiva, ma non appena potè fece ritorno in Italia.
Fu nel ’59 che ritornò per la prima volta per fare il viaggio di nozze ad Alassio, anche se si era sposato nel ’51, poiché fino ad allora non aveva potuto permetterselo. Fu anche l’occasione per ritrovare Giorgio, “Ceno” ed altri per la prima volta dopo la guerra.
Anche Kaptein ritornò ad Andora in quel periodo e, dopo aver cercato e ritrovato Giovanni Moreno, poté riabbracciare tutti i suoi ex nemici, che nemici in realtà non erano mai stati.
L’ex Maresciallo Kaptein e l’ex Caporale Kappes tornarono più volte ad Andora più o meno fino a metà degli anni ottanta ed ogni volta che tornarono fecero grandi rimpatriate con Giorgio e gli ex partigiani Vincenzo “Ceno” Marchiano e Giovanni Moreno, invitandoli ripetutamente ad andare a trovarli a propria volta in Germania dove sarebbero stati ospiti graditissimi.
“Ceno”, che era più legato a Kappes, a fine anni settanta andò a trovare l’ex caporale a Zeltingen insieme alla figlia e fu suo ospite per alcuni giorni.
Ancora più intenso fu il rapporto che legò Giovanni Moreno ad Heinrich Kaptein, in quanto si scambiarono reciproche visite con tanto di famiglia al seguito più volte. Giovanni Moreno, in onore ed in segno di ringraziamento nei confronti dell’amico tedesco andò oltre battezzando il figlio maschio Enrico e per giunta volle che Heinrich stesso ne fosse padrino di battesimo.
Di questi incontri, avvenuti anche a casa mia, conservo ancora viva memoria io stesso a dimostrazione del fatto che le vicende storiche talvolta possono forzatamente portare gli uomini su fronti opposti, ma prima ancora dei rapporti ufficiali esistono pur sempre la volontà ed il senso di responsabilità delle singole persone. Andora sotto questo aspetto fu molto fortunata poiché durante quel periodo storico di guerra civile così travagliato e contraddistinto da violenze e lutti, in cui molti, su entrambi i fronti, si lasciarono andare a crimini efferati mascherandoli da azioni di guerra, potè godere dell’alto senso di responsabilità, umanità e perché no, anche di pacifismo ante litteram di un gruppo di tedeschi provenienti da Coblenza e dintorni, che interiormente ripudiava il nazismo e la guerra, arricchito anche dal fatto che si trattava per la maggior parte di padri di famiglia che ben comprendevano quali fossero i valori importanti della vita e pertanto anelavano solamente a ritornare indenni presso i propri cari.
A riprova di ciò è emblematico l’episodio che avvenne il giorno di Natale del ’44 quando uno di quei soldati di presidio a Stampino di nome Hans, complice forse qualche bicchiere di troppo, bevuto straordinariamente in coincidenza della festività natalizia, strappò dal muro il ritratto di Hitler che per regolamento dovevano tenere nelle proprie stanze e lo gettò a terra con furore sputandoci sopra, calpestandolo con gli scarponi e distruggendolo, mentre in mano teneva la foto dei propri due figli e piangeva.
Alternava frasi in cui urlava parole incomprensibili, ma che ci voleva altrettanto poco a comprendere che erano cariche di insulti nei confronti del Fuhrer, ad altre in cui parlava sommessamente osservando le foto dei figli. Si capiva che soffriva per la lontananza dalla famiglia. I suoi commilitoni ebbero da fare non poco per calmarlo e rabbonirlo e soprattutto evitare che la cosa potesse avere qualche testimone scomodo per tutti i presenti.

1972. Da sinistra Giorgio Volpara, l'ex maresciallo della Wermacht Heinrich Kaptein, gli ex partigiani Vincenzo "Ceno" Marchiano e Giovanni Moreno.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
Un’ultima annotazione per spiegare l’insolita non belligeranza tra partigiani e tedeschi: col tempo si venne a sapere che, su iniziativa proprio dei tedeschi, era stato siglato un patto segreto di non aggressione tra le due parti e detto patto era stato concordato proprio in casa del podestà Vatterone a Rollo tra il comandante Geiersback ed il comandante partigiano Nino Agnese. Certamente il comandante aveva contratto il patto segreto da solo ed in assenza di testimoni della propria parte, onde evitare eventuali denunce ai vertici, ma altrettanto certamente i suoi sottoposti di lì a poco avrebbero dimostrato coi fatti e soprattutto spontaneamente che erano assolutamente allineati con lui nel perseguire la politica del dialogo e della pacifica convivenza con la popolazione locale e di questo tutta Andora gliene deve rendere merito, poiché in questo caso furono i tedeschi a salvare gli italiani dagli italiani stessi.
GLI AMERICANI
I partigiani discesero in paese dalle colline la notte tra il 24 e il 25 aprile preceduti da un fitto fuoco di mitraglia diretto verso il mare, forse più atto ad avvertire la popolazione che stavano arrivando che per colpire qualche potenziale nemico. Infatti praticamente nemici non ce n’erano più; i tedeschi si erano già ritirati da qualche giorno e gli ultimi San Marco li avevano seguiti a ruota poco dopo.
Ancora una volta l’Albergo Milano cambiò inquilini nel volgere di pochi mesi e stavolta diventò la base del comando partigiano, che proprio davanti all’albergo stesso installò un posto di blocco per controllare chi transitava sulla via Aurelia. La vita andorese per fortuna non fu scossa più di tanto dai nuovi padroni della situazione. Mentre in tante altre parti d’Italia la resa dei conti da parte dei vincitori nei confronti dei vinti fu terribile, come nella vicinissima Alassio, per fare un esempio, dove le fucilazioni di uomini e donne compromessi con il fascismo furono decine, per fortuna ad Andora non si verificarono particolari fatti di sangue, né vendette in serie, tranne una postuma. L’unico fatto degno di nota, accaduto subito dopo il 25 aprile, fu che anche qui come altrove si dovette assistere al penoso ed umiliante spettacolo di alcune donne portate in piazza della stazione, fatte sedere su delle sedie e quindi sottoposte alla rapatura a zero poiché accusate di avere intrattenuto rapporti con l’occupante tedesco oppure perché sostenitrici del fascismo, ma, come già detto, i vincitori si limitarono a questo e non si lasciarono andare agli eccessi che si verificarono in molte altre parti del nord Italia. L’unica vera vendetta sommaria si verificò circa un mese dopo alla fine di maggio quando ad Alassio fu catturato un brigatista nero nativo della val Merula che durante il conflitto aveva terrorizzato non poco gli abitanti locali con il proprio attivismo. Sebbene già ferito alle gambe da una raffica durante le operazioni di cattura avvenuta nelle campagne di Moglio, fu condotto ad Andora per mostrarlo alla popolazione, come era in uso un po’ ovunque in quei giorni di tragica e crudele resa dei conti. Portato nell’allora caserma dei carabinieri, che si trovava a metà dell’attuale via Carminati, non essendo ormai più in grado di camminare, fu portato di peso su una balconata al primo piano per essere mostrato meglio come un trofeo alla popolazione che gli inveiva contro e lo voleva linciare. Il triste e crudele spettacolo del condannato a morte senza nemmeno la recita di un qualsiasi processo si concluse pochi minuti dopo quando il poveretto fu riportato dentro. Ormai agonizzante fu trascinato nel bagno della caserma e, fattolo sedere sul gabinetto, gli scaricarono addosso l’ultimo caricatore.
Con questa esecuzione sommaria si può affermare che anche ad Andora calò il sipario sull’ultima delle tante fratricidi guerre civili che gli italiani hanno combattuto nella loro storia plurimillenaria.
Episodio suddetto a parte, a conti fatti si può affermare che il conflitto entro i confini comunali andoresi per fortuna non trascese mai più di tanto e le vittime dei rari scontri tra partigiani e fascisti si contarono sulle dita di una mano. Di ciò si deve rendere merito, oltre ai già menzionati tedeschi, soprattutto a tre uomini: l’Avv. Commendator Giovanni Quaglia, il podestà “Pippo” Vatterone e Guido Gagliolo.
Quaglia per tutta la durata della guerra civile continuò a foraggiare e non poco sia con soldi che con generi di conforto le forze resistenti affinchè desistessero da azioni proditorie e violente, intendansi attentati ed imboscate varie, che potessero scatenare la reazione dei nazifascisti contro l’inerme popolazione civile e bisogna dire che, almeno per quanto riguarda il territorio municipale andorese, ci riuscì o quasi.
Alla stessa maniera Vatterone, anche se era il podestà e pertanto un esponente di primo piano del regime fascista, seppe tenere una posizione equidistante tra le parti contendenti cercando inoltre, quando possibile, di aiutare in qualche modo i partigiani senza farsene accorgere dalle autorità militari repubblicane. Inoltre, come già visto, fu il grande regista del patto di non aggressione tra tedeschi e partigiani. Infatti, a conflitto terminato, non ebbe nulla da temere per la propria incolumità. Giuseppe “Pippo” Vatterone un grande podestà-sindaco che ha avuto il dono di privilegiare sempre il bene della collettività considerando tutti gli andoresi cittadini di pari grado e meritevoli di attenzione, anche quelli che non la pensavano come lui.
Infine Guido Gagliolo, il quale essendo l’unico andorese in grado di comunicare con le truppe teutoniche nella loro lingua, fece anch’egli costante opera di diplomazia presso gli occupanti cercando di attutire le inevitabili incomprensioni che quotidianamente e di volta in volta potevano crearsi tra locali e tedeschi.
Grazie all’opera fattiva di queste tre persone sia la fase bellica che quella immediatamente successiva furono praticamente indolori o quasi.
Le truppe alleate arrivarono che ormai i giochi erano fatti e non dovettero fare altro che constatare lo status quo.
E l’aspetto dei liberatori si palesò sotto forma delle divise americane della V Armata.
Siccome la persona del Commendatore era ben nota a livello internazionale e l’eco delle sue gesta aveva oltrepassato l’Atlantico, costoro, appena poterono, si precipitarono a Stampino onde poter prendere contatto con cotanto personaggio.
Sicuramente Quaglia durante tutto il periodo bellico era riuscito in qualche modo a tenere vivi i rapporti con il mondo britannico attraverso canali personali che solo lui conosceva e quelle particolari attenzioni ne erano la testimonianza fattiva.
Sintomatico e molto sospetto fu il fatto che, nonostante gli aerei alleati avessero bombardato a più riprese ed in più punti la ferrovia, oppure le postazioni antiaeree poste sulle colline ed i loro piloti non si fossero fatti scrupolo alcuno di mitragliare tutto ciò che si muoveva, militari o civili che fossero, e più di un civile se la vide veramente brutta per essere stato puntato e poi mitragliato da un caccia dei “liberatori”, però non osarono mai mitragliare e tantomeno bombardare l’accampamento dei San Marco che si trovava a poche centinaia di metri dalla villa. Questo fatto potrebbe far pensare che le forze alleate sapessero molto bene chi abitava in “quella villa” posta accanto al loro accampamento e che proprio per questa ragione si astenessero dall’intentare azioni che potessero mettere in pericolo qualcuno loro amico.
D’altronde il giorno in cui l’aereo americano passò così basso rasente sopra la villa, agli occhi di Giovanni parve quasi che il pilota fosse più intento a curiosare che ad osservare eventuali obiettivi militari.
Quando gli americani arrivarono a Stampino sembrò che fossero attesi quasi come gente di casa ed anche ciò risultò sospetto.
Così per un certo periodo un loro presidio si installò nella foresteria con l’intento sia di conoscerlo meglio che di proteggerlo da qualche vendetta o da qualche sconsiderato dell’ultima ora, ma il Commendatore aveva già ampiamente dimostrato di sapersi difendere da sé e di essere abilissimo nel sapersi districare attraverso i turbini della storia e quindi di non aver certo bisogno di protettori dell’ultimo minuto.
Con l’arrivo degli americani anche gli andoresi per la prima volta conobbero quelle strane auto militari chiamate jeep e si resero conto di persona come fossero fatti i neri che fino ad allora avevano visto solamente sui libri oppure al cinema tramite i film o i cinegiornali. Ancora più strano fu constatare che anche loro vestivano una divisa e combattevano proprio come i bianchi.
Grande fu lo stupore di Rina il giorno in cui un ragazzone enorme di nome Bob le si avvicinò e, mostrandole una foto sulla quale era ritratta una bambina, le fece capire che anche lui a casa aveva una figlia piccola come lei che lo aspettava una volta terminato il servizio militare.
Quindi Bob frugò nelle proprie tasche e ne trasse un pacchettino che la invitò ad aprire. Rina obbedì e ne trasse fuori una barretta colorata, ma non riusciva a comprendere cosa fosse quell’insolito oggetto che stringeva in mano.
Allora Bob ne trasse di tasca una per sé e le fece vedere che cosa si poteva fare con quella strana barretta:si poteva mettere in bocca e si poteva anche masticare.
A questo punto Rina ruppe gli indugi e provò a propria volta: era dolce e gommosa, aveva scoperto il chewing-gum.
Quella non fu l’unica volta, in seguito ne arrivarono altre, ma l’omaggio più gradito fu rappresentato da quello della cioccolata, una cosa di cui si era ormai perso totalmente non solo il sapore, ma anche il ricordo.
L’ultima volta che Bob salì a Stampino prima di tornarsene in America portò a Rina addirittura una borsetta a tracolla di pelle, ovviamente tutta farcita all’interno dell’ultima razione di cioccolata e chewing-gum.
Mamma Giuseppina provvide saggiamente a sequestrare l’abbondante farcitura ed a razionarla, affinchè la figlia non facesse indigestione e, avendola conosciuta bene anch’io dato che era mia nonna, perchè no, anche per approfittarne un poco personalmente……dopo tanti anni di astinenza era più che lecito!!!
RITORNO ALLA NORMALITA'
Esauritesi le vicende belliche e, dopo circa un mese di permanenza, ripartiti infine anche gli americani, poco a poco tutto ritornò nell’alveo della normalità o quasi.







Fu un lento ma progressivo ritorno alla quotidiana normalità per tutti.
Per Giorgio, che ritornò a fare l’odontotecnico nello studio del Dott. Amoretti ad Oneglia, anche se, a causa del sabotaggio delle linee ferroviarie da parte delle truppe tedesche che durante il ritiro avevano tranciato con la dinamite tutti i pali dell’elettricità, ogni giorno era obbligato ad andare a lavorare ad Oneglia in bicicletta e come lui tanti altri costretti a muoversi con mezzi di fortuna.
In quel momento storico anche una bici poteva essere già considerata una comodità.
Però vent’anni erano vent’anni ed al mattino, andando verso Oneglia lui ed altri giovani si sfidavano nella scalata del Berta in bicicletta emulando i grandi ciclisti che correvano la Milano-Sanremo; ed alla sera, rientrando a casa, era ancora in grado di arrampicarsi con la bici fino al piazzale terminale di Stampino alzandosi sui pedali per scalare l’ultima ripidissima erta.
Una volta il Commendatore vide Giorgio arrivare sbuffando ed imprecando per via del mezzo non proprio in ottimo stato e lo consolò con queste parole: “U se vegghe che ti sei zuènu, anche mi a-a toa etàe a ghe daxèvu in bicicletta”.....
Fu un lento ritorno alla normalità anche per Bruno che, dopo aver esaurito le proprie vicende belliche, era ritornato a lavorare a Stampino.
Anche Felice, il figlio di “Tugnìn” Verda, dopo qualche mese dalla fine delle ostilità, potè finalmente fare ritorno a casa dalla prigionia che aveva trascorso in Africa ad opera degli inglesi e come lui tanti altri giovani di quella sfortunata generazione.
Il più triste, che non potè gioire fino in fondo della liberazione, risultò sicuramente Carlìn, al quale i tedeschi ad Albenga avevano requisito il cavallo, costringendolo a rimanere appiedato.
Al contrario, i più contenti erano Giovanni, che, finalmente sgravato dalle responsabilità di cui sopra, aveva potuto finalmente far rientro in casa assieme a tutta la famiglia ed “u Sciù Giuvanni”, che aveva potuto alfine celebrare la liberazione da tutti quegli occupanti in divisa, nemici od amici che definirsi potessero.
Lontano da occhi indiscreti, poco per volta, si dissotterrarono e si recuperarono tutti gli averi ed i viveri che non erano stati consumati. Giovanni riprese zappa, piccone e badile e si ridiede da fare alla rovescia in quella che si dimostrava una caccia al tesoro nel vero senso della parola.
Tornarono così alla luce banconote, titoli, gioielli, lingotti d’oro e quant’altro ancora.
E così accadde che al termine di quell’opera di recupero, mentre si stava facendo l’inventario dei beni alla presenza del Commendatore, ad un certo punto Giovanni, portandosi le mani nelle tasche dei pantaloni da lavoro sporchi di terra, si accorgesse di avere ancora delle monete, al chè le estraesse, anch’esse sporche di terra, e, porgendole al legittimo padrone, dicesse:
“Sciù Giuvanni, a mumenti a me scurdovu che i ghèan ancùa ‘ste tre sterline d’ou”
“U Sciù Giuvanni” non replicò subito, ma si fermò un momento a guardarlo in silenzio con la testa di traverso e dopo una lunga pausa, con un tono a metà tra il paternalesco ed il commosso gli ribattè bonariamente:
“E ti sei propriu abelinàu!” come a dire che oramai a quel punto poteva anche tenersele, tanto per lui tre sterline in più o in meno cosa sarebbe cambiato?!?
Con quell”abelinau”, che in quella circostanza perdeva e trasformava radicalmente il proprio significato originale, voleva racchiudere con una sola parola tutto il proprio sentimento fatto di benevolenza ed affetto nei confronti di una persona che aveva rischiato molto per lui e che invece di chiedere qualcosa per i rischi corsi, al contrario, altrettanto fedelmente ed ingenuamente, voleva restituire qualcosa per la protezione ricevuta. Insomma in quella parola c’era racchiuso tutto un universo di sentimenti.
Quelle tre sterline per Giovanni avrebbero costituito sicuramente un piccolo tesoro e gli sarebbero certamente tornate molto comode, ma l’ultima cosa che avrebbe potuto pensare di operare sarebbe stata la benché minima mancanza di fedeltà od approfittazione nei confronti del suo principale, che tanto si era prodigato per la sua famiglia.
Terminate le operazioni di dissotterramento e recupero, ancora pochi giorni per riordinare idee e cose e poi il “u Sciù Giuvanni” riprese la strada per Genova dove avrebbe avuto veramente molto da fare.
C’era infatti da ricostruire la flotta che il conflitto gli aveva colato a picco per intero nei modi e nei tempi più diversi, ma nonostante ciò, entro pochissimo tempo l’avrebbe di nuovo apprestata come e meglio di prima.
Di conseguenza le sue apparizioni a Stampino ritornarono ad essere saltuarie e soprattutto estive.
Dopo la guerra, oltre alla necessità di ricostruire, c’era pure una gran voglia di divertimento da parte di tutti anche se i divertimenti, obiettivamente parlando, erano veramente pochini, ma la fantasia non mancava e le menti erano sempre attive.
Durante il conflitto c’era stato un gran traffico di armi che aveva coinvolto non solo i partigiani, ma un po’ tutta la popolazione compresi coloro che non si erano schierati apertamente con alcuna delle parti. Ora che il conflitto era giunto a termine bisognava consegnare tassativamente le armi con relative munizioni alle autorità preposte. Invece molti si erano ben guardati dal fare ciò. I più politicizzati non le riconsegnavano sperando che un giorno non troppo lontano potessero nuovamente tornare utili in caso di rivoluzione di popolo, invece i più goliardi se le tenevano solamente per continuare ancora un po’ a giocare alla guerra.
Così spesso e volentieri i giovanotti del circondario si divertivano ad andare sul greto del Merula a lanciare bombe a mano tra i cespugli di oleandro verso ipotetici nemici, oppure a sparare al tiro a segno a righe di bottiglie vuote con qualche moschetto.
Non si sparava solamente alle bottiglie o in mancanza di queste ai semplici sassi, ma si poteva sparare a qualsiasi altra cosa, tanto per cambiare un po’ bersaglio, ad esempio, veniva bene anche un isolatore elettrico. Ed è ciò che fecero un tardo pomeriggio Giorgio ed un paio di suoi amici scapestrati al par suo.
Avendo a disposizione un fucile ed una certa dotazione di pallottole, stufi delle solite bottiglie, decisero di tirare ad un isolatore di ceramica, che non portava alcun filo, che però si trovava su un palo della linea elettrica attiva, in quanto un po’ più in alto rispetto all’isolatore un filo della luce lo portava eccome.
Iniziarono così quell’ anomalo tiro a segno; un tiro a testa a turno in quell’insolito duello con l’isolatore finché uno di loro non fece centro mandandolo in mille frantumi come un piattello. Sfortuna volle che, non si sa se a causa della pallottola deviata oppure a causa delle schegge di ceramica, il filo della luce che stava poco sopra andasse reciso di netto.
I tre maldestri ammutolirono sgomenti, si guardarono istintivamente attorno per verificare che qualcuno non li avesse inopinatamente visti nell’atto dell’infelice azione e se la dettero a gambe senza dire nulla a nessuno, guardandosi bene dal segnalare l’insolito guasto.
La conseguenza fu che si interruppe l’erogazione dell’energia elettrica a tutta la parte a monte della valle, lasciando al buio Molino Nuovo per una sera ed una notte, finché il “guasto” non fu rilevato e riparato il giorno successivo.
Confessarono la bravata solo molti anni dopo.
Un’ altra attività tipica dei giovani di quei tempi consisteva nell’alleviare i possidenti terrieri dal peso della raccolta della frutta, con un occhio di riguardo nei confronti di certa frutta che risultava più ricercata. Ciò è quello che facevano spesso e volentieri alcuni ragazzotti della borgata dei Canossi, che avevano preso di mira l’agrumeto di Stampino, che era rifornitissimo di aranci, limoni, mandarini, pompelmi.
Costoro erano quasi tutti figli di alcune famiglie di profughi della Prima Guerra Mondiale, che non erano più tornate nelle terre d’origine.
Giovanni, che considerava l’agrumeto un’estensione del salotto di casa propria, considerate le cure e la dedizione che vi profondeva, quando, alla mattina successiva delle loro imprese notturne, riscontrava gli ammanchi sugli alberi, andava su tutte le furie e non la smetteva più di inveire a pieni polmoni contro quei ragazzotti che egli era solito chiamare spregiativamente “Profughi”, ragazzi che secondo lui non avevano alcun rispetto per la proprietà ed il lavoro altrui.
“Sti belìn de profughi…” era il suo intercalare abituale in queste circostanze.
Tentò più volte di attenderli al varco, ma quelli erano scaltri e non si facevano sorprendere. Tutto sembrava procedere costantemente secondo un copione fisso e senza particolari colpi di scena, senonché una sera i “Profughi” commisero l’errore di muoversi troppo presto, prima del calar delle tenebre.
Bruno, che era sempre vigile ed attento ad ogni novità, li vide da lontano, mentre scendevano dai Canossi a mo’ di squadra all’imbrunire.
Corse subito ad avvisare Giovanni, il quale, dopo aver lanciato la doverosa ennesima contumelia nei loro confronti, decise che era venuta l’ora di dare una bella lezione a quegli sfrontati.
Pertanto, dopo un breve conciliabolo, decisero sul da farsi.
Entrambi corsero in casa e si affrettarono a radunare e (ovviamente) a caricare (sennò a che sarebbero serviti?) tutti i fucili che c’erano in dotazione alla villa. Quindi andarono sulla terrazza lato nord al primo piano e li disposero sul muretto del parapetto attendendo i “Profughi”, un po’ come quando i “Nostri” attendono i nemici al varco nella scena finale dei film d’azione.
Attesero in silenzio che arrivassero e, quando furono ben certi che si trovassero nell’agrumeto, aprirono il fuoco in contemporanea scaricando una gragnuola di colpi poco sopra le loro teste condendola con urla e maledizioni varie.
Terminata la sparatoria, scesero in basso per verificare la situazione e con grande stupore, ma ancor maggiore soddisfazione, riscontrarono che non solo se l’erano data a gambe, ma sul luogo del misfatto avevano lasciato tanto le ceste, che le cesoie.
Non tornarono mai più.
In seguito, quando i ragazzi furono cresciuti e diventati uomini ed anche gli animi si furono stemperati, allorquando Giovanni ne incontrava qualcuno, non lesinava loro di ricordare quella volta che se l’erano fatta nei pantaloni.
I “Profughi” allora sorridevano e sottolineavano che, per via dei colpi precedenti andati a buon segno, il bilancio era nettamente a loro favore. Così fu e così sarebbe stato ogni qual volta si fossero reincontrati.
Entrambi avrebbero continuato a pizzicarsi ed a sfottersi a vicenda, ma pur sempre in maniera amichevole e col sorriso sulle labbra sostenendo costantemente il gioco delle parti come dei tifosi di calcio al bar sport.
In fondo in fondo era stato come se avessero giocato a guardie e ladri e tutti ne erano consci.
Comunque fosse, in quell’Italia appena uscita dalla guerra, i giovani erano sempre in penosa ricerca di lavoro ed anche quando ne trovavano uno i soldi a disposizione rimanevano pur sempre pochi.
In conseguenza di ciò anche i divertimenti erano proporzionati alle scarse risorse economiche della gioventù locale, ragion per cui quelli un pochino più dotati sotto quest’aspetto (veramente pochi), quando potevano se ne andavano fuori a divertirsi. D’inverno soprattutto ad Imperia per via dei cinematografi, oppure d’estate ad Alassio, per vedere un po’ di movimento e frequentare qualche locale da ballo.
Coloro che rimanevano ad Andora se ne stavano al bar, ma non dentro al bar, molto più frequentemente fuori di esso, poiché prima di tutto c’era ben poco da spendere eppoi perché fuori si poteva guardare il passaggio dei rari mezzi a motore che tanto fascino suscitavano.
I camion per l’appunto potevano rivelarsi particolarmente interessanti.
I ragazzi se ne stavano seduti sulla spalletta del muretto davanti al bar del passaggio a livello della Marina anche per ore, finchè non arrivava una vittima predestinata.
A quei tempi non era ancora stato terminato il cavalcavia dell’Aurelia, la cui costruzione, iniziata nel 1940, era stata interrotta a causa della guerra. Detto cavalcavia sarebbe stato completato solo nel 1953 e fino a quella data tutti i mezzi, a motore e non, compresi i ciclisti che correvano la Milano- Sanremo, dovevano passare di sotto nell’attuale Via Fontana, correndo il rischio di doversi fermare al passaggio a livello quando era chiuso. Infatti più di una volta si verificò che i ciclisti durante la corsa trovassero le sbarre abbassate ed allora, treno permettendo, dovevano scendere dalla bici e passare sotto le sbarre trascinandosi seco la bicicletta.
Infatti quando i ciclisti, dopo essere scesi dal Turchino, arrivavano in riviera si trovavano di fronte un vero e proprio campo minato costituito da ben quindici passaggi a livello della ferrovia: chi era in fuga sperava ardentemente di trovarseli aperti, ma chi inseguiva si trovava nella situazione d’animo diametralmente opposta in quanto confidava nell’insperato appoggio di qualche treno collaborazionista. I capistazione, da parte propria, avvertiti da rapide staffette in bicicletta o in moto dell’avvicinarsi dei ciclisti, quando potevano, cercavano di collaborare onde permettere un regolare svolgimento della corsa bloccando i treni in stazione, ma non sempre ciò era nelle loro possibilità, poiché a volte, paradossalmente, la corsa del treno e quello della gara procedevano per lunghi tratti di conserva, oppure il treno arrivava dalla direzione opposta a quella di gara. Ne derivava che, durante certe edizioni, più di una volta i corridori dovevano scendere e risalire dalla bici, intenti quasi più in una gara ad ostacoli che in una corsa in linea.
Nel 1946 Coppi, trovandosi in fuga da solo, transitando da Andora, si vide la strada sbarrata dal passaggio a livello chiuso, ma non si scompose più di tanto e, sceso velocemente dalla bici, dette rapidamente un’occhiata a destra e a sinistra, dopodiché, constatato che il treno era ancora distante, altrettanto velocemente attraversò i binari e riprese a pedalare su per la salita del capo. I suoi inseguitori, che arrivarono poco dopo, come se non bastasse già il fatto evidente di trovarsi di fronte un Fausto Coppi in giornata di grazia già in fuga solitaria sul Turchino, invece furono meno fortunati di lui, poiché il treno era proprio in procinto di transitare ed impedì loro altrettanta pericolosa manovra e di conseguenza dovettero attendere il passaggio del convoglio. In ogni caso il fatto non si rivelò decisivo più di tanto, poiché Coppi quell’anno avrebbe vinto con una gamba sola anche senza l’aiuto del treno, dato che arrivò a Sanremo con un vantaggio di un quarto d’ora sul secondo classificato, il francese Lucien Teisseire ed una ventina di minuti su un certo Gino Bartali!
Ma torniamo al discorso delle vittime predestinate.
Durante la stagione estiva non era così infrequente che passasse qualche camion carico di frutta inusuale per i nostri posti, quali meloni oppure angurie, che di solito arrivavano dall’Emilia Romagna.
Quei camion così poco potenti, se paragonati a quelli dei nostri giorni, e così sgangherati, richiedevano vere e proprie prove di coraggio per essere guidati: potevano impiegare un paio di giorni ed anche più per andare da Milano a Roma
Quando alla sera ne arrivava uno sembrava di assistere all’assalto della diligenza e non ne parliamo se il passaggio a livello era chiuso. Ma quand’anche fosse stato aperto, complice la bassa velocità impiegata nell’attraversamento dei binari, il fatto che subito dopo iniziava la salita che costringeva il conducente ad ingranare la marcia ridotta e complice, non ultimo, una Via Aurelia ancora priva di illuminazione, uno dei ragazzi saltava sul cassone e, senza che l’autista se ne accorgesse, cominciava a lanciare giù la frutta ai compagni che seguivano il camion di corsa nell’oscurità.
Il povero conducente correva così il rischio di arrivare al termine del viaggio con metà del carico svanito nel nulla se ad ogni paese attraversato doveva pagare questo tipo di dazio. In ogni caso per i ragazzi autori della bravata il problema dello scrupolo di coscienza non si poneva assolutamente. L’importante era che fosse assicurato un po’ di sano divertimento e come valore aggiunto ci si potesse riempire la pancia gratis con qualcosa di differente dal solito e, perché no, magari anche di esotico per quei tempi.
Sempre per rimanere in ambito di divertimenti, l’immediato dopoguerra ad Andora vede finalmente la nascita della prima squadra calcistica che partecipa ad un campionato ufficiale: si tratta della Valmerula che viene fondata nel 1946 e gioca sul campo di Molino Nuovo, a lato del Dopolavoro, proprio dove si trova il campo sportivo attuale, senonchè allora il campo, essendo di dimensioni più ridotte, era posto di traverso rispetto ad oggi, con una porta a levante vicino al greto del torrente non ancora arginato e l’altra poco distante dalla strada provinciale.
La squadra di calcio costituisce un valido motivo di interesse per gli affamati sportivi locali anche se la squadra è raccogliticcia, cioè composta principalmente con gli scarti delle squadre limitrofe e l’impianto sportivo è tutto meno che tale con un campo di gioco più simile ad una massicciata della ferrovia che ad un morbido prato erboso.
Il presidente e motore della società è il Sig. Andrea Morro, detto “Dedè”, che di mestiere fa il frantoiano, il quale, essendo le risorse societarie molto limitate, escogita un sistema molto originale per attuare il rimborso spese dei giocatori che provengono da fuori Andora. Praticamente li rimborsa o li paga con dei fiaschi d’olio. Chi arriva da Alassio o da Diano Marina viene rimborsato con un tot e chi da Imperia ha diritto a un di più.
Ciononostante l’entusiasmo non manca. Si segue e si accompagna la squadra anche in trasferta nei primi derby contro le compagini dei paesi vicini spostandosi tutti rigorosamente in treno oppure in bici.

A.S. Valmerula 1946-47. In piedi: Falconi, Pelissetti, Giulla, Moirano, Damele, Berlingeri, Ruffini, Ricciuto, Rodino (allenatore).
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro

A.S. Valmerula 1947-48. In piedi Revello, (...), Pelissetti, (...), Damele, Moirano, Selvatico, (...), Belmonte. In ginocchio: Giulla, Amarella, Berlingeri.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
Tutto bene per un paio d’anni con alternanza di vittorie (poche) e sconfitte (molte) che non intaccano minimamente l’entusiasmo degli sportivi calciofili andoresi, finchè il 28 maggio 1948 non arriva l’ultima storica rovinosa piena del Merula a seminare danni e scompiglio nella nostra valle.
Il Merula, non ancora dotato di argini, esonda provocando ingenti danni all’agricoltura e alla viabilità. Allaga anche i Lanfredi, Molino Nuovo e la bassa piana della valle con tutte le abitazioni che vi si trovano. La strada provinciale viene danneggiata in più punti; a San Giovanni l’acqua invade il Gumbasso e arriva a risalire i primi metri del viale che porta a Stampino; per pura buona sorte non ci sono vittime.
Ne sa qualcosa il contadino “Giuranen” di Piangrande che, dopo una notte di pioggia incessante e a dirotto, essendosi recato incautamente a verificare lo stato di conservazione del motore che pompa l’acqua dal pozzo, che si trova in prossimità dell’alveo abituale del Merula, viene colto di sorpresa dalla repentina piena del torrente. Non sapendo cos’altro fare, si aggrappa disperatamente al bordo della vasca di protezione del pozzo e, in questa posizione tragicomica, “naviga” per alcune centinaia di metri assieme alla vasca stessa trascinato dalla piena finchè entrambi non si arenano in un’ansa meno turbinosa.
Ne sa qualcosa anche Giuseppe Bilingui che, essendo anch’egli andato incautamente come il precedente a verificare lo stato del proprio pozzo presso il ponte romano, viene ghermito dalla piena e si aggrappa disperatamente ai tubi. Per fortuna viene avvistato ed in suo aiuto intervengono prontamente i “profughi” dei Canossi i quali dopo aver unito delle corde e facendo una catena umana, riescono a lanciargli una cima e a trascinarlo a riva in salvo.
Ne fa le spese anche il campo di calcio che viene letteralmente semicancellato; la metà campo verso est viene scavata come se fosse una succursale del greto del torrente ed al suo posto rimane una enorme cunetta piena di sassi e ciottoli, della porta nemmeno più l’ombra.
La piena del Merula, oltre ad aver cancellato il terreno di gioco ha cancellato pure la giovane società sportiva e bisognerà arrivare agli anni sessanta prima che un’altra società calcistica andorese partecipi ad un campionato regolare. Da questo momento e per un quindicennio la vita calcistica andorese sarà vissuta solamente sotto forma di sfide tra frazioni e borgate che si disputeranno sul campetto della colonia Brignole oppure al campo della “Bea” a San Bartolomeo vicino all’allora sferisterio senza muro di appoggio.
Questo avvenimento straordinario rinnova ancora una volta negli andoresi la rabbia e la disperazione nei confronti degli elementi avversi.
Il torrente Merula, anche se a distanza di molti anni dall’ultima volta, ha rinnovato la consapevolezza di quanta e quale forza distruttiva possa celare in sé.
Oltretutto non è più come al tempo della coltivazione dell’ulivo in cui tutto o quasi andava bene; nel ‘48 la valle viene ormai coltivata in maniera intensiva e tali colture devono essere protette adeguatamente, senza contare che il numero delle abitazioni presenti vicino all’alveo del torrente comincia ad aumentare sensibilmente.
Gli andoresi prendono coscienza che l’arginamento del Merula non è più indilazionabile per far sì che disastri simili non abbiano più a ripetersi e colui che porta avanti con forza questa istanza è proprio Quaglia che si fa promotore di un movimento di possidenti per sollecitare le istituzioni ad agire in questa direzione. Dapprima egli stesso in prima persona fa costruire autonomamente i primi muri di arginamento per proteggere i propri campi da ulteriori piene, muri dei quali rimane ancora oggi qualche traccia a San Giovanni. Ma soprattutto, avvalendosi delle proprie conoscenze altolocate, esercita pressione sulle istituzioni ad alto livello ed in poco tempo la via viene tracciata: infatti in capo a pochi anni il progetto di arginamento verrà redatto e finanziato.
Purtroppo per lui, Quaglia farà solo in tempo a vedere l’inizio dei lavori che partiranno appena prima della sua morte, lavori che saranno attuati e portati a compimento entro la fine degli anni cinquanta.
Se il Merula aveva cancellato con violenza la sana voglia di divertimento calcistico degli andoresi, e questo fatto distruttivo necessiterà di alcuni anni prima che venga sanato mediante rifacimento del campo e sua messa in sicurezza con l’arginamento del torrente, è altrettanto vero che gli andoresi non si piangono addosso e nel frattempo trovano nuovi modi di aggregazione e divertimento.
Sa quasi di reazione all’ingrato destino ciò che organizza un gruppo di intraprendenti ragazzi appena un mese dopo il tragico evento distruttivo. Infatti in quel di Ospedaletti il 27 giugno 1948 c’è in programma la terza edizione del “Gran Premio Città di Sanremo” di automobilismo, la seconda dopo il conflitto. Pur non essendo ancora una gara valida per il campionato del mondo, sono ugualmente in gara i migliori piloti in circolazione Fangio, Ascari, Villoresi.
Dato che le ferrovie non assicurano ancora un servizio affidabile ed adeguato, una ventina di baldi giovanotti, tra i quali Giorgio, con annesse ragazze fatte di pari pasta, decidono di recarsi a vedere la corsa ad Ospedaletti in bicicletta, ma beninteso, con le biciclette che erano a disposizione a quei tempi: cigolanti con cambio fisso, pesantissime con i freni a bacchetta e le camere d’aria più simili a carta vetrata, considerate le infinite rattoppature subite, che a dei lisci tubolari.
Partenza mattino presto e addirittura sosta a Bussana per poter andare a messa al santuario. Ovviamente pranzo al sacco lungo i tornanti del circuito in attesa della corsa automobilistica e spettacolo motoristico che sarebbe rimasto nella mente e nei cuori di quei giovani per anni ed anni considerata l’allora scarsezza di mezzi a motore. Al ritorno la povera Teresa “Gitta” Rossi allora diciottenne forò ben sette volte, tanto che alla fine, per non arrivare di notte, uno dei ragazzi se la prese in canna alla propria bicicletta ed un altro si prese in spalla la sua bici. Per la cronaca vinse Ascari su Maserati, ma anche quella squadra di intrepidi giovani andoresi vinse la propria scommessa.
Con l’inizio degli anni cinquanta, complice il sopraggiungere di una nuova positiva fase economica a livello nazionale, anche ad Andora comincia a cambiare qualcosa a livello produttivo ed infatti anche da noi l’attività turistica inizia a muovere i suoi primi timidi passi. I primi bagni marini vedono la luce nel 1949 con la creazione dei “Bagni Sirenella” fondati da Pierino Trevia, altri seguono il suo esempio negli anni successivi e via di seguito con la creazione di affittacamere, pensioni, campeggi, bar, alberghi. E’ sempre in questo periodo che avviene l’incubazione dei primi villaggi residenziali per turisti situati in collina, come la Pineta, che è la prima ad essere edificata a levante, oppure il Villaggio Aurora a ponente, la cui realizzazione, iniziata nella seconda metà degli anni cinquanta, trae vigore anche sotto l’impulso del ritorno ad Andora di tanti di quei soldati tedeschi che erano stati di presidio in loco durante il periodo bellico e che non si erano certamente dimenticati della bellezza del paesaggio ligure. Due di loro sono proprio l’ex maresciallo Kaptein assieme all’inseparabile ex caporale Kappes che possono così ritornare in pace e non più in divisa sui luoghi di un tempo neanche troppo lontano e riabbracciare i “nemici” forzatamente voluti dalla storia.
Questi ex militari costituiscono la testa di ponte del movimento turistico proveniente dalla Germania che si ingrosserà sempre più negli anni successivi fino a costituire la pacifica invasione che caratterizzerà tutti gli anni sessanta e settanta.
Questa nuova favorevole fase economica si riflette automaticamente a livello finanziario consentendo agli andoresi di spendere in nuove tipologie di beni. La conseguenza più immediata è la motorizzazione di massa, intesa soprattutto sotto il profilo motociclistico, che avviene nei primi anni cinquanta, la quale porta come conseguenza la creazione del locale Moto Club Andora, che sotto la presidenza di quel Giuseppe Bilingui salvato dalle acque, sarà molto attivo durante tutto il periodo di attività.
Il Moto Club, che annovera decine di iscritti, organizza gite nei dintorni, trasferte presso altri moto club, gare di velocità e gimcane, veglioni, perfino serate a tema con l’elezione di Miss Motoclub. Anche Giorgio non sfugge al fascino ed al richiamo degli scooter iscrivendosi al club e partecipando alle gare assieme alla fidanzata sua futura moglie.

1953. Maria Luisa Manno, futura moglie di Giorgio Volpara, prima donna motociclista andorese.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro

1953. Giorgio Volpara impegnato in una gara motociclistica.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
Ma la società si sta trasformando molto velocemente, anche quella andorese, e di conseguenza entro la fine degli anni cinquanta tanti passano inevitabilmente dalle due alle quattro ruote e così il destino del Moto Club Andora è segnato e si spegne prima che possa vedere l’alba del nuovo decennio.

Benedizione dei motocicli del motoclub sul sagrato della chiesa di San Giovanni nel 1953.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro

Stesso luogo, stessa benedizione due anni dopo: come si può notare il numero di ciclomotori è già notevolmente diminuito.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
Durante questo periodo la voglia di divertimento e di dimenticare i lutti e le distruzioni causati dalla recente guerra sono il filo conduttore della società intesa sia a livello generale che a livello più propriamente locale, ma se qualcuno ritiene che ad Andora negli anni cinquanta si pensasse solo ad andare in balera oppure a lanciarsi in folli corse in moto sbaglia di grosso, poiché è proprio nei primi anni di questo decennio che la nostra comunità vede la nascita e la costituzione di un’ associazione culturale che non avrà più pari né simili per spessore ed impegno fino a tutt’oggi.
Questa associazione viene battezzata “Circolo dei Sacchi”, vede la luce nel 1952 ed è fondata da sei giovani, sicuramente impegnati culturalmente, ma forse un po’ troppo avanti per la società andorese del tempo. Si tratta di sei ragazzi, alcuni studenti universitari, altri che già lavorano, accomunati da una sincera, rara ed unica passione per la cultura intesa nel senso più sincero, disinteressato e totale del termine. Sono soliti ritrovarsi in un salone che si trova in uno dei padiglioni dell’allora Colonia di Milano, oramai abbattuto, proprio dove oggi c’è il Parco delle Farfalle. Essi sono: Giorgio Benvenuto studente, Giovanni Musso bancario, Francesco Fossati studente, Pietro Trevia enotecnico, Giovanni Randone studente ed il Dott. Giovanni Barbero veterinario.

Cinque dei sei soci fondatori del "Circolo dei Sacchi". Da sinistra: Giovanni "Nini" Randone, Francesco Fossati, Giorgio Benvenuti, Giovanni Musso, Pietro Trevia.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
Hanno deciso di darsi questo nome così particolare perché le finestre del salone dove tengono gli incontri sono fasciate da sacchi di iuta che permettono l’oscuramento del locale quando si proiettano filmati. Sicuramente per la società andorese di quei tempi sono degli astratti visionari privi di senso pratico e con poche speranze perché si riuniscono per proiettare dei film e fare cineforum, leggere assieme libri e commentarli, studiare la storia e la cultura locali, organizzare eventi culturali mediante i quali coinvolgere la comunità.
Purtroppo, non trovando proseliti strada facendo come avevano sperato, dureranno pochi anni, ma non si sciolgono completamente, è come se andassero in letargo per un ventennio. Restano comunque la consapevolezza ed il rimpianto di una grande occasione persa per tutta la comunità andorese, che non ha saputo capire adeguatamente questo manipolo di incredibili precursori.
Molti anni dopo, a metà anni settanta, tenteranno con un ultimo colpo di coda di risvegliare le coscienze culturalmente addormentate dei concittadini organizzando nuovamente qualche serata a tema, ma, continuando a non trovare adeguato seguito sia da parte della cittadinanza che da parte delle istituzioni, anche l’ennesimo tentativo cade nel vuoto e…..da allora resta il vuoto.
OSPITI ECCELLENTI O CHE LO DIVENTERANNO

Wallis Simpson
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
Nel parentado du Sciù Giuvanni, oltre al già noto Sciù Carlìn, il cavalier servente della signora Tina, era annoverato un altro cugino da parte di madre, un po’ particolare, che proveniva da Albenga. Si trattava del cosiddetto Marchese Luigi, come era da tutti nominato.
Costui non era così assiduo come Carlino nelle sue frequentazioni a Stampino, però quando arrivava lasciava ugualmente il segno.
Amava più divertirsi che lavorare ed a riprova di ciò era il semplice fatto che era un gran frequentatore della Costa Azzurra, luogo dove notoriamente si radunava il bel mondo.
Quaglia non lo bistrattava come era solito fare con Carlìn, ma in ogni caso lo guardava con occhio scettico ed un minimo di distacco.
A riprova di ciò era il fatto che soleva dirgli:
“Ti n’hai ciù in ta testa che in ta stacca”!
Sì, insomma, per il cugino castellotto, l’ingauno Luigi possedeva più fantasia che senso della realtà. Comunque fosse, un pomeriggio assolato e caldo si sentì un ‘auto rombare su per il viale e non si comprendeva chi potesse essere, dato che ancora nell’immediato dopoguerra le auto erano veramente pochine e, per completezza d’informazione, non era atteso nessun ospite di riguardo.
Pochi istanti dopo, quando l’auto fu arrivata sul piazzale e si fermò, il mistero si risolse quando si vide scenderne il Marchese Luigi accompagnato da altre persone tra le quali una signora.
Era una signora sulla cinquantina, nel complesso più brutta che bella, nonostante l’aspetto curato, e di corporatura esile.
Vestiva un abito azzurro molto elegante e portava una fascia in testa del medesimo colore.
Il colorito della sua pelle era pallido, ma sul suo viso risaltavano le labbra rosso intenso e due occhi azzurro mare.
Parlava solamente inglese e non si comprendeva nulla di ciò che diceva con gli altri compagni di viaggio.
Si infilarono tutti dritti in villa e ci stettero un paio d’ore, quindi come erano arrivati risalirono in auto e ripartirono.
Solo quando furono ripartiti si venne a conoscenza che quegli insoliti ospiti, che il Marchese Luigi aveva condotto in villa quasi col piglio del padrone di casa, un po’ come era solito fare Carlìn, erano suoi amici in viaggio e che la misteriosa donna non era una nobildonna qualsiasi, ma era una femme fatàl e si chiamava nientepopodimeno che Wallis Simpson!
Era la donna per la quale il re Edoardo VIII aveva abdicato rinunciando al trono d’Inghilterra e che Luigi aveva conosciuto ed agganciato chissà dove, chissà come, chissà quando.
Lei era in viaggio di trasferimento e, siccome allora non esistevano ancora né le autostrade né tantomeno gli autogrill, il suo occasionale compagno di viaggio aveva offerto le proprie conoscenze in loco per una sosta ristoratrice.
Coloro che ebbero la fortuna di vederla commentarono all’unisono che doveva trattarsi di amore vero, almeno da parte di Edoardo VIII, poiché l’impressione che la Simpson aveva suscitato durante quell’apparizione lampo non era stata tanto quella di una fatalona per la indubbia bellezza o per il fascino emanato, forse lo sarà stata per l’intelligenza oppure per la personalità, ma nessuno dei presenti aveva avuto tempo e modo per verificarlo.
Renato, in qualità di esperto del gran mondo, commentò con un lapidario: “A l’è propriu in’americana….”
A proposito di Renato abbiamo già avuto modo di vedere che durante i periodi di residenza stampinese era solito portare con sé la famiglia.
La figlia Renata nel frattempo era cresciuta e si era fatta una bella ragazzona che frequentava le superiori a Genova.
Durante l’inverno del 1947 la giovane aveva intrapreso un’amicizia particolare con un coetaneo nonché compagno di classe che amava frequentare nonostante la feroce opposizione di mamma Pina, la quale cercava di condizionare oltre che la figlia anche il marito, che non sapeva bene quale atteggiamento assumere.
Il tempo passava ed i due ragazzi continuavano a frequentarsi assiduamente incuranti dei rimbrotti materni.
Si arrivò così alla primavera del ’50 e lo studente, ormai conclusi gli studi e trovandosi allora sotto servizio di leva a Como, durante una licenza tornò a casa in Liguria, però non si fermò a Genova, ma proseguì fino ad Andora per venire a trovare la beneamata.
Renato accennò il fatto “au Sciù Giuvanni”, fermo restando che la signora Pina nel frattempo non aveva assolutamente receduto dalla propria convinzione sul conto del giovane, ma, anzi, con fiero cipiglio continuava a tifare apertamente per un altro pretendente con il quale la diretta interessata non aveva assolutamente intenzione di legarsi in alcun modo.
Il giovane soldatino amico di Renata, che si chiamava Alberto, arrivò in treno ad Andora per trascorrere un paio di giorni accanto a quella che oramai considerava la propria fidanzata, ma non immaginava in alcun modo la prova alla quale sarebbe andato incontro in capo a pochi minuti. Infatti non fece nemmeno in tempo a scendere dal predellino del treno che il futuro suocero lo invitò a seguirlo a Stampino per incontrare il Conte che lo voleva conoscere immediatamente.
Pertanto, manco il tempo di posare la valigia, e fu subito introdotto al cospetto del padrone di casa.
L’incontro durò l’eternità di tre ore, tre lunghe ore con la presenza saltuaria anche della Contessa, durante le quali il giovanotto venne sottoposto ad un fuoco di fila alzo zero di domande che aveva per oggetto la sua persona partendo dalla nascita fino al momento contingente.
Al termine dell’interrogatorio, previa promessa che Alberto sarebbe poi andato a trovarlo nella sua residenza genovese, lo congedò gentilmente ma senza esprimergli alcun giudizio e la cosa più particolare fu che durante l’estenuante colloquio non si parlò minimamente della fidanzata Renata, ma sempre e solo della sua persona, dei suoi interessi e delle sue aspirazioni personali e di lavoro.
Appena terminato il colloquio, il “u Sciù Giuvanni” chiamò a sé il fido Renato e gli disse poche ma chiare e testuali parole:
“Non fatevi sfuggire quel giovanotto! È un ordine”!
La Pina, convinta o meno che fosse, se ne fece una ragione e finalmente sia Renato che la figlia potèrono alfine affrancarsi dai quotidiani ed estenuanti brontolii della Pina. I due innamorati pochi anni dopo convolarono a giuste nozze, dalle quali nacque presto una bimba di nome Marcella.
Per la cronaca, l’allora giovane Alberto, non appena terminato il servizio militare, trovò subito impiego alla Società di Navigazione Italia dove in pochi anni scalò le gerarchie grazie alle proprie doti umane, di capacità gestionale e di conoscenza della lingua inglese. Visse e lavorò in trasferta molti anni a New York ed una volta rientrato in Italia fu promosso ripetutamente fino a diventarne Amministratore Delegato.
Fu poi chiamato a dirigere la Società Aeroporti di Roma sempre con l’incarico di Amministratore Delegato ed infine ne divenne addirittura Presidente, collaborando attivamente e con profitto con la compagnia aerea di bandiera Alitalia dando in questo modo il proprio contributo fattivo affinchè fosse una società redditizia ed in attivo, come era allora prima delle note vicende di cronaca.
Il suo mentore non fece assolutamente in tempo a vedere tutta la brillante carriera percorsa da quel ragazzo poiché sarebbe passato a miglior vita solo poco più di un lustro dopo quel fatidico colloquio, ma aveva dimostrato ancora una volta che, nonostante il tempo fosse trascorso, il suo senso del fiuto e dell’intuizione per uomini e cose era rimasto intatto e che anche quella volta aveva visto lungo.
IL SECONDO DOPOGUERRA
Gli anni cruenti del conflitto hanno spazzato via l’intera flottiglia della SORIMA: nessuna nave è rimasta a galla.
Nel giugno del 1940 il”Rastrello” è silurato per errore dai nostri (!) nel porto di Napoli, il “Rampino” è anch’egli silurato, stavolta dagli inglesi, durante un trasferimento nel gennaio del 1942, stessa sorte subisce il “Rostro” nel settembre dello stesso anno, l’”Arpione” si autoaffonda nel porto di Trieste l’8 settembre 1943, il “Raffio” viene minato e fatto colare a picco dai tedeschi nel porto di Genova il 25 aprile 1945, stessa data dell’affondamento sempre con mine del glorioso “Artiglio”nel porto di Oneglia: un’ecatombe!!
Totale è quindi il tributo al conflitto da parte della SORIMA.
Ma, nonostante l’età che comincia ad avanzare e gli agi ai quali potrebbe ormai giustamente concedersi, il dinamismo di Quaglia non si è assolutamente spento, anzi si è rinfocolato più che mai, quasi che quella forzata inerzia ne abbia paradossalmente moltiplicato le forze, anche perché con la fine della guerra si prospettano urgenti e grosse operazioni di sgombero e recupero dei relitti per rendere agibili i porti e le rade di mezza Europa. E’ un film già visto, tutto come al termine della Prima Guerra Mondiale, ma differente nelle dimensioni del metraggio, che ora è di gran lunga maggiore rispetto alla prima volta dato che praticamente non si è salvato nessun porto d’Europa!
Il business è enorme ed il nostro uomo ci si tuffa a pieno corpo.
L’”Artiglio” ed il “Raffio” sono recuperati, riparati ed ammodernati già nel 1946. Pochi anni dopo altre navi vengono acquistate per rimpiazzare “Rostro”, “Raffio” e “Rampino” e sono ribattezzate allo stesso modo delle precedenti quasi a voler sottolineare che il tempo si era fermato e nulla era cambiato.
Insomma la flotta viene ricostituita più bella ed attrezzata che prima del conflitto; ne è un esempio l’ultima nave arrivata in società, lo “Scalpay”, adibita solamente alla ricerca dei relitti, attrezzata con scandaglio e radar di posizione, il massimo per quell’epoca.
Una curiosità statistica riguarda il fatto che il secondo dopoguerra vede per la prima volta imbarcati sulle navi della SORIMA anche degli andoresi: sono tre e fanno tutti parte dell’equipaggio del “Raffio”, due provengono da Molino Nuovo e sono Armido Longato e Carlo Telesio con la qualifica di fuochisti, il terzo proviene da Rollo ed è Bruno Stalla che svolge il delicato ruolo di palombaro, il quale prenderà parte a numerosi recuperi sia nel Mediterraneo che nell’Atlantico.
Sono di nuovo anni di successi per i recuperi effettuati un po’ ovunque tanto in Europa che per la prima volta in Africa.
Forse l’impresa più prestigiosa di quest’ultimo periodo è quella portata a termine dal “Rostro” nel 1953 davanti a Brest col recupero del carico del “Flying Enterprise”, il cui affondamento aveva attirato l’attenzione mondiale come già avvenuto a suo tempo per l’”Egypt”.
Durante l’estate del 1953 gli uomini del “Rostro” riescono a demolire il relitto e dalle stive della nave tornano alla luce grossi pacchi di banconote inglesi ed americane assieme ad azioni per milioni di euro attuali.
La nave inoltre trasportava anche preziose opere d’arte sotto forma di quadri di Tiepolo, Van Dick e Rubens, tutte quante vengono recuperate e riportate in superficie.
Dulcis in fundo un insolito e grande carico di zirconia, elemento prezioso per la costruzione di reattori nucleari e questo fatto lascerà fino ai giorni nostri un alone di mistero sulla provenienza e lo scopo al quale era destinato un simile materiale.
Quaglia è invecchiato, ma non manifesta la minima intenzione di abdicare non avendo modificato minimamente il suo modo di agire e le sue consuetudini.
Segue sempre da vicino se non proprio da bordo le operazioni di recupero soprattutto quando queste avvengono lontano da Genova.
Col suo immarcescibile basco portafortuna calato in testa sprona e incoraggia i propri uomini, quasi fossero i suoi figli, tanto per operazioni importanti quanto per recuperi di minor importanza.
E’ gentile ed affabile con tutti dal comandante all’ultimo dei mozzi; vuole che lo sentano vicino come una persona di famiglia, vuole fare squadra con loro, si sente come un allenatore in campo e forse anche in questo è un precursore, un principale atipico che precorre tempi più attuali.
Quando arriva è festa per tutti, le sue prime parole sono sempre: “Ragazzi, oggi festa! Andate a mangiare in quel ristorante!” e poi si accoda all’equipaggio ed a tavola scherza e ride assieme a loro non lesinando di dare di gomito al vicino quando è il caso. Praticamente è lui in prima persona che crea l’atmosfera giusta, un’atmosfera da spogliatoio e lui, come nel tennis, è il capitano non giocatore della squadra.
La SORIMA è una società floridissima e di successo a tal punto che ormai si può permettere anche di fare della filantropia o meglio di effettuare delle operazioni gratuite solo ed unicamente per amore della scienza e della cultura.
Quando il Prof. Nino Lamboglia, fondatore dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, nel 1948 contatta l’Avv. Giovani Quaglia, Presidente ed Amministratore Delegato della SORIMA per valutare se le sue navi recupero possano essere utili ed adatte al recupero di una nave romana giacente sul fondo marino di fronte ad Albenga, il patron esprime un immediato e disinteressato entusiasmo alla proposta di mettere il suo “Artiglio” al servizio della scienza archeologica.
L’iniziativa prende una forma concreta solo un anno dopo quando viene sottoscritto un concordato tra Comune di Albenga, Ministero della Pubblica Istruzione, Soprintendenza alle Antichità della Liguria e Capitaneria di Porto di Savona.
La SORIMA si impegna alle operazioni di recupero della nave romana e del suo contenuto a titolo gratuito.
In tutto questo prodigarsi di uomini ed istituzioni si distinguono sicuramente per l’attuazione del progetto il Dott. Pompeo Rolandi Ricci, cugino dell’Avv. Quaglia (che è oriundo albenganese per parte di madre) ed il Dott. Alfonso Ravina Procuratore Generale di Quaglia, che fanno da tramite per l’accordo tra i vari enti.
L’8 febbraio 1950 l’”Artiglio” arriva nelle acque prospicienti l’antica foce del Centa con il suo carico di personale espertissimo e di mezzi tecnici collaudati da una lunga esperienza nello strappare dal fondo del mare carichi preziosi.
Il 9 febbraio vengono già issate a bordo le prime anfore e nel giro di pochi giorni vengono recuperate centinaia di altre anfore.
Oltre alle anfore sono poi recuperati vari oggetti metallici in dotazione alla nave ed ai suoi occupanti.
Lo scafo viene rispettato per quanto possibile e un suo eventuale recupero viene rinviato in date successive, cosa che peraltro fino ad oggi non è mai stata attuata.
Il lavoro non è certamente terminato, anzi è appena iniziato, ma tant’è, ciò che è stato fatto è già sufficiente per cantare vittoria e poter decretare che è nata una nuova era archeologicamente parlando.
Il Prof. Nino Lamboglia e la SORIMA, agendo di conserva, hanno appena aperto un nuovo intrigante capitolo in prima mondiale: quello dell’archeosubacquea ovvero il recupero di reperti archeologici dai fondali marini.
L’immediata conseguenza di questo ennesimo successo delle navi dell’Avvocato sarà l’allestimento nel salone di Palazzo d’Aste, messo a disposizione dal Comune di Albenga, di una “Mostra della Nave Romana”, destinata successivamente a divenire un museo permanente, anzi a divenire ciò che oggi è l’attuale “Museo Navale Romano” di Albenga che accoglie il materiale recuperato dall’”Artiglio” ed una ricostruzione in modellino della nave che giace ancora sul fondale marino.
L'APPRODO FINALE
Quella del recupero delle anfore contenute nella nave romana affondata davanti ad Albenga è una delle ultime imprese dell’”Artiglio” e più in generale della SORIMA che destano impressione e catalizzano l’attenzione generale sia a livello nazionale che internazionale.



Anche questa volta Quaglia si è rivelato un precursore: ha saputo intuire e presagire nuove possibilità e opportunità che la tecnologia mette a disposizione sua e dei suoi uomini. D’altronde egli si è sempre rivelato e dimostrato un uomo fortemente positivo ed ottimista, pienamente conscio delle proprie possibilità ed al contempo fiducioso nelle qualità di coloro che lo circondano. Infatti il suo maggior pregio, a detta di tutti, è sicuramente quello che ha sempre saputo circondarsi di persone valide ed operose che conoscono il proprio lavoro ed assolvono il proprio dovere come nessun altro. Forse il segreto del suo ultradecennale successo risiede proprio in questa sua qualità innata: il saper vagliare le persone umanamente e lavorativamente come pochi altri.
Purtroppo per il grande castellotto le ultime imprese descritte rappresentano il canto del cigno perché di lì a poco cominceranno inesorabilmente a srotolarsi i titoli di coda.
Infatti un problema cardiaco, che si paleserà progressivamente ma inesorabilmente, lo porterà in un paio d’anni al trapasso, che si verificherà l’8 dicembre 1955 nella sua residenza genovese al 37 di Via XX Settembre. assistito dalla consorte e dalla fida servitù.

Residenza genovese del Commendator Quaglia.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
La notizia della sua morte fa clamore alla pari dei suoi incredibili recuperi.
I giornali di mezzo mondo titolano che è morto”…..il re dei recuperi sottomarini…..,….. “uno dei più attivi ed arditi armatori liguri…...” ed ancora ”….. un gentiluomo che possedeva in grado eccelso le virtù della gente ligure…..”
I funerali si svolgono a Diano Castello, suo paese natale, e dapprima viene ivi sepolto, ma la moglie lo vuole vicino a sé e alcuni mesi dopo lo trasla a Genova dove viene definitivamente tumulato nel cimitero monumentale di Staglieno dove si trova tuttora.
Con la sua scomparsa la vedova si distacca subito dalle proprietà rivierasche che lui tanto amava tanto è vero che già l’anno successivo mette in vendita la villa di Stampino con annesso parco e collina retrostante, che viene acquistata in blocco dall’industriale imperiese Carlo Isnardi. Invece le terre coltivate, che sono ubicate più in basso, sono praticamente svendute agli ex dipendenti o ai mezzadri che siano interessati all’acquisto.
Se a Genova “u Sciù Giuvanni” dispone dei lasciti, come ben testimonia la lapide nell’atrio del monoblocco dell’Ospedale San Martino, al paese natale a Diano Castello destina buona parte dei suoi beni e del suo denaro per opere di beneficenza e di assistenza ai malati ed agli anziani. Lo testimonia la donazione all’antico Ospedale di Santa Croce, che, grazie a ciò, viene rinnovato ed ammodernato completamente e viene adibito a casa di riposo a lui intitolata.
Nell’ingresso dello stesso una stele marmorea ne ricorda la carità e la generosità a nome della comunità castellotta mentre un busto con le sue fattezze reca sotto la scritta “Benefattore”.
Ad Andora invece, come volontà postuma, lascia disposto che in pratica venga quasi fatto dono delle proprie terre ai contadini che per anni ed anni le hanno coltivate in qualità di dipendenti o mezzadri. Chi è interessato all’acquisto le può comprare a prezzi di tutto favore e chi non è nemmeno in grado di pagare a prezzo di liquidazione viene assistito per l’accensione di un eventuale mutuo.
Anche Giovanni acquista un pezzetto di terra sito poche centinaia di metri sotto la villa sul quale intende realizzare un’azienda floricola specializzata nella coltura delle strelizie, come aveva sempre anelato fin da giovane, ed inoltre edificare una casetta finalmente propria, casetta che fa costruire, guarda caso, proprio da alcuni di quei “Profughi” che alcuni anni prima aveva, come dire, tentato di rieducare a fucilate e che ora sono cresciuti ed ai suoi occhi sono finalmente diventati ragazzi affidabili e laboriosi.
Due dei suoi confinanti sono per l’appunto “Marchìn” Bertolino e “Tugnìn” Verda e, poco più in giù, alla Casa Garotta, c’è anche il suo grande amicone Ernesto Bonifacino, a testimonianza che tutti hanno approfittato della ghiotta occasione e ne hanno usufruito per diventare piccoli proprietari terrieri.

La contessa Tina con Ernesto Bonifacino, durante l'inaugurazione AVIS di Andora.
Foto dell'autore
Giovanni abiterà a Stampino insieme alla propria famiglia ancora qualche anno, giusto il tempo per costruirsi la casetta tanto agognata, dove andrà ad abitare assieme a Pina ed alla famiglia del figlio, che nel frattempo si è sposato con Luisa dalla quale è nato il sottoscritto, che avrà così il privilegio e l’onore di poter affermare di aver vissuto anch’egli in prima persona un paio d’anni a Stampino, anche se i ricordi sono praticamente nulli.
Contemporaneamente a Giorgio anche Rina, ormai cresciuta e diventata una bella ragazza, nel frattempo si è sposata e si è trasferita alla Marina divenendo in breve madre di due pargoli.
Dopo circa un ventennio si conclude così la presenza e la storia della nostra famiglia in villa.
Con questa frammentazione della proprietà tra gli ex lavoranti cala il sipario sulla quarantennale presenza, per quanto non continuativa, ma comunque assidua, dell’Avvocato, Cavaliere di Gran Croce della Corona d’Italia, Commendatore dei Santi Maurizio e Lazzaro, Conte Quaglia ad Andora, un uomo che a livello locale ha lasciato solo ricordi pieni di riconoscenza e gratitudine.
La sua creatura per eccellenza, cioè la SORIMA, sopravviverà in mano ai suoi soci ancora per quasi un quinquennio, poi, complici sia il cambiamento dei tempi, sia la mancanza di un leader vero con le idee chiare, quale era stato il suo padre-padrone fondatore, nel 1960 chiude per sempre i battenti e con la sua liquidazione praticamente termina l’era romantica dei recuperi sottomarini.
Negli anni successivi la vedova signora Tina farà di nuovo ritorno in riviera più volte, ma, per ovvi motivi, quasi unicamente a Diano Castello.
Il connubio Quaglia - Andora sembra così arrivato al termine ed il ricordo dell’armatore destinato ad affievolirsi ed a svanire progressivamente nel tempo, quando, nei primi anni sessanta a livello locale accade qualcosa di nuovo ed inaspettato che genererà un ultimo colpo di coda sulla sua influenza in seno alla comunità andorese.

La contessa Tina e il conte Quaglia presso il Parco delle Terme a Montecatini Terme.
Rielaborazione a colori - Mario Vassallo
L'AVIS ANDORA
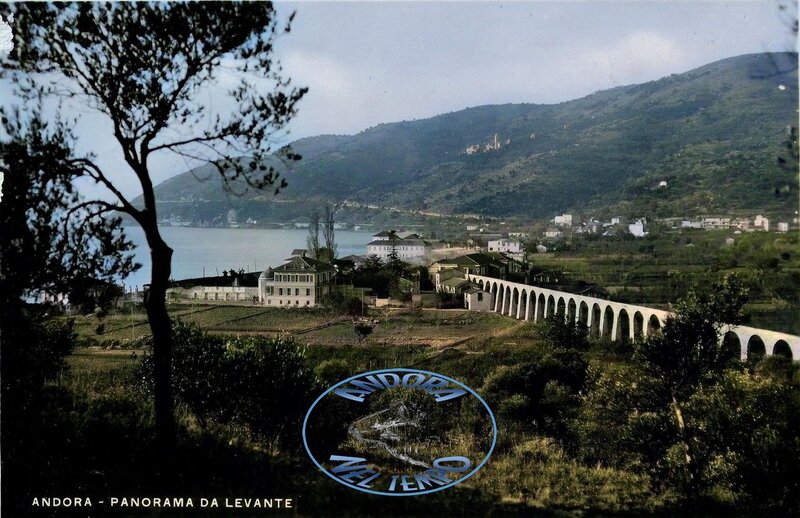
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora.
Rielaborazione a colori - Mario Vassallo
Nei primi anni ’60 la comunità andorese inizia un altro periodo di forte crescita sia sotto l’aspetto economico, sia demografico, sia sociale.




L’economia locale inizia un’altra stagione di grandi cambiamenti e trasformazioni: infatti i frutteti e gli orti della Marina vengono progressivamente soppiantati da un altro genere di coltivazione, evidentemente molto più redditizio, quello dei palazzi, che, dalla mattina alla sera, sorgono e crescono in maniera spropositata ed affollata alla stessa stregua dei funghi di serra.
Ciò che è più preoccupante è costituito dal fatto che si costruisce ovunque, anche a pochi metri dal mare, e lo stile non è proprio da manuale dell’estetica, senza contare il fattore verticalità.
Durante questo boom edilizio ciò che colpisce maggiormente l’occhio sono i palazzi a cinque piani posti a lato delle precedenti modeste casette coloniche, che, poco a poco, vengono abbattute per far spazio alle nuove costruzioni ed alle vie squadrate.
Non c’è pietà nemmeno per l’antico e spettacolare acquedotto aereo del XVIII sec. che originava dalle sorgenti di Mezzacqua e portava i rifornimenti idrici fino alle proprietà del Marchese Maglioni intorno a Villa Mazè. Questo acquedotto che si sviluppava su decine di arcate, caratterizzava singolarmente il panorama della zona a levante di Andora Marina, conferendo al paesaggio una nota tutta particolare, come si può vedere dalle foto d’epoca; purtroppo non riesce a sopravvivere al cieco ed ingordo furore edilizio degli anni sessanta e a tuttoggi ne rimangono in piedi solo tre misere arcate in un giardino privato (sic). Avrebbe potuto e avrebbe dovuto essere il simbolo di Andora e invece…..
Bisogna prendere atto che questa nuova opportunità di sviluppo, invece di essere gestita e sviluppata in maniera gradevole e sostenibile, soprattutto nella zona planiziale è stata tradita, sfruttandola in maniera eccessiva o distorta e quel che è più grave, è che, seppur a distanza di molti decenni, questa abitudine purtroppo è tutt’altro che morta. Anzi, si è dimostrata vivissima ancora negli anni duemila, tanto che si è edificato ancora troppo in alto ed addirittura sulla battigia.

Ambulanza donata dalla contessa Quaglia all’Avis di Andora.
Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora.

Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora.
Rielaborazione a colori - Mario Vassallo
Abbiamo così purtroppo assistito ad uno spettacolo che ormai credevamo appartenesse ad una mentalità di mezzo secolo prima e cioè la edificazione di inutili, informi ed oltraggiosi condomini su verdi prati in riva al mare (una vera rarità per la Liguria) che si erano miracolisticamente salvati, in quanto terreno delle ex colonie di Asti e Cuneo, e che meritavano ben altra ed opportuna valorizzazione ai fini turistici. Anche questi spazi verdi avrebbero potuto e dovuto essere il simbolo di Andora degli anni duemila e un’altra volta ancora invece…..
Durante gli anni ‘60 vengono tracciate le piazze e le vie che oggigiorno costituiscono il cuore commerciale ed economico di Andora: la prima è Piazza Doria nel 1960 con l’omonima via, alla quale seguirà Via Roma e così di seguito.
Nel 1961 viene realizzato un nuovo ponte sul Merula, battezzato appunto “Ponte Italia ‘61”, che va a rimpiazzare il vecchio e stretto ponticello realizzato con le traversine di legno della ferrovia.
Nel 1961 anche Andora si dota finalmente delle Scuole Medie Inferiori, che vengono provvisoriamente alloggiate in Palazzo Tagliaferro, ed i ragazzi andoresi non sono più obbligati a recarsi fino ad Alassio per conseguire la licenza media inferiore.
Nel 1963 viene iniziata la costruzione del porto, il quale si dimostrerà un notevole motore economico oltre che un inaspettato aiuto per il ripascimento del litorale e la sua trasformazione da pietroso a sabbioso naturale, implementandone altresì la sua profondità di decine di metri.
Poco dopo inizia la costruzione delle nuove Scuole Elementari e Medie, anche se la loro realizzazione si prolungherà fino a metà anni settanta.
Anche le colline vengono progressivamente urbanizzate, seppur seguendo una politica edilizia più sostenibile ed elegante tramite la costruzione di ville e villette che si integrano adeguatamente nel paesaggio.
Il fervore edilizio, imperniato soprattutto sulla politica della seconda casa al mare per i villeggianti estivi padani, attira manodopera da tutta Italia sia da nord che da sud ed il numero dei residenti aumenta vertiginosamente.
Contemporaneamente anche la vita sociale ne risente e fiorisce l’associazionismo a tutti i livelli, sportivo, sociale ed umanitario.

S.E. Mons. Gilberto Baroni, vescovo di Albenga, benedice l’ambulanza alla presenza della contessa.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
E’ proprio in questo periodo che anche ad Andora si viene costituendo un nucleo di donatori di sangue.
Si tratta di un primo gruppo storico di circa una decina di persone che decide di iscriversi all’A.V.I.S. e di cimentarsi in questa più che meritoria opera umanitaria.
Però ad Andora non esiste ancora una sezione ed i volontari devono recarsi fino ad Albenga per effettuare le donazioni, ragion per cui i donatori andoresi pensano bene di istituire una sezione locale, ma c’è un problema non da poco: per realizzare questa è necessaria, oltre che una sede, anche un’ambulanza per i servizi di consegna dei prelievi.
Sarebbe sufficiente anche una vecchia ambulanza di seconda mano, ma non è che costi proprio due lire pertanto il gruppetto di amici volontari si spreme le meningi per partorire un’idea valida che permetta loro di radunare la somma necessaria all’acquisto, quando a Bruno Stalla, che era stato palombaro della SORIMA a bordo del “Raffio”, viene un’idea che non esita a buttare lì.
“Perché non chiediamo un contributo alla Contessa Quaglia?”
Detto fatto Bruno Stalla e Vittorio Navacchi partono in missione per Genova e si recano dalla vedova per esporre la richiesta.
La Contessa li riceve da par suo nel segno della tradizione di famiglia e, non solo si rivela disponibilissima come sempre, ma fa molto di più, poiché non si limita ad elargire una somma, ma poco tempo dopo fa consegnare direttamente alla costituenda futura sezione andorese dell’A.V.I.S. una FIAT 600 T, attrezzata all’uso, che all’epoca costituiva il modello base di ambulanza.
Ed è così che il 13 febbraio 1964 viene ufficialmente dato il via libera alla nascita della sezione andorese dell’A.V.I.S., che ovviamente non può essere altrimenti intitolata che al marito Giovanni Quaglia.
La prima sede è sistemata provvisoriamente in alcuni locali al pian terreno di Palazzo Tagliaferro, lato est, edificio che allora accoglieva, sempre a titolo provvisorio, anche le scuole medie inferiori ed altre associazioni.
Primo presidente è l’impresario geometra Giuseppe Bagnasco ed il medico che effettua i prelievi è il Dott. Franco Zunino, successivamente anch’egli presidente.
Il 15 marzo 1964 si celebra la festa ufficiale di fondazione della sezione.
La contessa Tina De Nicola vedova Quaglia è la madrina d’eccezione della manifestazione alla presenza delle massime autorità civili, tra le quali il Sindaco Dott. Walter Momigliano, e militari locali, nonché del vescovo della diocesi, S. E. Monsignor Gilberto Baroni, allora Vescovo di Albenga, che benedice la nuova sede.
Anche in questa occasione, ora come allora, la Contessa arriva sulla grande auto scura pilotata da Renato e lo charme è sempre quello di un tempo.
La manifestazione si rivela oltretutto un’occasione ghiotta e forse irripetibile per molti ex lavoranti di andare a salutare ancora una volta quella che molti considerano ancora la “loro Signora”; infatti non manca praticamente nessuno di coloro che fino ad un decennio prima aveva lavorato a Stampino per suo marito ed il calore con il quale la festeggiano è reale e sentito a tal punto che sembra quasi che il tempo si sia fermato: manca solo Lui e più di uno, come Giuseppina, si commuove al punto da lasciarsi scappare la lacrimuccia. La vera primadonna della situazione non può essere che Lei e solamente Lei, tanto è vero che molti fanno la coda per farsi fotografare al suo fianco come si fa con le star del cinema o dello sport.
Da quel lontano giorno del 1964 ad oggi l’A.V.I.S. Andora ha progressivamente visto crescere sia il proprio impegno umanitario che la propria importanza grazie al continuo crescente numero di iscritti e donatori.
Infatti quella sparuta decina di donatori-fondatori nel corso del tempo si è moltiplicata facendo proseliti e la sezione a tutt’oggi può annoverare oltre duecento soci donatori.
Oggi, grazie alla fattiva e positiva collaborazione con la Croce Bianca, la cui fondazione fu a propria volta stimolata da questi predecessori, l’A.V.I.S. Andora può vantare una sede moderna e funzionale che continua ad operare nel tempo la propria insostituibile azione salvavita alla pari della sopracitata Croce Bianca Andorese.
La Contessa ritornò ancora una volta ad Andora l’anno successivo, il 6 giugno 1965, in occasione delle premiazioni dei donatori più meritevoli, e quella sarebbe stata la sua ultima volta presso la nostra comunità.
Anche in quell’occasione, come l’anno precedente, a margine delle manifestazioni, la Contessa non mancò di salutare, singolarmente e in disparte con sincera affettuosità, ogni suo ex lavorante o vecchia conoscenza. Si informava sulle vicende di vita di ognuno e per ognuno riservava parole adeguate di incoraggiamento oppure conforto a seconda dei casi. Comunque ciò che più mi colpì, nel mio candore di bambino che osservava queste scene con curiosità ed un pizzico di intriganza tipicamente infantili, fu la naturalezza e l’abilità con la quale riusciva a far scivolare delle banconote da 10.000 lire (circa 200 euro attuali) nelle mani di ogni suo interlocutore privilegiato. Accanto a sé aveva il fido Renato che le teneva la borsetta nera ferma all’altezza prefissata e la apriva e la chiudeva con un tempismo degno di una macchina operatrice. Non era necessario che gli dicesse nulla, bastava che si girasse verso lui e ciò bastava. Renato gliela apriva automaticamente senza battere ciglio, lei infilava la mano all’interno ed ecco che, quasi come fosse stata una vecchia zia che elargiva mancette ai nipoti, ne usciva una bella banconota frusciante che passava dalle sue mani a quelle dell’interlocutore quasi con abilità da prestigiatore. Sempre nel mio immaginario infantile, quella borsetta mi colpì a tal punto che mi sembrava quasi quella di Mary Poppins, dalla quale uscivano notoriamente tutti gli oggetti più inverosimili, ma soprattutto mi domandavo come facesse la Contessa a possedere così tante banconote. Quel giorno ne elargì decine e decine.
La Contessa passò a miglior vita pochi anni dopo, ma le piacevoli sorprese che aveva riservato ai cittadini andoresi non erano ancora terminate.
Infatti, come già detto, la sede primitiva dell’A.V.I.S. ANDORA era provvisoriamente locata in Palazzo Tagliaferro e nei primi anni settanta gli avisini locali, di concerto con l’allora amministrazione comunale, quando ebbero raccolto una cifra sufficiente per iniziare i lavori di edificazione della nuova sede, scoprirono con grande stupore di essere stati annoverati tra gli eredi della Benefattrice, seppur a distanza di mesi dalla di Lei dipartita.
La vedova Quaglia aveva lasciato come disposizione postuma agli esecutori testamentari di consegnare dieci milioni di lire, ( dicansi dieci! ), che nei primi anni settanta erano davvero una bella cifra, all’A.V.I.S. Andora per la costruzione della nuova sede.
Così nel 1973 inizia la costruzione di quella che poi è l’attuale sede dell’A.V.I.S. Andora, che in breve tempo viene completata grazie anche al lauto ed inaspettato contributo della Benefattrice, opera che oggigiorno risulta ulteriormente ampliata in quanto ospita tanto la suddetta associazione quanto la Croce Bianca Andora.
I turisti che sono soliti passeggiare oppure correre e che, durante il periodo estivo, arrivano addirittura ad accalcarsi sulla passeggiata a mare della nostra cittadina per sottostare al consueto rito dello struscio serale, sicuramente ignorano, come purtroppo molti andoresi, che quel marciapiedi sopraelevato situato in posizione panoramica e dominante le spiagge sottostanti a levante del Merula, alla fine degli anni settanta è stato intitolato alla figura dell’armatore Giovanni Quaglia. A proporre la dedica e ad effettuarla assieme all’amministrazione locale di allora fu proprio Giorgio il quale nel frattempo, oltre ad essere diventato un uomo maturo ed impegnato, ricopriva l’incarico di assessore all’anagrafe.

Il Dott. Franco Zunino rende gli onori di casa alla contessa durante la cerimonia di benedizione dell’ambulanza donata.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
Con questo atto volle esprimere a nome proprio e di tutta la comunità la riconoscenza nei confronti di chi aveva molto dato sia alla propria famiglia ed a lui in particolare, sia ad Andora in toto.
Purtroppo da tanti, troppi anni, complici forse i numerosi lavori di ammodernamento ed abbellimento che si sono succeduti nel corso del tempo, sulla passeggiata di quell’intitolazione si è persa ogni traccia.
Speriamo che quanto prima le dovute targhette vengano ripristinate in modo che tutti possano venire a conoscenza della meritevole intitolazione ed al contempo non sarebbe superfluo aggiungere una placca speciale suppletiva, come spesso avviene in questi casi, sulla quale riassumere sinteticamente le memorabili imprese compiute da Giovanni Quaglia.
D’altronde se ciò è stato fatto per altri illustri personaggi giustamente meritevoli e nemmeno italiani, non si capisce perché non si debba fare altrettanto nei confronti dei nostri migliori conterranei.
EPILOGO
…..il campanile della chiesa di San Giovanni batte le ore ed il suono familiare della campana ha il potere di riportarmi al presente da quel trasognamento mentale.


Quanto tempo è trascorso? Non saprei quantificare….. non saprei quantificare quanto è durata quella trance spazio temporale che mi ha rapito come se fossi stato colpito da una sindrome di Stendhal.
Mi rendo conto che nel frattempo il sole si è abbassato ed ormai non scalda più, i passeri si sono dileguati e gli storni se ne sono andati dopo aver portato a termine la loro incursione.
I comignoli del Gumbasso cominciano ad emettere le prime nervose volute di fumo alla pari di quelli dei Canossi: l’aria si è fatta sottile.
Ancora un abbaio, segno che Charly non molla la posizione ed è sempre là, vigile sotto le “Pigne”.
Un attimo dopo, uno dietro l’altro, senza proferire parola e accennando appena un saluto con la testa leggermente china sotto il loro ondeggiante zaino sulla schiena, passano lesti lesti gli ultimi due escursionisti della domenica intenti a rientrare con passo veloce prima che scenda la sera.
Si tratta di due giovani dalla gamba buona e pochi secondi dopo spariscono alla mia vista tirando diritto verso la Garotta.
E’ ora che rientri in casa anch’io e, girandomi sui miei passi, il mio sguardo si rivolge forzatamente ancora una volta verso la villa di Stampino, che, anno dopo anno, mi appare sempre più come una anziana signora col volto oramai segnato dall’inesorabile trascorrere del tempo e che, per non farlo vedere, si nasconde dietro gli alti cipressi del suo parco quasi fossero una gigantesca veletta per nascondere le rughe, ma al tempo stesso lascia ancora intuire la bellezza e la sontuosità del tempo che fu.
Certo, la villa è oramai disabitata ed abbandonata a sé stessa da molti, troppi anni e recentemente è rimasta anche trascurata, ma possiede pur sempre un fascino immutabile.
Chissà quando mai rivivrà stagioni intense come quelle vissute con il conte Quaglia?
Sto facendo questa ultima riflessione quando al secondo piano vedo una persiana aprirsi sbattendo violentemente sul muro della facciata e dietro i vetri con mio enorme stupore mi par di distinguere una grossa figura con sembianze umane, poi, al contempo, un lampo di luce quasi come se qualcuno all’interno stesse accendendosi una sigaretta oppure….. un sigaro?!?
No, non è possibile, …..eppure sembrerebbe proprio…..possibile che….?
Il mio cuore ha un soprassalto e batte forte in gola quasi avessi scorto un fantasma ed al contempo, ben oltre la già fresca temperatura stagionale, un gelido brivido percorre il mio corpo dalla testa ai piedi.
Sono solo pochi istanti, ma lunghi un’eternità, per fortuna un attimo dopo la ragione ha di nuovo il sopravvento.
Ma no!! Non può essere possibile!! Cosa mai vado a pensare?? I fantasmi non esistono!! Tutto ha una spiegazione ed anche in questo caso c’è logicamente una ragione.
La persiana ha semplicemente sbattuto perché nel frattempo si è levata una fredda aria serale che, oltre a sferzarmi il viso, agita la chioma degli alberi ed evidentemente anche la persiana che ha sbattuto non era bloccata a dovere.
L’ombra umana che mi è sembrato di distinguere è originata dal vetro sporco che, illuminato dagli ultimi raggi del sole morente a fil di collina, ha creato un’illusione ottica giocando ad ingannare la mia vista, al pari di quel raggio di luce riflessa sul vetro che simulava una fiammata.
Il resto ce l’ha messo la mia fantasia o meglio la mia suggestione.
Siamo seri, gli spiriti non esistono, checché qualcuno ne dica….. ma lo spirito di una persona sì, sopravvive al di là del tempo e degli avvenimenti che si succedono e sono convinto che non morirà mai, alla pari delle sue opere e delle sue imprese, ancor più se rimarrà nel ricordo e nel sentimento di coloro che rimangono.
FINE

La Tenuta Stampino oggi.
Foto Ovidia Siccardi e Mario Vassallo
POST SCRIPTUM
Alla veneranda età di 95 anni l’ex Caporale Karl Kappes è tuttora in ottima salute e si gode finalmente la meritata pensione dopo aver lavorato fino all’età di 89 anni nella propria azienda enologica, che produce un ottimo Riesling Spatlese, a Zeltingen sulle meravigliose rive della Mosella.
Salute ! Anzi, Prosit!

Zeltingen 2018: l'autore assieme a Karl Kappes e all'interprete Sabine Koegel.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
RINGRAZIAMENTI
Un quanto mai doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, chi tramite racconto orale in quanto testimone vivente dei fatti narrati, chi con opera di ricerca storica sui documenti o sui libri ed infine chi con contributo fotografico.
ALBORNO Prof. Silvia
ANFOSSO Laura
BERTOLINO Giacomo
BONIFACINO Ernesto
CORBOLANTE Dott. Licia
DEGOLA Antonello
DRI Bruna
FASSIO Leopoldo “Leo”
GAGLIOLO Guido
KAPPES Karl
LUNGHI Elio
MESSORI Franco
MICHERI Carla
MORANDI Alberto
MORANDI Marcella
MORENO Cristina
NOVARO Domenico “Meneguccio”
RANDONE Giovanni Battista “Nini”
RAVINA Luigi “Gigetto”
SETTI Bruno
SCHIVA Prof. Tito
STALLA Bruno
TREVIA Emanuele
TREVIA Pietro “Pierino”
TAGLIATINI Francesco
VERDA Felice
VERDA Maddalena “Berta”
VEZZARO Marino
VOLPARA Caterina “Rina”
VOLPARA Giorgio
Un sentito ringraziamento a parte alla Signora Sabine KOEGEL per la disponibilità manifestata in qualità di interprete durante la trasferta in terra di Germania.
BIBLIOGRAFIA
Appunti personali Signora Isa Gastaldi
Archivio di Stato Savona
Archivio Comune di Andora
Archivio Catastale Napoleonico di Torino
Conservatoria di Finale Ligure
“Con i marinai dell’Artiglio” di David Scott - Ed. TREVES
“L’Artiglio e l’oro dell’Egypt” di David Scott - Ed. MONDADORI
“L’Artiglio ha confessato” di Silvio Micheli - Ed. VALLECCHI
“L’Artiglio” di Boris Giannaccini - Ed. PEZZINI
“Questa nostra Andora” di Alma Anfosso - Ed. DELFINO MORO
“Come eravamo” di Antonello Degola - Ed. DELFINO MORO
“Viaggio nella Liguria Marittima” di Davide Bertolotti
“Alassio, Albenga e Andora” di Carlo Reynaudi - Ed. ROUX FRASSATI & C.
“Biblioteca Nazionale Braidense” - MILANO
LA SO.RI.MA.
La società anonima “So.Ri.Ma.”, acronimo per Società Ricuperi Marittimi, vide la luce a Genova l’11 ottobre 1926, e, fino al suo scioglimento avvenuto nel 1960, legò il proprio nome ad una lunga serie di operazioni subacquee di ogni genere.







Quando fu fondata la So.Ri.Ma. costituì una novità assoluta a livello mondiale, in quanto prima ditta specializzata in immersioni marine a grandi profondità, tali da essere allora considerate impossibili da raggiungere da parte degli addetti ai lavori di allora.
Il vero ideatore dei recuperi in profondità fu Alberto Fagian, mentre Presidente fu nominato il Gr. Uff. Alberto Manzi Fè. Il maggior azionista era invece il Commendator Giovanni Quaglia, il quale ricopriva anche la carica di Amministratore Delegato. La società aveva sede nel palazzo della Nuova Borsa in Piazza de Ferraris.
Correvano gli anni del primo dopoguerra e molte navi, affondate per sinistri marittimi, ma soprattutto per cause belliche, attendevano di essere recuperate con i loro carichi di valore. La prima guerra mondiale non fu, come molti credono, solo una guerra di trincea; i sottomarini tedeschi operarono una vera e propria mattanza nei nostri mari, affondando con i loro siluri non solo navi, ma migliaia di tonnellate di materie prime importate dall’estero, senza contare il fattore umano, cioè la moltitudine di marinai perduti negli abissi marini.
Tanto per citare un esempio, fra Capo Mele e l’isola Gallinara, in pochi chilometri quadrati di mare, gli U-Boot tedeschi mandarono a picco diverse navi quali: l’Umberto I, il Monte Bianco, l’Hylonian, lo Stromboli ed il Ravenna.
In ogni caso le fortune della So.Ri.Ma. si rivelarono già da subito strettamente legate all’abilità politico-imprenditoriale dell’Avv. Giovanni Quaglia che, sempre ed in ogni momento, ebbe idee estremamente chiare in merito al lavoro da svolgere e seppe tessere ed intrattenere le giuste amicizie e conoscenze in seno agli ambienti governativi onde poter ottenere le adeguate concessioni.
Già il 15 dicembre 1926 la So.Ri.Ma. sottoscriveva un contratto con l’INA (Istituto Nazionale delle Assicurazioni ), con il quale acquisiva l’esclusiva per il recupero del carico affondato col piroscafo americano Washington, silurato il 3 maggio 1917 dall’U-Boot 63 della marina imperiale tedesca comandato dal tenente di vascello Otto Schultze, giacente su un fondale di 90 metri davanti a Camogli.
L’INA gestiva per conto dello Stato l’Azienda dei Rischi di Guerra in Navigazione, l’Avv. Quaglia, con detto contratto, sperimentava la concessione in esclusiva del recupero di tutte le navi e dei rispettivi carichi affondati per cause di guerra lungo le coste italiane, la cui proprietà in seguito all’affondamento rimaneva all’Azienda dei rischi di guerra in navigazione.
A Camogli, laddove il Washington colò a picco, arrivarono le prime tre navi sociali di So.Ri.Ma. appositamente attrezzate: Artiglio, Raffio, Arpione. I lavori durarono più di due anni e dalle stive del piroscafo vennero fuori cinquecento tonnellate di barre di rame, cinquanta di acciaio, cinque locomotive e trecento carri ferroviari.

L'Artiglio, il Raffio e l'Arpione, sul relitto del Washington (inverno 1929)
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
A quei tempi sembrava impossibile poter lavorare a tali profondità, ma i segreti per la riuscita di quell’impresa furono due; il primo gli speciali scafandri rigidi della ditta tedesca Neufeldt & Kunke di Kiel dei quali la So.Ri.Ma. ottenne l’esclusiva per l’Italia e poi, non da meno, il fattore umano, costituito dall’ingaggio, nella primavera del 1927, di una qualificatissima pattuglia di palombari viareggini, capitanati dal mitico Alberto Gianni, i quali si riveleranno semplicemente i migliori al mondo.
Il Gianni, formatosi come tanti altri alla Regia Scuola Militare del Varignano, in particolar modo, nonostante avesse ricevuto un’educazione scolastica elementare, rivelò incredibili doti di intuizione e cognizione tecnica che in breve permisero di scendere e lavorare in sicurezza a profondità fino allora impensabili. Dapprima apportò modifiche agli scafandri tedeschi, rendendoli ancor più competitivi e sicuri, ma poi, non ancora appagato, concepì un nuovo modo di lavorare radicalmente differente da quello in uso, ideando e realizzando la cosiddetta “torretta”. Praticamente si trattava di un tubo d’acciaio rinforzato e dotato di oblò da osservazione che permetteva al palombaro di essere l’occhio in profondità e, tramite collegamento telefonico con la nave appoggio, di guidare il braccio meccanico della gru che svolgeva il lavoro vero e proprio risparmiando al palombaro fatiche estreme. E’ doveroso ricordare che Alberto Gianni, tra i suoi brevetti in campo marinaresco, vanta anche quello di avere inventato e realizzato per primo l’allora cosiddetta “cassa disazotatrice”, cioè l’antesignana della camera iperbarica attuale, che serve per evitare pericolosissime e letali embolie ai sommozzatori che non possono fare le adeguate compensazioni durante le risalite dalle profondità marine.
Visto e considerato il buon esito del lavoro effettuato sul Washington, la So.Ri.Ma. ottenne ulteriori agevolazioni, quali l’esclusiva per il recupero dei carichi delle navi affondate per cause belliche, purché il relitto si trovasse oltre i 50 metri di profondità e l’esenzione del dazio doganale. In cambio la società di recuperi avrebbe corrisposto il 12% del valore recuperato all’INA.
Dopo i positivi recuperi del Washington e del Lloevli, affondato davanti a Savona, e mentre Arpione e Raffio continuavano il loro lavoro in acque liguri, nell’estate del 1928, lo scenario si spostò in Atlantico.
L’Artiglio venne infatti inviato a Le Palais sull’ isola di Belle- Ile-en-Mer con l‘obiettivo di recuperare il piroscafo belga Elisabethville, che proveniente dal Congo e diretto ad Anversa, era stato silurato in Guascogna il 6 settembre 1917. Il suo prezioso carico, giacente su un fondale di 70 metri, era costituito da 12 tonnellate di avorio in zanne, acciaio ed un involto contenente tredicimila carati di brillanti grezzi che avrebbero dovuto essere custoditi nella cassaforte del comandante della nave, la cosiddetta “bullion room”. Purtroppo gli uomini dell’Artiglio, per una serie di circostanze a loro ignote, non erano a conoscenza che i diamanti non erano custoditi nella cassaforte, bensì in un altro locale, che essi stessi, con il lavoro di demolizione della nave per arrivare alla camera di sicurezza, avevano già distrutto, disperdendone così per sempre il contenuto.
Comunque anche il solo recupero dell’avorio fu ritenuto sufficientemente lucroso ed all’incirca a metà del lavoro, Quaglia, realizzato che i suoi palombari erano semplicemente i migliori al mondo e capaci di compiere lavori ritenuti fino allora impossibili, dispose di lasciare terminare il lavoro al Rostro e ordinò all’Artiglio di spostarsi ancora più a nord e precisamente a Brest, alla ricerca dell’Egypt e del suo famoso tesoro.

Il transatlantico Egypt in servizio sulla rotta Londra - Bombay
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
L’Egypt era una nave lunga 152 metri e larga 16,5 che stazzava 7941 tonnellate, di proprietà della “Peninsular & Oriental Steam Navigation Company”. Si trovava in navigazione sulla rotta da Londra a Bombay con a bordo 44 passeggeri e 294 uomini d’equipaggio, quando la sera del 20 maggio 1922, a causa della fitta nebbia che gravava su quel tratto di navigazione, fu speronato dal piroscafo francese “Seine” nei pressi dell’isola di Ouessant davanti a Brest. Nella collisione, in circa venti minuti, perirono 17 passeggeri e 71 uomini dell’equipaggio.
Oltre che i parenti delle vittime il fatto gettò nella costernazione anche gli assicuratori poiché la nave trasportava un vero e proprio tesoro diretto alla Banca Centrale dell’India. Nella sua “bullion room” erano stivate 119 cassette contenenti 1089 lingotti d’oro, 37 cassette contenenti 164.979 sterline d’oro e 1229 barre d’argento, per un totale di cinque tonnellate e mezzo d’oro e quarantatre d’argento: “Un vero e proprio tesoro!”
Gli assicuratori, sopportato e risarcito l’ingente danno, erano divenuti i proprietari del tesoro sommerso, ereditando il diritto di recupero, ma la cosa non si presentava assolutamente facile.
Nella corsa internazionale al recupero, prima di affidare alla So.Ri.Ma. le ricerche del relitto, altre società di recuperi avevano tentato questa impresa. Nel maggio 1923 tentò la società inglese “Gothenburg Towing & Salvage Company” il cui capitano dirigente Hedback asserì di aver trovato qualcosa, ma il punto fu segnato solamente sulle carte e non in mare mediante boe e così si perse precisione. Sempre nell’estate dello stesso anno una società svedese utilizzò una nave recuperi e due rimorchiatori, ma dopo un paio di mesi di vane ricerche abbandonò. Due anni dopo fu la volta della francese “Union d’Entreprises Sous-Marines” che tentò di rilocalizzare il punto di Hedback, ma inutilmente. L’anno successivo un’altra società francese, con palombari tedeschi, ritenne di aver finalmente ritrovato il punto di Hedback, ma nessun palombaro riuscì a individuare il relitto.
Fu così che il 30 agosto 1928 i Lloyd’s di Londra e tre compagnie minori stipularono un contratto con la So.Ri.Ma. per fare un ulteriore tentativo di recupero del prezioso carico, “unicamente con i propri mezzi, sotto la propria direzione, sopportando responsabilità, rischi e spese” secondo la scrittura. L’accordo prevedeva il 62,5% del valore recuperato per la, So.Ri.Ma. mentre il rimanente 37,5% sarebbe stato per i Lloyd’s e le altre compagnie interessate.
Potè così iniziare la grande avventura ed Artiglio, Rostro e Raffio iniziarono a rastrellare il mare per settimane e mesi alla ricerca del relitto e del tesoro dell’Egypt.
Nonostante i precedenti non invitassero all’ottimismo palombari e marittimi della So.Ri.Ma. non si fecero demoralizzare ed iniziarono il duro lavoro nonostante quel mare fosse noto a tutti i naviganti per la sua perigliosità a causa di alte maree, forti correnti, fitta nebbia, cambiamenti repentini di tempo e soprattutto vento, anche durante la cosiddetta “bella stagione”.
La ricerca, condotta tramite dragaggio del fondo marino, si protrasse dal giugno del 1929 fino all’estate del 1930 quando finalmente il 30 agosto, a due anni esatti dalla firma del contratto con i Lloyd’s, l’Egypt fu rinvenuto dal palombaro Alberto Bargellini su un fondale di 130 metri, praticamente una profondità doppia rispetto a quella massima alla quale erano soliti lavorare i migliori palombari del tempo.

L'Egypt sul fondo: tracciati da David Scott, su precise indicazioni dei palombari, i disegni riprodotti in questa immagine danno un'idea della mole di lavoro eseguita sul relitto. E' visibile, in alto, l'apertura della stanza-valori, su cui pendono la benna e la torretta.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
Il mondo intero e gli esperti scrollarono il capo non credendo assolutamente alla possibilità di quel recupero e soprattutto la Stampa francese ironizzò non poco sulla velleità del tentativo italiano. Ma anche questa ulteriore difficoltà psicologica non scoraggiò più di tanto gli uomini dell’Artiglio che iniziarono un lungo e paziente lavoro di demolizione, con cariche esplosive mirate, di ben quattro ponti navali, per poter raggiungere in verticale la stanza del tesoro che si trovava proprio al centro della nave.
Merita un inciso la vicenda dello scozzese David Scott, distinto e brillante giornalista del “Times”, di stanza nella redazione di Parigi, unico estraneo ammesso sull’Artiglio per tutto il tempo della ricerca del relitto dell’Egypt nonché del recupero del carico. Il suo racconto risulterà illuminante e fondamentale per i posteri che grazie alle sue cronache rivivranno tutte le operazioni quotidiane a bordo della nave recuperi. Il giorno della tragedia, il 7 dicembre 1930, per sua fortuna Scott non era presente sull’Artiglio, ma fu prontissimo a riprendere il suo posto di giornalista non appena la caccia all’oro ricominciò fino all’apoteosi finale. Inviato del giornale londinese durante i quattro anni trascorsi gomito a gomito con i palombari ed i marinai sulla nave, più che un cronista, si rivelò alla lunga un simpatizzante della vita di bordo. Seguì tanto sul primo, quanto sul secondo Artiglio, tutte le fasi di ricerca e recupero dell’oro riportando la sua singolare esperienza in due bellissimi volumi: il primo “Con i marinai dell’Artiglio” Ed. Treves – Milano ed il secondo “L’Artiglio e l’oro dell’Egypt” Ed. Mondadori Milano.

David Scott a bordo dell'Artiglio - Di David Scott - Libro Con i palombari dell'Artiglio - Pubblico dominio, httpscommons.wikimedia.orgwindex.php
Scott divenne amico di tutti, ne descrisse con garbo i tratti più caratteristici e significativi, ne divenne confidente e consigliere raccogliendo i loro pensieri più intimi. Imparò l’italiano, ma anche parole e modi di dire sia liguri che viareggini, tanto che, anni dopo, a vicenda ormai felicemente conclusa, venne in Italia a ritrovare alcuni dei componenti di quel glorioso gruppo.
Col sopraggiungere dell’autunno, non potendo continuare a lavorare sull’Egypt a causa del maltempo, i lavori di demolizione furono sospesi e Artiglio e Rostro, per non perdere tempo e lavoro, si diressero verso sud in una zona sottocosta e più riparata tra l’isolotto di Houat, la costa e la penisola di Quiberon, dove già si trovava il Raffio, per demolire alcuni relitti pericolosi che ostacolavano la navigazione nella Baia di Quiberon.
Il Rostro doveva demolire il relitto del piroscafo Ville d’Angers, carico di rame, sul lato nord del canale d’ingresso a Saint Nazaire, mentre l’Artiglio avrebbe dovuto occuparsi dello smantellamento della nave americana Florence H, affondata il 17 aprile 1918 da un sommergibile tedesco.
Il Florence H era stata una nave adibita al trasporto di munizioni dagli Stati Uniti al fronte alleato in Europa. Ora giaceva su un basso fondale (circa una ventina di metri) ostacolando la navigazione. Nelle sue stive conservava ancora intatte 150 tonnellate di proietti per cannone che aveva imbarcato alla partenza a New York e che doveva scaricare a Saint Nazaire. Per smantellare le strutture del Florence H venivano utilizzate delle cariche esplosive opportunamente posizionate dai palombari che poi venivano ovviamente recuperati prima del brillamento delle mine e dell’allontanamento a distanza di sicurezza da parte dell’Artiglio. Il lavoro, iniziato il 4 ottobre 1930, andò avanti per un paio di mesi con fasi alterne, tempo permettendo.
Ormai il Natale si stava avvicinando ed equipaggi e palombari dopo mesi e mesi di duro lavoro e lontananza dall’Italia erano nervosi e fremevano per tornare a casa presso le proprie famiglie in tempo per le feste natalizie. Per velocizzare il lavoro, Gianni e compagni, accantonato l’iniziale timore che li aveva fatti agire con cautela e presero a familiarizzare progressivamente con il rischio. Da un lato aumentarono il numero e la potenza delle mine, ma, fatto ben più grave, iniziarono altrettanto progressivamente a ridurre la distanza di sicurezza che la situazione imponeva. Pertanto, se ad ottobre stavano a circa un miglio di distanza, al mese di dicembre, complice anche il fatto che con ogni esplosione anche il filo della miccia si scorciava, si ritrovarono a far brillare le mine stando a non più di duecento metri di distanza.
Si giunse così a domenica 7 dicembre, una maledetta domenica.
Il palombaro Bargellini, quel giorno particolarmente felice avendo il giorno prima ricevuto dalla moglie Alfea la foto della figlia appena nata e che non aveva ancora potuto stringere tra le braccia, dopo aver sistemato le cariche, venne recuperato a bordo e l’Artiglio si allontanò di sole poche centinaia di metri prima di dare il contatto all’ultima serie di cariche esplosive.
Domenica 7 dicembre, una maledetta domenica!
Alle ore 14.00 il Rostro, che si trovava a circa quattro miglia di distanza tra le isole di Houat e Hoedic, impegnato nella demolizione del Ville d’Angers, diede il segnale che i suoi palombari erano a bordo e che l’Artiglio poteva pertanto procedere a far brillare l’ultima carica della giornata.
All’improvviso, in luogo della solita esplosione sorda sottomarina, esplose letteralmente il mare. Si sollevò un’onda alta decine e decine di metri che mise a nudo il fondo marino scavandovi una fossa di trecento metri di diametro. L’Artiglio fu scaraventato in aria come una barchetta di carta spezzandosi in due tronconi, il mare divenne nero e ribollì per un’ora, uno spostamento d’aria ed una nuvola di schegge provenienti dal relitto sommerso piovvero a distanza di miglia. Il cielo si oscurò avvolto da una densa nebbia di fumo nero che formò un enorme fungo spettrale. Era esplosa la santabarbara del Florence H il cui carico di bombe era stato molto sottostimato.
In pochi secondi l’Artiglio era scomparso.
L’onda lunga provocata dall’esplosione si infranse contro la chiesetta di Saint Gildas sull’isola di Houat mentre i fedeli assistevano al vespro domenicale. Il capitano Carli che comandava il Rostro, superato il momentaneo disorientamento, diede immediatamente ordine di precipitarsi a tutta forza sul luogo della tragedia, ma ci volle almeno mezz’ora prima che raggiungesse il luogo dell’esplosione. Purtroppo poté recuperare solamente sette superstiti che annaspavano in una cortina di schiuma densa e nera aggrappati a qualche misero relitto.
Ecco l’elenco delle vittime della tragedia dell’Artiglio:
- Giacomo Bertolotto, di Camogli, comandante
- Alberto Gianni, di Viareggio, capo palombaro
- Aristide Franceschi, di Viareggio, palombaro
- Alberto Bargellini, di Viareggio, palombaro
- Luigi de Melgazzi, di Motta Visconti, radiotelegrafista
- Antonio Deiana, di Genova, ingrassatore
- Felice Bresciani, di Civitavecchia, fuochista
- Enrico Tedoldi, di Spezia, fuochista
- Costante Ulivieri, di Cavo, marinaio
- Romualdo Cortopassi, di Viareggio, marinaio
- Maurizio Amoretti, di Imperia, cuoco
- Amerigo Ramelli, di Framura, mozzo
Solo i corpi di tre vittime furono recuperati, quelli dei palombari Gianni, Franceschi e del marinaio Cortopassi. Gli altri rimasero dispersi in mare per sempre nonostante che il giorno dopo e con il mare finalmente limpido i palombari del Rostro, Raffaello Mancini e Mario Raffaelli, si fossero immersi tutto il giorno nella vana ricerca di altri corpi.
Nella tragica esplosione erano scomparsi ben dodici uomini tra i quali il comandante Bertolotto ed i palombari Gianni, Franceschi e Bargellini, che erano considerati i più grandi palombari mai esistiti, praticamente l’elite della So.Ri.Ma. e della palombaristica mondiale.

I palombari dell'Artiglio. Da sinistra Aristide Franceschi, Alberto Gianni e Alberto Bargellini.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
Se il tragico evento gettava nel medesimo abisso di dolore tutti i dipendenti della So.Ri.Ma. a cominciare da Quaglia fino all’ultimo dei gregari, parimenti non veniva meno la tenacia e l’ardore dei propositi.
Solo cinque mesi dopo l’immane sciagura della baia di Quiberon un nuovo “Artiglio” era pronto a prendere il mare dai cantieri di Saint Nazaire e sulla sua fiancata a prora era stata sistemata pure la vecchia targa in bronzo recuperata dai rottami del vecchio “Artiglio” saltato in aria, la quale recava il motto “Memento audere semper”.
Proprio in Bretagna era stato acquistato un peschereccio di nome Mauretanie che stazzava 350 tonnellate. Durante i lavori di adeguamento nei cantieri Penhoet di Saint Nazaire, era stato recuperato dal relitto del vecchio Artiglio tutto ciò che poteva essere ancora utile al nuovo bastimento: torretta, scafandri, articolati, bighi, piatti elettromagnetici, boe, ancore, fari da grandi profondità, ect.
La nuova nave recuperi, contrariamente a quanto la logica avrebbe imposto, non si chiamò volutamente Artiglio II, ma proprio a voler sottolineare la estrema continuità con il primo, fu battezzata con lo stesso nome quasi non fosse accaduto nulla.
Il nuovo Artiglio fu visto per la prima volta all’opera il giorno di Pasqua del 1931 ed il 4 maggio il vecchio trowler lasciò Saint Nazaire diretto a Brest. Il nuovo equipaggio, 25 unità, era composto da uomini del Rostro, compreso il capitano Carli, insieme ai superstiti della tragedia. Capo palombaro era stato promosso Mario Raffaelli, uomo di grande valore, serio e riflessivo che già aveva lavorato con Gianni negli anni precedenti. Primo palombaro era Raffaello Mancini, secondo e terzo erano rispettivamente Fortunato Sodini e Giovanni Lenci.
Due giorni dopo, il 6 maggio, purtroppo un’altra funerea sciagura colpì la So.Ri.Ma. e i suoi uomini.
Il Raffio, mentre era impegnato al recupero di un carico dal relitto del piroscafo francese Jeanne Marie, si capovolse a causa di un aggrovigliamento delle boe ed andò a picco in pochi secondi nella Manica vicino all’isola di Sark, trascinando con sé il fuochista Angelo Tortarolo di Loano che non era riuscito a guadagnare la coperta in tempo ed a gettarsi in mare prima dell’affondamento. Il Raffio in quel momento, oltre all’usuale equipaggio, recava a bordo i nuovi palombari che avrebbero dovuto prendere posizione sull’Artiglio e solo per puro miracolo non si verificò una nuova tragedia collettiva. Per fortuna dei presenti era già pronta in mare una lancia di salvataggio sulla quale presero posto tutti gli occupanti della nave tranne il fuochista che al momento della disgrazia era in cuccetta a dormire.
Il commendator Quaglia, come già con l’Artiglio, sostituì prontamente l’imbarcazione perduta con un’altra che prese automaticamente il nome di quella andata a fondo. Se anche questa volta il destino fosse stato crudele come la precedente la So.Ri.Ma. non avrebbe certamente più avuto un seguito.
Dopo lo scampato pericolo, il 24 maggio l’Artiglio lasciò Brest per ricominciare la ricerca del relitto dell’Egypt. Tutti si rimboccarono le maniche e la lotta contro il mare, le correnti, le nebbie, le maree, il freddo, il vento, la pioggia ricominciò. Il relitto venne finalmente rintracciato il 6 giugno. Per poter raggiungere la fatidica bullion room occorse demolire ben quattro ponti dell’Egypt. Ben cinque tonnellate di tritolo ad alto potenziale, fatte arrivare appositamente dall’Italia, furono fatte brillare sollevando dall’Egypt circa 500 mq. di lamiere per un totale di 250 tonnellate di materiale ferroso.
Durante questa fase emerse prepotentemente la figura di Mario Raffaelli che, divenuto giocoforza capo palombaro ed uscito dal cono d’ombra dei colleghi scomparsi, dimostrò a propria volta una personalità eccezionale e soprattutto coi fatti che i rincalzi non erano da meno dei titolari.
Il 2 dicembre, alla fine della terza stagione in Atlantico, la maggior parte dei ponti dell’Egypt erano stati tagliati e rimossi. Alla ripresa dei lavori, nella primavera del maggio 1932, il soffitto della bullion room finalmente era stato rimosso. Entrò allora in azione una speciale benna a polipo adatta a recuperare lingotti e monete costruita, su indicazione della So.Ri.Ma., dalla “Demag Aktiengesellchaft” di Duisburg. Quando la benna venne calata per la prima volta nella camera del tesoro, rovesciò sul ponte migliaia di cartucce da caccia insieme ad alcuni fucili che sul calcio recavano una placchetta d’oro con incise le iniziali M. B. S. sormontate da una corona principesca. Queste armi non erano state registrate ufficialmente, ma si poté ugualmente accertare che fucili e cartucce erano destinati al Marajah di Patjala, Mohinder Bahadur Singh (M.B.S.), per la caccia alla tigre!
Nelle successive bennate riemersero grandi pezze di seta dai colori sgargianti e soprattutto pacchi di banconote da 5, 10 e 100 rupie, commissionate a Londra per lo Stato indiano di Hiderabad, di nessun valore in quanto mancanti ancora della firma del governatore. Il ritrovamento di queste tipologie di merci, oltretutto non registrate nei documenti di bordo, fece dubitare a più di uno che qualcosa non fosse andato per il verso giusto, in particolar modo durante la demolizione. Ma Quaglia mantenne sempre una fede incrollabile sull’operato dei propri uomini e sulla riuscita dell’impresa ed il successo non tardò ad arrivare.
Finalmente il 22 giugno 1932 alle ore 11.30, dopo quattro anni di lavori, di sacrifici, di fatica, di imprecazioni, di freddo e purtroppo anche di sangue e lutti, le prime due sterline pescate dalla gru emersero dall’abisso. La bennata successiva depose sul ponte due lucenti mattoni gialli: “Lingotti, lingotti!! Oro, Oro!!” furono l’urlo comune in un delirio da trionfo.

Esultanza dell'equipaggio al ritrovamento dell'oro.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro

Il Comm. Quaglia accanto ai palombari del nuovo Artiglio. Mario Raffaeli in piedi a sinistra.
Seduti da sinistra: Raffaello Mancini, Giovanni Lenci e Fortnato Sodini.
Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro
Il primo a congratularsi con gli uomini dell’Artiglio per il successo conseguito fu proprio Benito Mussolini, seguito da tantissime autorità politiche ed economiche e da innumerevoli giornalisti di tutto il mondo inviati per descrivere l’eccezionale ritrovamento, anche perché da tempo il recupero dell’oro dell’Egypt era diventato un argomento di rilevanza mondiale. Tre giorni dopo, il 25 giugno 1932, l’Artiglio lasciò le boe e si diresse verso Plymouth per consegnare il primo carico d’oro recuperato.
Sia il Corriere della Sera che il Times diedero ampio spazio in prima pagina all’avvenimento sull’altra sponda della Manica. All’atto dell’ingresso in porto a Plymouth, per rendere omaggio ai trionfatori, salirono a bordo: Peter Sandberg, promotore dell’opera di recupero; il conte Buraggi, rappresentante a Londra della So.Ri.Ma.; Sir Percy Mackinnon, presidente dei Lloyd’s; Sir Joseph Lowrey, presidente della “Salvage Association”. In mezzo a queste ed altre autorità salì pure anche il primo ufficiale della Dogana del porto di Plymouth il quale, senza tanti preamboli e nell’ incredulità generale informò il capitano Carli che il carico d’oro doveva essere immediatamente sequestrato per ordine del Maresciallo dell’Ammiragliato. Gli illustri ospiti e le altre persone presenti non riuscivano a capacitarsi di quanto stesse accadendo. L’ordinanza di sequestro era stata emanata in conseguenza di una istanza presentata dalla “Societè Nouvelle de Pescherie a Vapeur” di Nantes, una compagnia di pesca francese, che nel 1926 aveva tentato di rintracciare il relitto dell’Egypt, e che adesso sembrava reclamasse qualcosa dalla So.Ri.Ma. Fortunatamente nell’immediato pomeriggio giunse da Londra la notizia che il sequestro era stato tolto, dopodiché l’Artiglio ripartì immediatamente verso Brest.
Si arrivò così al 9 luglio e l’Artiglio si apprestava nuovamente a tornare sulle boe per riprendere il recupero dell’oro e dell’argento dall’Egypt, quando improvvisamente vi fu una chiamata da parte della Marina Militare francese.
Cosa era accaduto? Tre giorni prima e precisamente il 6 luglio, il sommergibile francese Prometheè era affondato presso Capo Levy al largo di Cherbourg. Si trattava di un prototipo sperimentale, colato a picco in pochi secondi trascinando seco tutti gli uomini dell’equipaggio ad eccezione di sette marinai che si trovavano in coperta e che pertanto erano riusciti a salvarsi gettandosi in mare. Gli altri membri dell’equipaggio erano rimasti intrappolati all’interno dello scafo che ora si trovava adagiato su un fondale a ben 75 metri di profondità.
Il comandante il porto di Brest, che negli ultimi quattro anni non aveva mai dato segno di essersi accorto della modesta nave italiana attraccata al molo, improvvisamente si ricordò di quella imbarcazione e soprattutto dei suoi lavoranti a bordo proprio quando avvenne la sciagura del Prometheè. Anche i palombari francesi usavano gli scafandri Neufeldt & Kunke, ma nonostante febbrili e ripetuti tentativi, non erano riusciti a raggiungere il fondo ed allorquando il Ministro della Marina francese Leygues chiamò, chiedendo aiuto, l’Artiglio ed il Rostro partirono immediatamente per il luogo della sciagura.
Molte navi da guerra erano sul luogo del naufragio ed avevano fissato le boe per individuare meglio il sommergibile affondato.
Alle 14.30 di domenica 10 luglio l’Artiglio era in mezzo al poligono di boe ed ormeggiato. Raffaello Mancini chiuso nello scafandro rigido e collegato con Mario Raffaelli, si immerse con lo scopo di battere contro lo scafo del sommergibile con un grosso martello per accertarsi se provenisse qualche risposta dall’interno. Purtroppo non udì alcun segno di vita, così come non captarono nulla i sensibili misuratori di suono dell’Artiglio. Mancini, infaticabile nel suo enorme slancio di generosità, nell’occasione aveva battuto il record mondiale di durata dentro uno scafandro in tela gommata rimanendo sott’acqua sei ore consecutive!
Il giorno dopo scese anche Donato Sodini del Rostro e poi ancora Giovanni Lenci. Ci provò ancora un palombaro francese di Tolone, ma dovette riemergere subito poiché non era in grado di resistere alla enorme pressione.
Dopo una riunione nel gabinetto dell’Ammiraglio comandante la Prefettura Marittima di Cherbourg, presente il Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Durand Veil, molti ufficiali del genio navale, nonché i due capitani Carli e D’Arcadia, comandanti rispettivamente dell’Artiglio e del Rostro, si arrivò alla conclusione che per i 72 occupanti del Prometheè non c’era più nulla da fare. Probabilmente il sommergibile era andato a fondo in pochi secondi per una apertura accidentale delle valvole per l’immersione. In seguito, durante verifiche in arsenale effettuate su altri sommergibili simili, si arrivò alla conclusione che molto probabilmente il natante era affondato coi suoi occupanti proprio per un difetto delle valvole per l’immersione.
In una lettera al commendator Giovanni Quaglia, il Ministro della Marina francese G. Leygues, volle porgere la riconoscenza della Francia e della Marina agli uomini dell’Artiglio e del Rostro per il pronto, energico e disinteressato aiuto prestato con grande spirito di abnegazione nei confronti dello sventurato Prometheè. Nella stessa lettera il Ministro annunciò di aver accordato al commendator Quaglia il titolo di Cavaliere della Legion d’Onore. Inoltre altre onorificenze furono conferite ai comandanti ed ai palombari dell’Artiglio e del Rostro.
Ecco il testo della lettera:
Paris, le 8 Aout 1932
Le Ministre de la Marine a Monsieur le Commandeur Quaglia President de la Società “So.Ri.Ma.”
Monsieur le Commandeur, Il m’est agreable de vous annoncier que, desireux de vous temoigner la reconnessaince du Pays et de la Marine pour le concours si energique et si desintèressè que vous m’avez pretè dans les travaux de recherche du sous-marin Prometheè , j’ai propose è au Gouvernement de vous nommer Chevalier de la Legion d’Honneur et d’accorder:
la Croix d’Officier du Merite Maritime à M. Raffaelli Mario, Directeur Technique&Chef Plongeur;
la Croix de Chevalier du Merite Maritime à MM. Carli Giovanni, Commandant l’Artiglio e D’Arcadia Emanuele, Commandant le Rostro;
la Medaille d’Honneur des Affaires Etrangeres à MM. Mancini Raffaello, plongeur de l’Artiglio, Lenci Giovanni, plongeur de l’Artiglio, Albavera Cesare, chef mecanicien de l’Artiglio, Del Pistoia Emilio, matelot de l’Artiglio, Sodini Donato, plongeur du Rostro, Bonuccelli Catone, plongeur du Rostro, Terzi Giacomo, chef mecanicien du Rostro.
Ces propositions ont etè approuvèes.
Je vous addresse mes felicitations personnelles et celles de la Marine Francaise et je vous re nouvelle l’expression de notre gratitude pour votre aide fraternelle.Veuillez agrèer, Monsieur le Commandeur , l’assurance de ma haute consideration et de mes sentiments de tres vive sympathie. Le Ministre de la Marine G. LEYGUES
Conclusa la parentesi “Prometheè”, nei giorni seguenti l’Artiglio ritornò a lavorare sull’Egypt utilizzando una particolare “macchina succhiatrice” fatta realizzare appositamente su indicazioni di Mario Raffaelli.
Questo nuovo apparecchio a forma di siluro velocizzò enormemente il lavoro e sterline d’oro e lingotti, tanto d’oro quanto d’argento, furono succhiati dagli abissi e vomitati sulla tolda della nave con relativa facilità.
Tutto ciò andò avanti fino a metà ottobre quando l’Artiglio, nonostante un mare spaventoso, si avviò nuovamente verso la Manica e per un giorno intero, tutti coloro che ebbero la sventura di trovarsi a bordo in quel frangente, pensarono di fare la fine dell’Egypt.
Come la prima volta, a Plymouth vennero festosamente accolti dai rappresentanti dei Lloyd’s e della National Salvage Association, con la presenza di giornalisti, fotografi, inviati di agenzie e la solita folla di curiosi. I giornalisti americani giunsero addirittura a toccare i muscoli dei palombari italiani per verificare con le proprie mani se avessero di fronte uomini normali oppure dei particolari superuomini!
L’Artiglio tornò a Brest e per quell’anno le operazioni furono considerate concluse.
Ricominciarono a metà maggio dell’anno successivo. Tranne Giovanni Lenci che era passato capo palombaro sull’Arpione, il lavoro subacqueo era ancora affidato a Raffaello Mancini e Fortunato Sodini sotto la guida di Mario Raffaelli. La caccia all’oro iniziò a giugno e si protrasse di nuovo fino alla fine di ottobre.
Anche il 1934 fu nuovamente speso dall’Artiglio a recuperare altro oro. A stagione ultimata l’oro issato a bordo fu stimato in circa 7 tonnellate, mentre 40 tonnellate furono quello dell’argento, pertanto molto di più di quanto effettivamente assicurato dalla National Salvage Association e dai Lloyd’s di Londra.
L’Artiglio tornò saltuariamente sul relitto dell’Egypt fino al 1939, cioè fino a quando la “miniera d’oro” non smise di dare frutti.
Nel 1935 Raffaello Mancini passò capopalombaro sul Raffio e Fortunato Sodini divenne capopalombaro dello stesso Artiglio. Mario Raffaelli fece invece carriera passando dai natanti agli uffici, in quanto nominato dal Comm. Quaglia direttore di tutta la flotta So.Ri.Ma..
La vicenda dell’Egypt fu solamente la punta dell’iceberg delle operazioni di recupero della flotta So.Ri.Ma.. Negli anni ’30 e successivi le sue navi lavorarono senza un attimo di sosta su innumerevoli fronti. Altri tesori sommersi furono rappresentati da carichi di rame, alluminio, acciaio, zinco, molibdeno, tungsteno, cromo; metalli certamente non nobili, ma molto appetiti sul mercato delle materie prime. In questo periodo vennero recuperati i carichi di oltre 50 navi naufragate sia nel Mediterraneo che nell’Atlantico.
L’arrivo del secondo conflitto mondiale vide la flottiglia della So.Ri.Ma. venire ripetutamente in aiuto di unità militari e mercantili danneggiate a causa di azioni belliche. Soprattutto nell’Egeo la loro presenza fu quasi continua. Nelle acque greche soccorsero il caccia Granatiere, le torpediniere Climene, Procione e Sagittario ed i mercantili Città di Marsala, Dubac, Esperos, Famiglia Meriga, Kriti, Luciano Manara, Maddalena G., Maiotis, Messarya Nomikos, Monviso, Monstella, Nikolas Nomikos, Nicolau Georgios, Nino Bixio, Pozarica, Unione, Valfiorita. A Tripoli assicurarono il rigalleggiamento dei mercantili Città di Bari ed Eritrea.
Il conflitto, tuttavia, alla lunga, si rivelò fatale per tutte le unità della So.Ri.Ma..
La serie degli affondamenti dei suoi natanti iniziò il 16 giugno 1940. neanche una settimana dopo l’entrata in guerra dell’Italia, con il Rastrello ormeggiato alla diga foranea nel porto di Napoli: un siluro sganciato per errore da una unità militare ormeggiata in banchina, lo centrò irrimediabilmente causandone l’immediato affondamento.
Fortunatamente in quel momento la nave era praticamente deserta; tre uomini vennero recuperati in acqua senza che nemmeno conoscessero la reale causa del sinistro! Il Rampino venne invece silurato da un sommergibile inglese il 17 gennaio 1942 mentre era in Tunisia. Stessa sorte subisce il Rostro che il 17 settembre del medesimo anno venne cannoneggiato e silurato sempre da un sommergibile nemico nel golfo della Sirte. L’Arpione si autoaffondò nel porto di Trieste l’8 settembre 1943, e successivamente recuperato, complice un destino ingrato, affondò nuovamente a Fiume il 5 novembre 1944. Il Raffio venne minato e fatto colare a picco dai tedeschi nel porto di Genova il 24 aprile 1945, giorno in cui il glorioso Artiglio si autoaffonda nel porto di Oneglia. Un’ecatombe! Totale fu quindi il tributo al conflitto da parte della So.Ri.Ma..
Al contrario di quanto ci si poteva attendere, il dinamismo di Quaglia non si era affatto spento. Anzi con la fine della guerra, un po’ come avvenuto un quarto di secolo prima, prospettandosi urgenti operazioni di recupero e sgombero dei relitti per rendere agibili i porti e rade di mezza Europa, l’Artiglio fu riportato a galla e trainato a Genova per le opportune riparazioni e così il Raffio.
Il 6 ottobre 1946 fu una data storica per la So.Ri.Ma.. L’Artiglio rientrò nel porto di Oneglia finalmente completamente risanato dalle ferite della guerra, agli ordini del comandante Giobatta Dulbecco che aveva già comandato il Rastrello. Rispetto al passato la nave presentava una novità operativa: tre verricelli a prua ed a poppa in grado di manovrare tre cavi contemporaneamente. La nave era pronta per una campagna in Sierra Leone. Sino al 1948 in due campagne operative l’Artiglio davanti a Freetown recuperò il carico dei piroscafi Mokambo ed Empire Arthur ed in collaborazione con il Raffio anche il carico del City of Birmingham.
Pochi anni dopo la fine della guerra altre navi furono acquistate per rimpiazzare Rostro, Raffio e Rampino e vennero ribattezzate allo stesso modo delle precedenti quasi a voler sottolineare che il tempo si era fermato e nulla era cambiato. Insomma la flotta venne ricostituita più bella ed attrezzata che prima del conflitto; ne è un esempio l’ultima nave arrivata in società, lo Scalpay, adibita solamente alla ricerca dei relitti, attrezzata con scandaglio e radar di posizione, il massimo per quell’epoca.
Sono di nuovo anni di successi per recuperi effettuati un po’ dappertutto, soprattutto nell’Atlantico. Forse l’impresa più prestigiosa di quest’ultimo periodo fu quella portata a termine dal Rostro nel 1953 davanti a Brest col recupero del carico del Flying Enterprise, il cui affondamento aveva attirato l’attenzione mondiale come già avvenuto a suo tempo per l’Egypt. Durante l’estate del 1953 gli uomini del Rostro riuscirono a demolire il relitto e dalle stive della neve tornarono alla luce grossi pacchi di banconote inglesi ed americane assieme ad azioni per il valore di decine di milioni di euro attuali e perfino preziose opere d’arte sotto forma di quadri di Tiepolo, Van Dick e Rubens. Il materiale che tuttavia destò maggiori interrogativi risultò un insolito e grosso carico di zirconia, elemento prezioso per la costruzione di reattori nucleari. Questo fatto lascerà per molto tempo un alone di mistero sulla provenienza e sullo scopo al quale era destinato tale materiale.
La So.Ri.Ma. era oramai divenuta una società floridissima e di successo a tal punto che poteva permettersi anche di fare filantropia o meglio di effettuare delle operazioni gratuite solo ed unicamente per amore della scienza e della cultura. Quando il Prof. Nino Lamboglia, fondatore dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri nel 1948 contattò l’Avv. Giovanni Quaglia, Presidente ed Amministratore Delegato della So.Ri.Ma. per valutare se le sue navi recupero possano essere utili ed adatte al recupero di una nave romana giacente sul fondo marino di fronte ad Albenga, il patron espresse un immediato e disinteressato entusiasmo alla proposta di mettere il suo Artiglio al servizio della scienza archeologica.
L’iniziativa prese forma concreta soltanto un anno dopo quando venne sottoscritto un concordato tra Comune di Albenga, Ministero della Pubblica Istruzione, Soprintendenza alle Antichità della Liguria e Capitaneria di Porto di Savona. La So.Ri.Ma. si impegnava alle operazioni di recupero della nave romana e del suo contenuto a titolo gratuito.
L’8 febbraio 1950 l’Artiglio arrivò nelle acque prospicienti l’antica foce del fiume Centa con il suo carico di personale espertissimo e di mezzi tecnici collaudati da una lunga esperienza nello strappare carichi preziosi dal fondo del mare. Il 9 febbraio furono issate a bordo già le prime anfore e nel giro di pochi giorni vennero recuperate altre centinaia di anfore. Oltre alle anfore furono recuperati altri oggetti metallici in dotazione alla nave ed ai suoi occupanti. Al 21 di febbraio le anfore recuperate ammontavano già a più di un migliaio. Lo scafo venne rispettato per quanto possibile ed un suo eventuale recupero venne rimandato a data da destinarsi, cosa che, per altro, fino ad oggi non è mai stata attuata.
Il Prof. Nino Lamboglia e la So.Ri.Ma. agendo di conserva, avevano appena aperto un nuovo intrigante capitolo in prima mondiale: quello dell’archeosubacquea ovvero il recupero di reperti archeologici dai fondali marini. Anche in questo frangente, come accaduto in precedenza per la vicenda dell’Egypt, sia la Stampa italiana che quella internazionale diedero molta risonanza al fatto, dato che si trattava di una prima assoluta a livello mondiale.
L’8 dicembre 1955 si chiudeva la parabola terrena dell’Avvocato, Cavaliere di Gran Croce della Corona d’Italia, Commendatore dei Santi Maurizio e Lazzaro, Conte Giovanni Quaglia.
Con la sua morte iniziò a morire lentamente anche la società che per un trentennio era stata la sua personale “creatura”. La So.Ri.Ma. sopravvisse infatti in mano ai suoi soci ancora per quasi un quinquennio. Poi, complici sia il cambiamento dei tempi, sia la mancanza di un leader vero e proprio con idee chiare, quale era stato il suo padre- padrone fondatore, e che soprattutto sapesse evolvere ed adattare la società alle nuove realtà del tempo, chiuse nel 1960 per sempre i battenti.
Con la sua liquidazione praticamente terminò l’era romantica dei recuperi sottomarini che aveva affascinato ed entusiasmato la gente di mare e la gente comune di buona parte del mondo.






